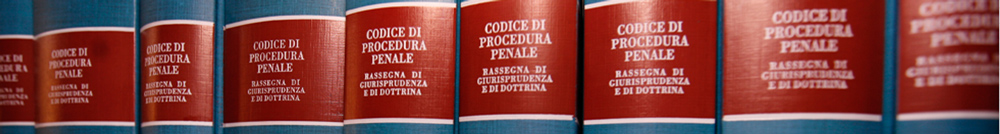Penale
Per la Cassazione la strage di piazza Fontana è da addebitare a Fereda e Ventura, anche se non pià processabili.
Per la Cassazione
la strage di piazza Fontana è da addebitare a Fereda e Ventura, anche se
non più processabili.
Cassazione – Sezione seconda
penale(up) – sentenza 3 maggio-10 giugno 2005, n. 21998
Presidente
Morelli – relatore Macchia
Ricorrente Tringali ed altri
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 12 marzo 2004. la Corte di assise di appello di Milano, in riforma della
sentenza emessa il 30 giugno 2001 dalla Corte di assise della medesima città,
con la quale, fra l’altro, Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo e Rognoni Giancarlo
erano stati dichiarati colpevoli del reato di strage continuata loro ascritto e
condannati
alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tre anni, e
Tringali Stefano era stato dichiarato responsabile del delitto di
favoreggiamento personale al medesimo contestato e condannato alla pena di anni
tre di reclusione, ha assolto Maggi e Zorzi dalla imputazione loro ascritta,
per non aver commesso il fatto, a norma dell’articolo 530, comma 2, Cpp; ha
assolto Rognoni dalla imputazione al medesimo ascritta per non aver commesso il
fatto ed ha ridotto la pena inflitta a Tringali ad anni uno di reclusione.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il
procuratore generale della Repubblica preso la Corte di appello di Milano; la
Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell’interno,
rappresentati e difesi dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano; il
Comune di Milano, rappresentato e difeso dall’avv. Corso Bovio; la Provincia di
Lodi, in persona del Presidente pro-tempore, e la Provincia di Milano, in
persona del Presidente pro-tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Federico
Sinicato, ricorrente anche per le parti civili Luigi Passera, Eugenia
Garavaglia, Clementina Gerli, Annamaria Scaglia, Lucia Valè, Francesca Dendena,
Alessandro Perego, Annamaria Maiocchi, Paolo Silva, Giorgio Silva, Giovanni
Gaiani, Mario Meloni, Giuseppina Amoldi e Carlo Alfredo Maria Amoldi; l’avv.
Caterina Malavenda, nell’interesse delle parti civili Gabriella China e Silvana
China; nonchè il difensore di Tringali Stefano.
Nel ricorso proposto dal
procuratore generale, si censura la sentenza impugnata per essere la stessa
viziata da un duplice errore logico: da un lato, infatti, la disamina del
materiale probatorio sarebbe stata condotta in forza di un procedimento logico
di parcellizzazione delle varie acquisizioni, al quale
non sarebbe seguita una ricomposizione unitaria delle singole acquisizioni;
sotto altro profilo, la pronuncia avrebbe omesso di esaminare tutti gli
elementi di prova versati in atti secondo un criterio di concatenazione logica,
così compromettendo la‑ coerenza stessa delle conclusioni valutative. In
sintesi ‑
deduce il ricorrente ‑ la tesi dei giudici a quibus è
la seguente. La responsabilità della strage di Piazza Fontana è dì Freda e
Ventura, anche se assolti nei procedimenti a suo tempo celebratisi a loro
carico; tuttavia, non sarebbe dimostrata la collaborazione del gruppo
ordinovista di Mestre e Venezia, cui appartenevano
Maggi e Zorzi. Quanto in contrario emergerebbe dalle dichiarazioni dei
principali collaboratori, intranci ad Ordine Nuovo, Carlo Digilio e Martino
Siciliano, non sarebbe sufficiente a dimostrare un rapporto organico e
qualificato con il gruppo padovano, per la scarsa attendìbilità intrinseca di
Digilio e la mancanza di riscontri in ordine ai due
principali episodi dal medesimo descritti, mentre, pur qualificandosi come
attendibili le dichiarazioni del Siciliano, il suo narrato non riguarderebbe in
modo specifico la strage. Per giungere a tali conclusioni ‑
sottolinea ancora il ricorrente ‑
la corte territoriale non avrebbe esaminato tutte le prove a sua disposizione e
sarebbe entrata in contraddizione con sè stessa, nella parte in cui non ha
spiegato le ragioni in forza delle quali ha confermato la responsabilità del
Digilio ‑
per il quale espressamente ha negato l’effetto estensivo della pronuncia
assolutoria ‑
trascurando di valutare le precedenti sentenze su Ordine Nuovo, pure acquisite
agli atti. Da qui, la manifesta illogicità della motivazione. Si deduce, poi,
vizio di mancanza di motivazione, in ordine a tutti i
segnalati punti qualificanti sui quali i giudici dell’appello si sarebbero
fondati per giungere a conclusioni antitetiche a quelle cui era pervenuta la
sentenza di primo grado. Il ricorrente lamenta, infatti, la mancata disamina,
da parte deì giudici a quibus, di tutta una serie di importanti
emergenze probatorie, già consacrate in varie sentenze acquisite agli atti del
procedimento. Fra queste, in particolare, la sentenza della Corte di assise di appello di Venezia dell’8 novembre 1991, con la
relativa individuazione del ruolo di Maggi, Digilio e Zorzi, e della
configurazione come “gruppo unitario”, sin dal 1984, delle varie cellule
ordinoviste dei Triveneto; la sentenza relativa alla strage di Peteano; quella
del Tribunale di Padova del 1972, che aveva condannato Zorzi per detenzione di
armi da guerra ed esplosivi per fatti del novembre 1969; le sentenze delle
Corti di assise di appello di Catanzaro e Bari, con le quali Freda e Ventura erano
stati ritenuti responsabili degli attentati commessi nel 1969 a Padova, Torino,
Milano e Roma e di dieci degli attentati commessi sui treni. La sentenza
impugnata avrebbe omesso di valutare tali elementi in un quadro unitario,
erroneamente isolando dal contesto il semplice dato
cronologico dei rapporti tra cellula mestrina‑veneziana e cellula padovana.
Attraverso tale delibazione atomistíca dei dati processuali, i giudici
dell’appello avrebbero svilito i riscontri ‑ desumibili da quelle pronunce ‑
che si potevano trarre rispetto alle dichiarazioni di Siciliano: dichiarazioni,
per di più ‑
soggiunge il ricorrente ‑esaminate solo in parte, come è
dimostrato dalle valutazioni relative agli incontri programmatici cui la stessa
fonte ebbe a partecipare e che sono testimoniati dalle dichiarazioni rese nel
corso di un interrogatorio richiamato a pag. 503 e segg. della sentenza di
primo grado, e che, invece, i giudici dell’appello hanno esaminato solo in
parte, al fine di avallare una tesi che si definisce preconcetta. Omissione,
quella censurata, che si deduce essere riscontrabile anche in
riferimento alle dichiarazioni rese da Ruggero Pan e da Giancarlo Vianello ed
in rapporto a varie altre emergenze processuali, analiticamente passate in
rassegna. Si lamenta, poi, manifesta illogicità della motivazione, con
specifico riferimento alla omessa valutazione delle
perizie psichiatriche concernenti la capacità espositiva del Digilio; la omessa
valutazione di ímportanti elementi di riscontro e la alterazione delle dichiarazioni
rese dallo stesso DIGILIO, rispetto alle quali si reputa del tutto superflua e
contraddittoria la lunghissima, disamina concernente la pretesa appartenenza
della fonte alla rete di sicurezza americana. Si sottolineano,
in particolare per ciò che attiene all’omesso esame di elementi atti a fungere
da riscontro alle dichiarazioni del DIGILIO, numerose acquisizioni che
smentirebbero ‑
sul piano soggettivo ed oggettivo ‑ l’intera gamma delle
considerazioni svolte dai giudici a quibus in merito alla centrale vicenda
relativa agli accessi effettuati presso il casolare di Paese. Le dìchiarazioní
di DIGILIO sarebbero poi state alterate nella parte in cui la sentenza
impugnata ha ritenuto che le affermazioni di allertamento
per l’ambiente rivolte da MAGGI ‑ in prevenzione delle
conseguenze che sarebbero scaturite da prossimi “fattacci” ‑fossero
avvenute nel corso di un incontro successivo a quello avuto con ZORZI nei presi
di Canal Salso: una successione temporale ‑ deduce il ricorrente ‑
che, invece, non sarebbe stata mai attestata dal DIGILIO. A proposito, poi,
dell’incontro avvenuto con ZORZI in Canal Salso il 7‑8 dicembre 1969,
oltre a censurarsi le deduzioni di inattendibilità
intrinseca delle dichiarazioni rese al riguardo dal DIGILIO da parte dei
giudici a quibus, si sottolinea come, sull’aspetto centrale della vicenda
relativa all’esplosivo visto dalla fonte nella autovettura del MAGGI, la
sentenza impugnata abbia ritenuto non credibile l’assunto dei DIGILIO, secondo
i quale ‑
per come dettogli da ZORZI ‑ si sarebbe trattato di esplosivo ammonal, in forza
di un dato non esistente agli atti: e cioè che del vecchio furto di ammonal
commesso dallo ZORZI e riferito dal SICILIANO, il DIGILIO fosse stato
inopportunamente messo a conoscenza nel corso della sua escussíone avvenuta ad
opera dei carabinieri dei R.O.S. il 16 marzo 1995, e cioè assai prima di quando
aveva cominciato a parlare della vicenda di Canal Salso. Ebbene, deduce il
ricorrente, nel relativo verbale non risulta che il furto dell’esplosivo fosse avvenuto ad
opera dello ZORZI, nè che ZORZI avesse poi conservato quell’esplosivo; sicchè,
la deduzione di inattendibilità del DIGILIO sarebbe stata desunta dai giudici
dell’appello o da un erroneo apprezzamento delle risultanze, o da documenti non
acquisiti e non acquisibíli. Lo stesso è a dirsi ‑ conclude
sul punto il ricorrente ‑ a proposito della affermazione secondo la quale gli
interrogatori del DIGILIO sarebbero stati intervallati da colloqui
investigativi, che avrebbero addirittura costituito la traccia dei primi. Nel
quinto motivo si prospetta mancanza di motivazione per omessa disamina di una
prova decisiva. A proposito dell’esplosivo visto dal DIGILIO nell’incontro di
Canal Salso, infatti, la sentenza impugnata avrebbe trascurato
il fatto che il DIGILIO aveva riferito che nel bagagliaio della FIAT
1100 vi era anche una borsa sportiva, evidentemente collegata al restante
materiale da trasportare: riferimento, dunque, coerente con quanto la sentenza
di primo grado aveva affermato circa la compatibilità ‑ esclusa dai
secondi giudici ‑
dell’esplosivo indicato dal DIGILIO con quella utilizzato per gli attentati.
Evenienza che il ricorrente ritiene desumibile anche dalle varie perizie, ivi
compresa quella del consulente tecnico Berry, che i giudici dell’appello
avrebbero invece evocato a sostegno della tesi della incompatibilità.
La sentenza impugnata avrebbe poi compiuto un altro errore di valutazione,
omettendo di apprezzare, secondo i criteri sanciti dall’articolo 192 Cpp, il
risalto probatorio da annettere all’alibi falso fornito da ZORZI in ordine alla sua pretesa presenza a Napoli nel dicembre
1969. Nel sesto motivo si lamenta manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni di
Martino SICILIANO. Anche con riferimento alle dichiarazioni rese da tale fonte ‑
del quale si sottolinea la posizione non di coimputato
ma di teste assistito ‑ la Corte dell’appello avrebbe omesso di valutare le
prove atte a fungere da elemento di riscontro. Si censurano, in particolare, le
valutazioni poste a base della ricostruzione della cosiddetta cena del
tacchino, svoltasi con VIANELLO e ZORZI, e si puntualizzano le omissioni e le
aporie che sul piano logico infirmerebbero la coerenza degli apprezzamenti al
riguardo svolti nella impugnata sentenza. Analoghe
doglianze vengono formulate anche in riferimento
all’incontro che il SICILIANO avrebbe avuto agli inizi del 1970 con l’amico
GRADARI, indebitamente svalutato dai giudici a quibus, ed all’attentato
avvenuto presso i magazzini COIN di Venezia nel marzo 1970. A proposito di
quest’ultimo, infatti, la sentenza avrebbe omesso di valutare, da un lato, i
risultati di una intercettazione relativa ad uno degli
autori dell’attentato, nella quale quest’ultimo significativamente asseriva che
“se parlo di COIN comincia tutto”; e, dall’altro, che la gelignite usata per
quella azione era compatibile con quella usata per gli attentati di Trieste e
Gorizia, secondo l’assunto di SICILIANO, posto che i giudici a quibus avrebbero
erroneamente fondato il diverso giudizio confondendo la ricostruzione di quella
fonte con quanto invece asserito dal DIGILIO circa l’esplosivo nella
disponibilità dello ZORZI. Il tutto con evidenti riflessi in tema di
collegamenti con i fatti di Piazza Fontana, considerato che ‑
ha sottolineato il ricorrente ‑ anche in questa
occasione era stata impiegata proprio una sostanza ‑ gelignite ‑
dello stesso tipo di quella impiegata per quegli attentati. Nel settimo motivo
si denuncia vizio di motivazione in riferimento a
varie emergenze atte a denotare le preoccupazioni di MAGGI e ZORZI. Quanto a
quest’ultimo, la sentenza avrebbe trascurato di assegnare il dovuto risalto
alla corresponsione di ingenti somme al SICILIANO per
indurlo a ritrattare; al.timore che incuteva la
persona dello ZORZI allo stesso MAGGI; alla strumentalità dell’esposto di
quest’ultimo, ed all’eloquente contenuto di una lettera inviata dal TRINGALI
allo stesso ZORZI, ove traspare il timore che venisse individuato un legame tra
i veneziani ed i padovani. Nell’ottavo motivo si censura, infine, la coerenza e
la adeguatezza della motivazione in riferimento alla
posizione di Giancarlo ROGNONI, la delibazione della quale sarebbe stata
condotta dai giudici dell’appello ancora una volta con metodo atomistico e
parcellizzane e con sottovalutazione di circostanze logiche e documentali,
invece valorizzate in prime cure. Da tutto ciò, la richiesta di
annullamento della sentenza nei confronti di MAGGI, ZORZI e ROGNONI.
Nel ricorso proposto dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano viene
prospettato, coma primo motivo, manifesta illogicità e contraddittorietà della
motivazione, nonchè omesso esame delle prove dei rapporti fra il gruppo di
Ordine Nuovo di Padova ed il gruppo di Venezia‑Mestre. La sentenza impugnata ‑
osserva, infatti, la difesa erariale ‑ ha ritenuto di poter desumere
la responsabilità di FREDA e VENTURA in ordine agli
attentati del 12 dicembre 1969, ma ha al tempo stesso reputato di dover
escludere la attribuibilità di tali episodi anche al nucleo di Venezia e
Mestre, cui appartenevano MAGGI e ZORZI, in quanto non sarebbe stata acquisita
prova che i due gruppi avessero progettato assieme la realizzazione di tutti
gli attentati commessi nel 1969. Così trascurando di valutare
tutti gli elementi che, invece, consentivano di individuare in via autonoma la
responsabilità degli stessi MAGGI e ZORZI. D’altra parte, soggiunge la
ricorrente, è la stessa sentenza impugnata ad aver evidenziato in numerosi
passaggi ‑
che si indicano ‑ l’esistenza di univoci
elementi atti a denotare il cementarsi di una strategia eversiva comune ai
gruppi di Padova e Venezia‑Mestre. Ugualmente vizio di motivazione e mancato
esame di elementi di prova sono denunciati anche in
riferimento alle dichiarazioni rese da Martino SICILIANO. Avuto riguardo,
infatti, al giudizio di piena attendibilità che contrassegna più passaggi della impugnata sentenza in riferimento alla disamina delle
dichiarazioni rese dalla indicata fonte, non si comprende perché i giudici
dell’appello abbiano omesso di valutare gli elementi di prova forniti dal
medesimo anche in ordine alle vicende più significative per la attribuzione
delle responsabilità inerenti i fatti del 12 dicembre 1969, quali il racconto
della cosiddetta cena del tacchino e la crisi di pianto in occasione
dell’incontro con l’amico GRADARI. Tanto più ‑ soggiunge la ricorrente
Avvocatura ‑
che il SICILIANO non rivestiva la qualità di coimputato, ma quella di teste.
Analoghi vizi ‑
viene prospettato nel terzo motivo ‑
infirmerebbero anche la valutazione delle dichiarazioni rese da Carlo DIGILIO.
Ad avviso della ricorrente. infatti, la valutazione
della attendibilità del DIGILIO, come dimostrerebbe il contraddittorio risalto
assegnato alle dichiarazioni relative alla presunta appartenenza del medesimo
alla rete informativa americana, sarebbe
frutto di preconcetti e di sottovalutazione delle contrarie acquisizioni
processuali. Tale sarebbe, ad esempio, la ricostruzione offerta dai giudici a
quibus in ordine alla vicenda relativa al casolare di
Paese ‑
ove è stato trascurato l’apporto di ben sei testimonianze. e
degli spunti che potevano desumersi dagli stessi FREDA e VENTURA ‑
agli incontri DIGILIO‑ZORZI del settembre, ottobre 1969, successivi agli
attentati ai treni; all’incontro tra il DIGILIO ed il MAGGI prima del 7
dicembre 1969; alla vicenda di Canal Salso ed al pranzo natalizio, infine, tra
il DIGILIO, il MAGGI ed il SOFFIATI. Si denuncia, poi, la contraddittorietà
della motivazione nella parte in cui si riconosce la responsabilità del DIGILIO
in ordine ai fatti del 12 dicembre 1969, ma si
assolvono MAGGI e ZORZI, pur concorrenti nel medesimo reato, asserendosi ‑
con evidente salto logico ‑ la non applicabilità, nei confronti del primo,
dell’effetto estensivo della pronuncia liberatoria adottata nei confronti dei
secondi, facendo leva sulla differenza che sussiste tra la confessione e la
chiamata in a ‑
denuncia ancora la ricorrente ‑ avrebbe inoltre correità. La sentenza impugnata
omesso di dedurre elementi dì valutazione negativa circa la posizione dello ZORZI,
sia dalla ritenuta inattendibità dei testi indotti a discarico; sia dal provato
tentativo di inquinamento volto a conseguire la
ritrattazione del SICILIANO; sia, infine, dalla ritenuta responsabilità dei
TRINGALI per favoreggiamento. Si lamenta, infine, manifesta illogicità e
contraddittorietà di motivazione anche in riferimento
alla assoluzione di ROGNONI Giancarlo, giacche essa si sarebbe fondata solo
sulla mancata prova di collegamenti con il gruppo di FREDA e VENTURA,
trascurando però totalmente gli elementi che dimostravano, in via del tutto
autonoma, il coinvolgimento del ROGNONI nella strage, e di stabilire, di
conseguenza, i rapporti tra il gruppo della Fenice ed i vari nuclei di O.N. In
tal senso si evocano le numerose dichiarazioni atte ad inquadrare il ruolo e la
figura dell’imputato, e che confermano quelle rese da Edgardo BONAZZI: uno dei
principali testi a carico che i giudici a quibus hanno svilito senza adeguata
motivazione, dimenticando, pure, gli elementi confermativi desumibili dalle dichiarazioni
rese dal SICILIANO a proposito dei rapporti esistenti, antecedentemente al
dicembre 1969, tra il gruppo di Venezia-Mestre e l’imputato. Non senza
tralasciare la circostanza che il ROGNONI lavorava
proprio preso la Banca Commerciale ove fu collocato l’ordigno che non esplose,
e dovendosi dare atto ‑ conclude l’Avvocatura ‑ «dell’inopinato ed
ingiustificato suo allontanamento all’indomani dei 12.12.1969, seguito dalle
parimenti inopinate ed ingiustificate sue definitive dimissioni, senza che lo stesso
avesse trovato una fonte alternativa di reddito, ma essendosi solo iscritto, a
partire dal 18.12.1969, alla facoltà di medicina dell’Universitá».
Vari i motivi rassegnati anche
nel ricorso proposto nell’interesse del Comune di Milano. Nel primo si lamenta
illogicità della motivazione, con specifico riferimento al contrasto fra
l’asserita estraneità del gruppo di Venezia e la ritenuta responsabilità del
DIGILIO. Si osserva, infatti, che, essendo il DIGILIO ‑ per come anche
accertato nella sentenza, acquisita agli atti, della Corte di
assise di appello di Venezia divenuta irrevocabile nel 1991 e che ha
scandagliato l’attività dei gruppi ordinovisti nell’area di Venezia‑Mestre,
accertandone la natura di organizzazione armata volta alla ricostituzione del partito
fascista ‑
un importante protagonista del sodalizio, che ricopriva il ruolo di esperto di
armi e di “quadro coperto” posto a diretto contatto con Carlo Maria MAGGI, capo
del gruppo locale e del Triveneto, diviene del tutto contraddittorio ritenerlo
responsabile per la strage di Piazza Fontana e al tempo stesso reputare il
medesimo estraneo ai fatti il suo gruppo di appartenenza. Se, infatti, al
“gruppo Veneziano” di O.N., di cui DIGILIO è
pacificamente intraneo, non può essere attribuita alcuna responsabilità per i
fatti del 12 dicembre 1969, perchè realizzati dal solo gruppo padovano, il
giudice di appello avrebbe dovuto annullare anche la parte della sentenza di
primo grado in cui è stata dichiarata la prescrizione in ordine al reato
ascritto a quell’imputato. Analoga illogicità ‑ si osserva nel secondo motivo ‑
può cogliersi anche nel contrasto fra l’affermazione di responsabilità del
DIGILIO e la assoluzione di MAGGI e ZORZI. Si deduce,
al riguardo, la contraddizione in cui sarebbe caduta
la sentenza impugnata nel ritenere DIGILIO colpevole per i fatti del 12
dicembre 1969, mentre MAGGI e ZORZI, imputati di concorso con il DIGILIO nel
medesimo reato e dallo stesso coinvolti con la sua confessione ‑
reputata sufficiente per affermarne la penale responsabilità ‑vengono
assolti e, dunque, considerati estranei a quegli stessi fatti. Nel terzo motivo
si denuncia ugualmente vizio di motivazione nonché
travisamento dei fatti, in relazione al collegamento fra i vari gruppi di O.N.
e, in particolare, fra quelli di Padova e Venezia, nonchè in ordine al concorso
dei componenti del gruppo di Venezia‑Mestre nella strage. li vizio logico risiederebbe, secondo l’assunto del
ricorrente, nella circostanza che i giudici dell’appello, pur avendo
ricostruito correttamente gli eventi, ne avrebbero da essi tratto conclusioni
confliggenti con le premesse. La Corte, infatti, dopo aver posto a base
dell’iter logico la responsabilità di FREDA e VENTURA per i noti fatti di
sangue, avrebbe cercato i collegamenti tra costoro ed il gruppo di Venezia‑Mestre
senza trovarli, pur riconoscendo l’esistenza di frequentazioni per la
consumazione di attentati “comuni”. Da ciò concludendo per l’assoluzione degli imputati, in quanto
«ritenuti appartenenti ad un gruppo rimasto estraneo alla strage». La Corte
Però ‑
osserva il ricorrente ‑ avrebbe del tutto omesso di esaminare e valutare le
prove autonome nei confronti di MAGGI e ZORZI, così invertendo il corretto
percorso logico che avrebbe dovuto seguire: cioè,
partire prima dalla disamina delle prove autonome e, solo dopo, vagliare quelle
inerenti ai collegamenti tra i vari gruppi, in riferimento alle azioni che
avevano preceduto e seguito la strage. Al riguardo, il ricorrente ‑
dopo aver tracciato uno specchio descrittivo di fatti, autori e singoli gruppi di appartenenza ‑ ha passato in meticolosa
rassegna una diffusa serie di acquisizioni dalle quali, al contrario,
emergerebbero i contatti Personali e strategici tra il gruppo di FREDA e
VENTURA, da un lato, e MAGGI, ZORZI ed il gruppo di Venezia‑Mestre,
dall’altro; in linea, d’altra parte, con la stessa struttura Organizzativa per
cellule che caratterizzava O.N.” e con le finalità perseguite. Non senza sottolineare l’errore di ragionamento in cui sarebbero
caduti i giudici a quibus nell’interpretare il rientro nell’MSI dell’autunno
del 1969 come causa del progetto stragista, e non, piuttosto, come conseguenza
di quella strategia. Riferendosi, infatti, alla espressione
di RAUTI, secondo la quale O.N. doveva mettersi “sotto l’ombrello protettivo del
partito” ciò non poteva significare altro ‑ si deduce nel ricorso ‑
che erano proprio le paventate conseguenze di quel progetto stragista a
suggerire la necessità di una protezione ufficiale: «serve un ombrello ‑
sottolinea il ricorrente ‑ perchè sta per piovere, non è che piova perchè si
è preso l’ombrello!». Nel quarto motivo
si lamenta illogicità e carenza di motivazione in
riferimento alla ritenuta piena attendibilità del SICILIANO, all’attentato ai
magazzini COIN, ed alla eliminazione di rilevanza probatoria in ordine alla
cosiddetta “cena del tacchino” ed all’incontro con il GRADARI, conosciuto come
1a crisi di pianto” del SICILIANO. La Corte territoriale, infatti, dopo aver
formulato un giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal
SICILIANO, svaluta l’apporto della fonte in
riferimento, proprio, alle tre vicende sulle quali i giudici di Primo grado
avevano fondato la condanna: vale a dire l’attentato ai magazzini COIN (ed il
coinvolgimento dello ZORZI, per il quale è stata pronunciata la prescrizione);
alla cena di fine d’anno tra il SICILIANO, lo ZORZI ed il VIANELLO (nella
circostanza non attendibile, per evidenti esigenze dì autodifesa) , e
l’incontro tra il SICILIANO ed il GRADARI in Galleria a Mestre (ove si è
ritenuto attendibile il primo e inattendibile il secondo, senza trame le debite
conseguenze); episodi, questi, in ordine a ciascuno dei quali il ricorrente
svolge un’analitica ricostruzione, sottoponendo a critica i relativi passaggi
argomentativi svolti nella sentenza impugnata. Si lamenta, poi, nel quinto
motivo, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alle dichiarazioni “ambivalenti” di DIGILIO in
merito al casale di Paese ed alla vicenda di Canal Salso. A proposito del
difetto dei requisito della costanza e della coerenza
esterna nelle dichiarazioni relative al casolare di Paese, il ricorrente
osserva con i giudici dell’appello abbiano omesso di considerare varie
circostanze deducibili dalla sentenza di primo grado che smentirebbero la pretesa
tardività di alcuni riferimento cronologici; mentre, in ordine alla esistenza
del casolare, gli stessi giudici si sarebbero concentrati sul mancato
rintraccio dello stesso, senza prendere atto dei numerosi riscontri
testimoniali che erano stati acquisiti al riguardo. Analoghi errori
vizierebbero anche le conclusioni rassegnate a proposito della vicenda relativa all’incontro di Canal Salso, circa la quale si
sottolinea l’errore in cui la sentenza sarebbe caduta nel ritenere che il
DIGILIO avesse dichiarato di aver visto ordigni già predisposti “in tutto e per
tutto, compreso l’innesco”, quando, in realtà, tale assunto risulterebbe
contraddetto ampiamente dalla sentenza di primo grado; cosi come, al contrario,
i giudici dell’appello avrebbero totalmente omesso di considerare la presenza
nel bagagliaio della FIAT 1100 di una borsa sportiva, la cui importanza era
stata ‑
ancora una volta ‑ puntualmente sottolineata dai primi giudici. Pure trascurata è stata l’importanza del falso alibi fornito
dallo ZORZI. Contraddittorio è. infine, l’assunto
secondo il quale gli episodi di Paese e di Canal Salso avrebbero potuto vedere
la partecipazione di altri soggetti, visto che la stessa incertezza che ha
condotto alla assoluzione dì NUGGI e ZORZI ha invece condotto alla affermazione
della responsabilità di DIGILIO, con la declaratoria
di prescrizione. Se, infatti, conclude sul punto il
ricorrente, «il casolare di Paese non esiste, visto che DIGILIO non è riuscito
ad indicarne l’ubicazione, se DIGILIO non ha mai visto l’esplosivo a Canal
Salso, non si comprende, poi, sulla base di quali diverse valutazioni, non
esplicitate, il giudice a quo può affermare che a Paese cosi come a Canal
Salso, DIGILIO può aver incontrato qualcun altro, in un diverso momento». Nel
sesto motivo si censura la omessa valutazione
conclusiva in merito alle attività di depistaggio e di subornazione dei testi
poste in essere da Delfo ZORZI. Viene infatti rilevato
che i giudici dell’appello non avrebbero tratto alcun elemento circa la
responsabilità di ZORZI dal fatto che TRINGALI abbia svolto l’attività per la
quale è stato condannato. Del pari nessun significato è stato desunto dalle
deposizioni dei testi COGLITORE ed ARPAJA, ritenute entrambi
inattendibili, circa la presenza napoletana dello ZORZI. A ciò va
aggiunto ‑
sottolinea il ricorrente ‑ che lo stesso
ZORZI nelle sue spontanee dichiarazioni rese a Parigi, avrebbe clamorosamente
mentito, in ordine alla sua militanza in OX; sui fatti di Trieste e Gorizia;
sulle armi e gli esplosivi di cui avevano la disponibilità; sulla sua amicizia
di vecchia data con il SICILIANO, omettendo anche di citare la sua relazione
con COZZO Anna Maria ‑ il cui nominativo compariva sulla agenda di FREDA,
per conto del quale vendeva i suoi libri a Napoli ‑ al fine di evitare
i collegamenti che gli sarebbero derivati per i noti fatti di Trieste e
Gorizia. Aggiungendo a ciò la protezione offerta al VIANELLO perchè non
“ricordasse” la “cena del tacchino”, nonchè i vari interventi svolti perchè
SICILIANO, dapprima non confermasse, e, poi, ritrattasse le dichiarazioni rese,, risulterebbe, ad avviso del ricorrente, un evidente
difetto di motivazione circa i significati da annettere a condotte dello ZORZI
reputate, al contrario di elevato risalto ai fini del giudizio di responsabilità.
Identici i motivi rassegnati
dall’avv. Caterina Malavenda nell’interesse delle parti civili Gabriella CHIINA
e Silvana CHINA nei confronti di Carlo Maria MAGGI e
Delfo ZORZI.
Anche nel ricorso proposto per la
Provincia di Lodi, per la Provincia di Milano e per numerose altre parti civili
dall’avv. Federico Sinicato si prospetta, come primo motivo, manifesta
illogicità della motivazione e travisamento del fatto in
riferimento al ritenuto concorso di DIGILIO con FREDA e VENTURA nei noti fatti
del dicembre 1969 ed alla esclusione, per converso, del concorso nei medesimi
fatti degli imputati appellanti. Il ricorrente sottolinea
i vari passaggi della sentenza nei quali si coglierebbero vistose “crepe” che
incrinerebbero il “fragilissim” schermo posto dai giudici di appello tra Padova
e VeneziO per distinguere la ritenuta responsabilità del nucleo padovano di
FREDA e VENTURA dal gruppo di Venezia‑Mestre diretto da MAGGI e
ZORZI, per di più senza chiarire come fosse possibile attribuire a DIGILIO
attività eversive al di fuori di qualsiasi collegamento con questi ultimi due.
Analoghi vizi si denunciano anche
in relazione alla non riconosciuta compatibilità delle
dichiarazioni rese da Carlo DIGILIO con le valutazioni tecniche acquisite sugli
esplosivi utilizzati il 12 dicembre 1969. Erra, anzitutto, la Corte
territoriale nel ritenere le indicazioni offerte dal DIGILIO come frutto di indebite notizie fornitegli in occasione
dell’interrogatorio dei R.O.S., in quanto la descrizione dell’esplosivo “a
scaglie rosacee” era stata fornita nel febbraio 1994, “ben prima del colloquio
R.O.S. del 16 marzo 1995”. Cadrebbe, quindi, l’argomento utilizzato per
invalidare la spontaneità delle dichiarazioni circa l’esplosivo di Canal Salso.
In secondo luogo ‑ sottolinea ancora il ricorrente
‑
la sentenza impugnata non si sarebbe fondata su una lettura coerente dei dati
tecnico‑esplosivistici
raccolti, giacchè i dati acquisiti (odore di mandorle amare e mal di testa) in
occasione dell’accesso compiuto subito dopo la strage presso la B.N.A., stavano
a denotare ‑
come pure attestato dalla consulenza Berry, ampiamente utilizzata e citata dai
giudici a quibus ‑ che la presenza di “ammonal” o altro esplosivo
pulverulento a base di nitrato di ammonio non era affatto incompatibile ‑
come invece ritenuto in sentenza ‑ con le relazioni tecniche
acquisite agli atti. Si contesta, poi, la correttezza degli argomenti
utilizzati per dedurre, dalla riscontrata esistenza di solchi in un reperto, la
presenza di candelotti e che essi fossero di gelignite,
mentre si assume la compatibilità tra l’ammonal ed altro esplosivo similare
rispetto all’esplosivo “a scaglie rosacee” visto da DIGILIO. La Corte avrebbe,
poi, del tutto omesso di considerare il ruolo avuto dallo ZORZI nell’attentato
ai magazzini COIN di Mestre del marzo 1970 e le ragioni della preoccupazione
dell’ANDREATTA, il quale in una intercettazione
ambientale significativamente affermava che «se scoprono COIN comincia tutto!»,
creando un evidente collegamento con la strage di Piazza Fontana che non poteva
che riguardare lo ZORZI, visto che l’ANDREATTA non era stato mai indagato per
quel fatto. Nel terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione in riferimento alla ritenuta
inattendibilità dei DIGILIO circa i cosiddetti accesi al casolare di Paese,
nonchè travisamento dei fatti in ordine all’effettivo contenuto delle prove
esaminate. La sentenza afferma, infatti, che la narrazione di DIGILIO
difetterebbe del requisito della costanza (per via dei
ritardo nella descrizione della vicenda) e della coerenza interna
(mancato reperimento del casolare e presenza di Lino FRANCO) e non sarebbe
accompagnato da riscontri. Non vi sarebbe invece alcun ritardo nelle
dichiarazioni, posto che della vicenda delle armi e degli esplosivi di VENTURA il
DIGILIO ne aveva parlato già in interrogatori del
febbraio, marzo e ottobre 1994: solo del terzo accesso nè parlò durante il
1997, dopo l’ictus di cui era rimasto vittima ed il lungo periodo di
riabilitazione. Quanto alla coerenza esterna, la prima obiezione nasce dalla
difficoltà di rinvenire l’esatta ubicazione del
casolare a distanza di tanti anni e del profondo mutamento dei luoghi; a
proposito, poi, della presenza di Lino FRANCO, il ricorrente sottolinea la
mancata esatta lettura delle prime dichiarazioni del DIGILIO, antecedenti la
malattia, e la valutazione non corretta delle dichiarazioni rese dalla vedova
del FRANCO, evidentemente dettate dalla esigenza di tutelare la figura del
marito. Quanto ai riscontri, il ricorrente evoca le numerose fonti, fra le
quali lo stesso ZORZI, dalle quali poteva desumersi l’esistenza di un deposito di armi ed esplosivi vicino a Treviso, ed alle descrizioni
di Vincenzo VINCIGUERRA circa nastri di proiettili consegnatigli da ZORZI
destinati ad una mitragliatrice dello stesso tipo di quella descritta dal
DIGILIO fra le armi viste nel casale di Paese. Altrettanto svilito sarebbe il
risalto delle dichiarazioni rese da Tullio FABRIS circa le «prove di accensione dell’innesco al nichel‑cromo», in
riferimento alla narrazione del DIGILIO sulla vicenda di Paese. Ugualmente
vizio di motivazione e travisamento dei fatti vengono
prospettati nel quarto motivo in relazione alla valutazione delle prove
documentali e testimoniali sulla conoscenza antecedente il 12 dicembre 1969 tra
Franco FREDA, Delfo ZORZI e Carlo Maria MAGGI. La Corte, in particolare,
avrebbe trascurato tutta una serie di riscontri alle dichiarazioni di SICILIANO
circa i programmi di attentati ai treni evidenziati da
ZORZI e avrebbe al tempo stesso svilito la unicità del disegno che collegava
quegli attentati ai fatti del 12 dicembre di quello stesso anno; cosi come sono
stati sottovalutati gli elementi di conferma circa i qualificati rapporti
esistenti tra i gruppi di Padova e di Venezia‑Mestre, nel quadro di una comune
strategia (dichiarazioni del teste CASALINI che aveva parlato della consegna di
armi ed esplosivi affidati da FREDA a MAGGI per la custodia; il sequestro di
una agenda di VENTURA con il numero del DIGILIO; la presenza sulla agenda di
FREDA del recapito napoletano di ZORZI e di un biglietto con il quale, al
momento della perquisizione a casa di VENTURA il 20 dicembre 1969, avvisava
MAGGI e RAUTI dell’esito della stessa). Il tutto non senza
ricordare l’omessa valutazione delle false testimonianze sul presunto alibi
napoletano di ZORZI, e la tentata subornazione di SICILIANO. Analoghe
censure vengono svolte anche in relazione agli
incontri di Corso dei Popolo tra DIGILIO e ZORZI nel settembreottobre 1969,
mentre vizio di motivazione e travisamento dei fatti si evocano a contrastare
la ritenuta inattendibilità dei DIGILIO a proposito di quanto affermato circa
l’incarico di relazionare il FRANCO ed il MINETTO sulle armi custodite a Paese
da VENTURA, con riguardo alla accertata appartenenza del collaboratore ad una
rete informativa di controguerriglia in
funzione anticomunista. Sulla base di una diffusa
disamina, tutta condotta in punto di fatto, il ricorrente contesta, in
particolare, l’assunto della Corte secondo il quale non ha ritenuto attendibile
DIGILIO, laddove ha accreditato una sua collocazione in seno ad una rete informativa
che ‑
come ampiamente chiarito nella sentenza di primo grado ‑ «aveva un ruolo
significativo nella complessa strategia anticomunista e controrivoluzionaria»:
strategia, questa, che ‑ deduce il ricorrente ‑ sarebbe stata asseverata dallo
stesso Generale MALETTI, sentito nel corso del dibattimento. Si lamenta,
ancora, vizio di motivazione e travisamento dei fatti in
relazione all’episodio della progettata evasione di VENTURA secondo le dichiarazioni
rese dal DIGILIO, contestandosi la coerenza degli elementi su cui i giudici
dell’appello avrebbero fondato il loro scrutinio di attendibilità. Sulla base di una ampia ricostruzione in fatto, il
ricorrente contesta ‑denunciando vizio di motivazione e travisamento del
fatto ‑
la sentenza impugnata nella parte in cui fa propria la tesi della difesa di
ZORZI, secondo la quale DIGILIO avrebbe accusato falsamente esso ZORZI per
l’astio conseguente alle dichiara ioni accusatorie di Martino SICILIANO rese
nei suoi confronti a Tolosa nell’autunno 1994; dichiarazioni che, secondo il
collaboratore, sarebbero state ispirate proprio dallo ZORZI. Analogo tipo di
contestazioni vengono formulate anche per ciò che
attiene alla ritenuta influenza che ‑ secondo i giudici a quibus ‑
avrebbero avuto i colloqui investigativi cui il DIGILIO era stato sottoposto,
con l’effetto di aver reso non spontanee le relative dichiarazioni. Nel decimo
motivo si denuncia ugualmente vizio di motivazione, avuto riguardo al non coretto
percorso logico che la sentenza avrebbe seguito per
affermare la irrilevanza delle dichiarazioni rese da SICILIANO in ordine alle
affermazioni di ZORZI durante la cosiddetta “cena del tacchino” del capodanno
1969. Manifesta illogicità e travisamento dei fatti si prospettano anche in
merito alla ritenuta insufficienza delle prove circa il concorso di Carlo Maria
MAGGI nel reato di strage. La sentenza di appello, in
particolare, per definire la posizione dell’imputato, si sarebbe fondata
esclusivamente sugli episodi di Paese e di Canal Salso e sulla relativa assenza
di riscontri circa le dichiarazioni del DIGILIO, trascurando, pressochè
integralmente, gli altri elementi di prova elencati nella sentenza di primo
grado in merito al concorso di MAGGI e che il ricorrente rammenta. Identiche
censure vengono dedotte ‑ con ampio sviluppo descrittivo
degli elementi portati ad emersione nella pronuncia di primo grado e con
allegazione di documenti ‑ anche in relazione alla ritenuta mancanza di prove
circa la responsabilità dì Giancarlo ROGNONI. Si contesta pure, al riguardo, la
valutazione operata dai giudici di secondo grado in ordine
all’apporto probatorio da annettere alla testimonianza di BONAZZI ed
alle giustificazioni offerte in merito alle dimissioni dello stesso ROGNONI
dalla Banca Commerciale Italiana, proprio in occasione dei tragici fatti del
dicembre 1969. Sì lamenta, infine, nel tredicesimo ed ultimo motivo, violazione
di legge, in riferimento alla perizia dì trascrizione
di una intercettazione ambientale avvenuta a casa del MAGGI il 13 marzo 1996 in
relazione ad un contrasto che era emerso in occasione di precedente
trascrizione. Si censura, al riguardo, che il perito, nel corso delle
operazioni, avrebbe proceduto ad una sessione con il
consulente della difesa, ma non con quello del pubblico ministero: circostanza,
questa, emersa nel corso dell’esame dibattimentale, ma della quale non vi era
traccia nel verbale delle operazioni peritali.
Nel ricorso proposto
nell’interesse di TRINGALI Stefano si prospetta, quale primo motivo,
inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali. in quanto a seguito della sentenza di primo grado era stata
esclusa l’aggravante delle finalità di terrorismo; sicchè ‑
osserva il ricorrente ‑ essendo state le intercettazioni disposte per
ipotesi di strage e comunque per fatti di terrorismo, non potevano più essere
utilizzate nei confronti dell’imputato. Riproponendo
motivo già devoluto in appello, si lamenta, poi, la mancata concessione della
riduzione di pena ex articolo 438 Cpp, essendosi la Corte territoriale limitata
a riportare la decisione di primo grado circa la tardività della domanda. Si
lamenta, poi, vìzio di motivazione in riferimento al
diniego delle attenuanti generiche e si deduce, nel quarto motivo, la prescrizione
del reato, che al più si sarebbe maturata ‑ secondo il ricorrente ‑
nel gennaio 2004. Si lamenta, inoltre, vizio di motivazione in
riferimento alle due condotte che, ad avviso della Corte territoriale,
integrerebbero il reato, e si contesta, in fatto, la congruenza del percorso
argomentativo ai fini della affermazione della penale responsabilità in ordine
alla contestata fattispecie delittuosa. Viene infine
censurata, in forza anche di rilievi nel merito della imputazione, la
motivazione della sentenza nella parte in cui ha escluso ‑
deduce il ricorrente ‑ che il TRINGALI si trovasse «nella posizione
psicologica di colui che aveva ritenuto di essere indagato», conseguentemente
escludendo «l’ipotesi di autofavoreggiamento» ai fini dell’applicazione della
esimente di cui all’articolo 384 Cp.
Con memoria assai diffusa ed
articolata, i difensori di Delfo ZORZI hanno, più di recente, analiticamente
passato in rassegna i singoli motivi posti a fondamento dei ricorsi, con
particolare attenzione a quello proposto dalla procura
generale, contestandone in taluni casi l’ammissibilità ‑ assumendosi
trattarsi di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità ‑
ed in altri casi la fondatezza, attraverso, anche, meticolose citazioni di
singoli passaggi della sentenza impugnata e di altri atti del procedimento. A
corredo della memoria è stata altresì depositata una altrettanto diffusa nota
riassuntiva della discussione orale svoltasi dinnanzi alla Corte di assise di appello di Milano.
Ha depositato memoria anche l’avv.
Sinicato, quale difensore della Provincia di Milano, della Provincia
di Lodi e dì altre parti civili, il quale, in merito alle doglianze espresse
nell’ottavo motivo di ricorso ed a sostegno del prospettato vizio di
motivazione e travisamento del fatto, ha prodotto stralci delle dichiarazioni
rese dall’Ispettore MADIA in merito ai contatti avuti con il SICILIANO ed atti
contenuti nel. cosiddetto “fascicolo SISMI” prodotto
dal pubblico ministero nel corso della udienza del 10 novembre 2000. Ciò al
fine di evidenziare, fra l’altro, la circostanza che il SICILIANO non avrebbe
accusato il DIGILIO della strage di Piazza Fontana, ma avrebbe indicato la
persona dello ZORZI come depositarío dei relativi segreti; sicchè, tenuto conto
dell’epoca di quelle prime confidenze fatte dal SICILIANO, sarebbe
conseguentemente erronea 19 interpretazione data dalla Corte al colloquio avuto
dal DIGILIO con il MAGGI presso la Questura di Venezia il 2 febbraio 1995,
secondo la quale il DIGILIO stesso sarebbe stato a conoscenza “dell’accusa a
lui rivolta da SICILIANO per la strage” con la ulterìore
conseguenza di far venir meno la asserita ragione di astio nei confronti dello
ZORZI, ritenuto mandante di quelle confidenze, posto che il SICILIANO avrebbe
iniziato a formulare accuse nei confronti dello stesso DIGILIO «solo a partire
dagli interrogatori resi nel 1995».
In prossimità della
udienza ha deposítato memoria anche il difensore del Comune di Milano,
sviluppando, in sintesi, le considerazioni e le censure già poste a fondamento
dei vari motivi di ricorso.
Considerato in diritto
Come agevolmente traspare da
quanto si è già riferito in parte narrativa, il nucleo essenziale delle censure
poste a fondamento dei ricorsi proposti dal pubblico ministero e dalle parti
civili, ruota, essenzialmente, attorno al reputato erroneo apprezzamento della
valenza probatoria annessa ai contributi dichiarativi offerti dalle principali
fonti di accusa: vale a dire Carlo DIGILIO e Martino
SICILIANO, i cui apportì sono stati valutati dai giudici di entrambi i gradi di
merito secondo i criteri stabiliti dall’articolo 192, commi 3 e 4, Cpp, nonchè
Edgardo BONAZZI, fonte de relato, in riferimento alla posizione di Giancarlo
ROGNONI.
Al riguardo, occorre qui ribadire che la giurisprudenza di questa Corte ha in più
occasioni avuto modo di puntualizzare che ‑ al lume di una precisa scelta
compiuta dal legislatore del nuovo codice, indirettamente ma chiaramente
scrutinata, con esito positivo, dalla stessa Corte costituzionale ‑
la chiamata in reità o in correità, per poter assurgere al rango di prova posta
a fondamento di una affermazione di responsabilità, necessita, oltre che di un
positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di
elementi correttamente evocabili alla stregua di riscontri estrinseci alla
chiamata stessa. Tali elementi, da un punto di vista oggettivo, possono
consistere in qualsiasi circostanza, fattore o dato probatorio non
predeterminato nella specie e nella qualità, ed avere, pertanto, qualsiasi
natura: i riscontri, dunque, possono consistere in elementi di prova sia
rappresentativa che logica ed essere a loro volta desumibili
anche da altra chiamata in reità o in correità, sempre che, ovviamente, la
stessa si presenti come totalmente autonoma ed avulsa rispetto a quella da
“corroborare”. E’ essenziale, inoltre, che tali riscontri siano indipendenti
dalla chiamata, nel senso che devono provenire da
fonti estranee alla chiamata stessa, in modo da evitare il fenomeno della
cosiddetta circolarità della acquisizione probatoria, e cioè che, in
definitiva, sia la stessa chiamata a convalidare se stessa, attraverso un
meccanismo di vuota autoreferenzialità. I riscontri, infine, sempre nella prospettiva di, un giudizio di condanna e, dunque, di
un corredo probatorio che asseveri la responsabilità penale in ordine alla
regiudicanda in termini di certezza, al dì là di ogni “ragionevole dubbio” ‑
circostanza, questa, che va evidenziata, giacchè le censure del pubblico
ministero e delle ricorrenti parti civili si concentrano prevalentemente contro
la assoluzione dì ILAGGI e ZORZI, pronunciata, peraltro, a norma dell’articolo
530, comma 2, Cpp ‑ devono avere valenza individualizzante, e cioè
riguardare non soltanto il complesso delle dichiarazioni, ma anche la
riferibilità dello specifico fatto reato che viene in discorso con la altrettanto
specifica posizione dell’Imputato; in altri termini, i riscontri non devono
semplicemente consistere nella oggettiva conferma del fatto riferito dal
chiamante, ma devono costituire elementi che collegano il fatto stesso alla
persona dei chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo della
attribuzione a quest’ultimo del reato contestato. Per converso, e come è evidente, non e invece richiesto che i riscontri
abbiano lo spessore di una prova autosufficiente, giacchè, in tal caso, la
prova si fonderebbe ‑ o potrebbe comunque fondarsi ‑
su tali elementi esterni, senza rendere indispensabile lo scrutinio di
“conferma” che la chiamata normativamente postula, in dipendenza della ritenuta
“non terzietà” ed indifferenza del dichiarante rispetto all’oggetto del suo
contributo. Per altro verso, e sempre in tema di riscontri esterni alla
chiamata in correità, si è pure affermato, di recente, che legittimamente il
giudice di merito può procedere attribuendo al singolo riscontro una efficacia traslativa, conferendo ad esso valenza anche
rispetto ad episodi diversi da quello cui il riscontro stesso si riferisce. Ciò
in quanto ‑
si è affermato ‑
l’efficacia traslativa interna del riscontro individualizzante, di regola non
consentita (giacchè, altrimenti, la confermata attendibilità delle
dichiarazioni su un fatto o su una persona basterebbe a rendere automaticamente
confermata la caratura probatoria delle dichiarazioni di quella stessa fonte su
ogni altro fatto e soggetto comunque coinvolto,
facendo venir meno la stessa ratio essendi della cosiddetta corroboration),
deve invece ammettersi nei casi in cui i singoli episodi delittuosi si
inseriscano in una attività che renda verosimile anche la responsabilità
dell’imputato per gli episodi privi di specifico riscontro. Infatti, allorchè
il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di
fatti‑reato
commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l’elemento di riscontro
esterno in ordine ad alcuni di essi fornisce, sul
piano logico, la necessaria integrazione probatoria a conforto della chiamata
anche in ordine agli altri, purchè sussistano, peraltro, ragioni idonee a
suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle
dichiara ioni accusatorie, quali l’identica natura dei fatti in questione,
l’identità dei protagonisti o di alcuni di essi, l’inserirsi dei fatti in un
rapporto intersoggettivo unico e continuativo, atteso che gli elementi
integratori della prova costituita da dichiarazioni rese da un imputato dello
stesso reato o di un reato connesso, ex articolo 192, comma 3, Cpp, possono
essere, come si è detto, della più varia natura, e, quindi, anche di carattere
logico, purchè riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni
(Cassazione, Sezione quarta, Sezione quarta, 10 dicembre 2004, Alfieri).
D’altra parte, e sul piano della argomentazione reciproca e speculare, è costante
l’assunto secondo il quale la cosiddetta valutazione frazionata delle
dichiarazioni accusatorie provenienti da chiamata in correità ‑
per la quale l’attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte
del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti,
quando queste reggano alla verifica giudizíale del riscontro ‑
in tanto è ammissibile, in quanto non esista una interferenza fattuale e logica
fra le parti del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano
intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate. Interferenza,
peraltro, che si verifica solo quando fra la prima
parte e le altre esista un rapporto di causalità necessario ovvero quando l’una
sia imprescindibile antecedente logico dell’altra (Cassazione, Sezione sesta, 2
febbraio 2004, Agate; Cass., Sezione prima, 18 dicembre 2000, Orofino;
Cassazione, Sezione prima, 20 marzo 1998, Barbaro). Inscindibilità del tessuto
dichiarativo ‑
nel che sta l’essenza della impossibilità di operarne
una valutazione frazionata in punto di attendibilità ‑ e corrispondente
“efficacia traslativa” dei riscontri esterni che quella attendibilità abbiano
confermato, sia pure con riferimento a taluni soltanto dei momenti “centrali”
in cui quel tessuto si è venuto a dipanare, rappresentano, dunque, gli
speculari termini di una medesima “fenomenologia probatoria”, quale è quella,
appunto, postulata dalla regola di giudizio sancita dall’articolo 192, commi 3
e 4, del codice di rito.
Peraltro, ai fini di una corretta
valutazione della chiamata in correità a mente del più volte
richiamato articolo 192, comma 3, Cpp, il giudice deve in primo luogo
sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e
accusatore) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio‑economiche
e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla
genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa
dei coautori e complici; ed in secondo luogo deve verificare l’intrinseca
consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce
di criteri come la precisione, coerenza, costanza e spontaneità; infine, deve
esaminare i riscontri esterni, a loro volta da scrutinare con rigore, specie
ove promananti da altri soggetti le cui dichiarazioni siano a loro volta
parimenti assoggettate alla disciplina prevista dall’articolo 192, commi 3 2 4,
Cpp. Tale esame, peraltro ‑ aspetto questo puntualmente osservato nella
sentenza impugnata, ma a tratti negletto dai ricorrenti ‑ deve essere
compiuto seguendo l’indicato ordine logico, perchè non si può procedere ad una
valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova
che ne confermano l’attendibilità se prima non si chiariscano
gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in se, indipendentemente
dagli elementi di verifica esterni ad essa (ex plurimis, Cassazione, Sezione
11, 12 dicembre 2002, Contrada; Cassazione, Sezione quinta, 18 gennaio 2000,
Orlando; v., anche, Cassazione, Su, 30 ottobre 2003, Andreotti). Se, infatti,
il riscontro esterno deve avallare la attendibilità
della chiamata, ove questa sia (intrinsecamente o estrinsecamente) reputata
inattendibile, non potrà subire meccanismi di “convalescenza probatoria” sulla
base di altre acquisizioni che avallino, per avventura, il fatto storico
narrato dalla fonte: in altri termini, ove sia ritenuta non affidabile la
dichiarazione de visu o de auditu, perchè si ipotizza che il soggetto non abbia
visto o udito di un determinato accadimento, i “riscontri esterni” sul fatto si
rivelano, in tale prospettiva, inconferenti.
Al tempo stesso, e come si è già
accennato, le dichiarazioni accusatorie rese da
imputati dello steso reato, o di reato connesso o collegato sul piano
probatorio, ben possono essere riscontrate anche da altre dichiarazioni della
stessa natura, a condizione, peraltro, che tutte siano dotate di intrinseca
attendibilità e che il giudice possa affermare l’autonomia di ciascuna,
escludendo reciproche interferenze e fenomeni di allineamento delle indicazioni
più recenti rispetto a quelle raccolte per prime (cfr. ad
es., Cassazione, Sezione prima, 4 novembre 2004, Palmisani; Cassazione, Sezione
quarta, 16 aprile 2003, Zungri; Cassazione, Sezione prima, 19 marzo 2003,
Vitale).
A proposito, poi, degli indizi,
la disciplina al riguardo prevista dall’articolo 192, comma 2, Cpp, sembra
accreditare la tesi di chi, lungi dal circoscrivere la relativa nozione nella
sfera della prova critica o indiretta (non avrebbe senso, infatti, postulare
per questo tipo di prova una esigenza di
“rafforzamento”, ben potendo essa connotarsi per una efficacia dimostrativa dei
fatto da accertare, maggiore rispetto a tutte le altre prove rappresentative),
reputa che il paradigma normativo evochi ‑ nel richiedere i requisiti
della gravità, precisione e concordanza ‑ l’intera ed innominata gamma
degli “elementi” che si caratterizzino, sul piano dei risultati appunto
“dimostrativi” (ed a prescindere dal relativo inquadramento dogmatico), quali
fattori di probatio levior. Quanto ai parametri di valutazione tracciati
dall’articolo 192, comma 2, Cpp, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto
modo di puntualizzare che gravi sono gli indizi consistenti, cioè
resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e convincenti; precisi sono
quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o
più verosimile, e, perciò, non equivoci; concordanti sono quelli che non
contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi. In
particolare ‑si
è aggiunto ‑ la precisione dell’indizio ne presuppone la
certezza. Tale requisito, benchè non espressamente indicato dall’articolo 192,
comma 2, Cpp, è da ritenersi insito nella previsione di tale precetto. Con la
certezza dell’indizio, infatti, viene postulata la
verifica processuale circa la reale sussistenza dell’indizio
stesso,
gìacchè non potrebbe essere consentito fondare la prova critica su un fatto verosimilmente
accaduto, supposto o intuito, e non accertato come realmente verificatosi, dal
momento che, con la regola di giudizio positivamente codificata, il
procedimento probatorio fondato su elementi indiziari per sfociare nella prova
del fatto ignoto ‑ oggetto del thema probandum ‑ deve fondarsi su
circostanze di sicura verificazione storico‑naturale (sul requisito della
“certezza” v. Cassazione, Sezione prima, 28 giugno 1999, Capitani; Cassazione,
Sezione prima, 20 ottobre 1994, Olivieri).
Peraltro, accanto alla disamina
“qualitativa” che, come si è detto, l’ordinamento impone al giudice nel dettare
rigorosi criteri per trarre il noto dall’ignoto su base indiziaria, regole
altrettanto rigorose contrassegnano anche la “metodologia” che il giudice deve
seguire nel procedere alle indicate verifiche. Infatti, nei procedimenti in
cui, come nel caso di cui qui si tratta, l’ipotesi accusatoria si regge su una
pluralità di elementi di carattere indiziario, il
giudice di merito è chiamato ad una duplice operazione, cadenzata secondo una
logica e doverosa consecutio: deve, infatti, prima valutare tali elementi
singolarmente, per stabilire se presentino il requisito della certezza, nel
senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti,
e per saggiarne la valenza indicativa individuale che di norma (salvo
l’ipotesi, del tutto rara, dei cosiddetto indizio necessario, da cui è
logicamente desumibile una sola conseguenza) è di portata solo probabilistica;
e deve, quindi, passare ad un esame globale degli elementi cui può essere
riconosciuto carattere di certezza, per verificare se la relativa ambiguità
promanante da ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione
unitaria, coerentemente rìsolversi (Cassazione, Sezione prima, 26 novembre
1998, Buono; Cassazione, Sezione prima, 2 febbraio 1996, Monaro; Cassazione,
Su, 4 febbraio 1992, Musumeci). Ancora una volta, le frequenti censure che i
ricorrenti muovono in ordine ad una pretesa “parcellizzazione” degli indizi da
parte dei giudici dell’appello ed alla corrispondente “atomizzazione” delle
relative valutazioni, non tengono conto della ineludibile
necessità ‑
puntualmente e con assoluto rigore logico soddisfatta nella sentenza impugnata ‑
di operare anzitutto ‑ e, per così dire, ante portas – uno scrutinio di
ciascuna acquisizione “indiziante”; scremare quelle reputate inconferenti o
prive delle accennate caratteristiche denotative; e, solo all’esito, procedere
ad un apprezzamento globale delle varie emergenze, per verificarne le relative
interazioni, integrazioni o, al contrario, smentite, aporie o contraddizioni
sul piano logico-ricostruttivo. Il tutto non senza trascurare il circoscritto
perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato di legittimità, posto che, in
tema di processi indiziari, alla Corte di cassazione spetta soltanto il
sindacato sulla non implausibilità delle massime di esperienza
adottate nella valutazione degli indizi, nonchè la verifica sulla correttezza
logico‑giuridica
del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare
l’elemento indiziario, ma non certo il compito di procedere ad un nuovo
accertamento, nel senso della ripetizione della esperienza conoscitiva dei
giudice del merito. Ne discende che l’esame della gravità, precisione e
concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità, è semplicemente
controllo sul rispetto, da parte del giudice dei merito,
dei criteri dettati dal legislatore in materia di valutazione delle prove
dall’articolo 192 Cpp; controllo eseguito con il ricorso ai consueti parametri
della completezza, della correttezza e della logicità del discorso
motivazionale (in tema di sindacato sulle massime di esperienza v. Cassazione,
Sezione sesta, 7 marzo 2003; Cassazione,
Sezione seconda, 24 febbraio 1998, Ermini; Cassazione, Sezione prima, 5
dicembre 1994, Colonnetti).
D’altra parte, e con specifico
riferimento proprio ai confini entro i quali può
svolgersi lo scrutinio della Corte di cassazione sulla valutazione delle
chiamate di correo operata dal giudice del merito, la giurisprudenza di questa
Corte ha in più occasioni avuto modo di sottolineare che non è consentito al
giudice di legittimità un controllo sul significato concreto di ciascuna
dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perchè un tale esame
invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice del merito; ma
è conferito solo il compito di verificare l’adeguatezza e la coerenza logica
delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari
elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento. Il giudice
della legittimità, che è giudice della motivazione e della osservanza
della legge, non può divenire, cioè, giudice del contenuto della prova,
trattandosi di un compito estraneo a quello istituzionalmente affidatoglì,
anche perchè con il nuovo codice di rito, il travisamento del fatto è stato
espunto dai vizi concernenti la motivazione, essendo richiesto che eventuali
contrasti siano interni a quest’ultima (fra le altre, Cassazione, Sezione
seconda, 1 marzo 2000, Previti; Cassazione, Sezione sesta, 2 ottobre 1998,
Archesso). Più specificamente, il vizio noto come “travisamento del fatto” ‑
come si è accennato in parte narrativa, insistentemente evocato, quale
frequente censura, tanto nel ricorso del pubblico ministero che in quelli delle
parti civili ‑
può sopravvivere, nella vigente disciplina, soltanto nella ipotesi,
prevalentemente teorica, in cui il giudice, dopo aver fatto propria una certa
ricostruzione degli eventi, ne tragga, sul piano giuridico, conclusioni
confliggenti con la medesima e supponenti, sotto il profilo logico, una
ricostruzione diversa (Cassazione, Sezione prima, 15 dicembre 1999, Morabíto;
v. anche, più di recente, Cassazione, 3 dicembre 2003, Polito).
La ricostruzione, quindi, dei
parametri teoricì e degli elementi ‑ fattualì o di
ordine logico‑congetturale ‑ sulla cui base i giudici del
merito sono pervenuti ad una determinata “configurazione probatoria” delle
singole emergenze e del reciproco e complessivo convergere in vista del
giudizio conclusivo agli effetti della relativa capacità “dimostrativa” del
relativo oggetto di prova, finisce dunque per trovare espressione e
dimostrazione “esterna” nel corrispondente percorso motivazionale che la
sentenza è chiamata, per obbligo normativo, a somministrare. Al generale
obbligo di motivazione, infatti, ne corrisponde uno specifico in punto di apprezzamento del corredo probatorio, giacche ‑
paradigmaticamente ‑ a nonna dell’articolo 192, comma 1, del codice di
rito, dei risultati che scaturiscono dalla valutazione della prova e dei
criteri adottati (il profilo “sostanziale” del tasso di persuasività della
prova, e quello “metodologico” del percorso seguito per giungere a quel
determinato convincimento) il giudice è chiamato a darne conto nella
motivazione. Al riguardo, nella Relazione al Progetto preliminare del nuovo
codice, si segnalava come fosse «decisamente nuovo …
il raccordo tra convincimento del giudice e obbligo di motivare: su un piano
generale ‑
sottolineava infatti il documento ‑ esso mira a segnalare, anche a
livello legislativo, come la libertà di apprezzamento della prova trovi un
limite in principi razionali che devono trovar risalto nella motivazione; sotto
un profilo più strettamente operativo, il nesso vuol far risaltare il contenuto
della motivazione in fatto, che si esprime nella enunciazione delle rìsultanze
processuali e nella indicazione dei criteri di valutazione (massime di
esperienza) utilizzati per vagliare il fondamento della prova … ». 1 limiti che
pertanto presenta nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione,
ineluttabilmente si riflettono, dunque, anche sul controllo in
ordine alla valutazione della prova, giacche altrimenti ‑
come si è già accennato ‑ anziché verificare la correttezza dei percorso
decisionale adottato dai giudici del merito, alla Corte di cassazione sarebbe
riservato un compito di rivalutazione delle acquisizioni probatoríe,
sostituendo ‑
in ipotesi ‑all’apprezzamento
motivatamente svolto nella sentenza impugnata, una nuova e alternativa
valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente sconfinerebbe in
un eccentrico terzo grado di giudizio. Da qui, il ripetuto e constante
insegnamento in forza del quale ‑ alla luce degli espressi e non
casuali limiti che circoscrivono, a norma dell’articolo 606, comma 1, lett. e),
il controllo del vizio di motivazione in cassazione ‑ nel momento del
controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la
decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del
testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile
(come puntualizzava anche la giurisprudenza formatasi sotto l’impero del
vecchio codice in tema di massime di esperienza) con
il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento:
e ciò proprio perchè il richiamato articolo 606, comma 1, lett. e), Cpp, non
consente alla Corte ‑ che deve limitarsi ad apprezzare la adeguatezza dei
corredo argomentativo e la non manifesta illogicità del relativo percorso ‑
di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa
interpretazione delle prove (o della relativa affidabilità ed inferenza), perchè
è estraneo al giudizio di legittimità il controllo della correttezza della
motivazione in rapporto ai dati processuali (cfr., al riguardo, ex multis,
Cassazione, Sezione quarta, 2 dicembre 2003, Elia; Cassazione, Sezione quinta,
13 maggio 2003, Pagano; Cassazione, Sezione quinta, 30 novembre 1999, moro). Da
qui la inconferenza di non poche delle censure
proposte dai ricorrenti, posto che la sentenza impugnata ha, con motivazione
ampia, appagante e non certo manifestamente illogica, dato puntualmente atto,
con riferimento alle singole vicende ‑ assunte in primo grado quali
altrettanti nuclei portanti del diverso giudizio in punto di responsabilità
penale ‑
delle “ragioni” per le quali si è ritenuto di assegnare diversa valenza alle
acquisizioni probatorie e dei criteri adottati per giungere a diverse e meno
“certe” conclusioni.
Scendendo alla disamina dei vari
motivi di ricorso proposti dal procuratore generale e dalle parti civili, e
riservando ad un momento successivo l’esame del ricorso proposto dal TRINGALI,
può rilevarsi, anzitutto, come, tanto nella premessa della impugnazione
proposta dal pubblico ministero, che in singoli motivi appositamente enunciati
da alcune delle parti civili, si dedichino consistenti doglianze per
stigmatizzare la asserita contraddizione che minerebbe alla radice la coerenza
intrinseca della decisione impugnata, nella parte in cui i giudici dell’appello
avrebbero, da un lato, ritenuto la responsabilità dei DIGILIO assieme a FREDA e
VENTURA e, dall’altro, hanno invece escluso la responsabilità di MAGGI e ZORZI
negli stesi fatti ascritti ai primi. Il tema, per la evidente
suggestione che è in grado di evocare ‑ dal momento che DIGILIO, fonte
di accusa per MAGGI e ZORZI, era stato ritenuto dai giudici di primo grado
credibile anche contra se, e assolto per prescrizione dall’addebito di strage a
seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche ‑
non è stato affatto eluso dai giudici dell’appello, come contrariamente opina
il pubblico ministero, il quale lamenta che la Corte territoriale avrebbe
«dimentica(to) di spiegare come mai», a fronte della ritenuta inattendibilità
erga alios, sarebbe stata «invece confermata la responsabilità» del DIGILIO in
ordine ai tragici fatti del 12 dicembre 1969. Nella sentenza impugnata, infatti
(pag. 612), dopo aver appunto rammentato l’epilogo del giudizio di primo grado in ordine alla posizione del DIGILIO, assolto per
prescrizione a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche
dichiarate prevalenti sull’aggravante, ha sottolineato come nella specie non
potesse invocarsi l’effetto estensìvo della impugnazione, giacche le ragioni
della assoluzione dì MAGGI e ZORZI dovevano, a norma ed agli effetti di quanto
previsto dall’articolo 587, comma 1, Cpp, qualificarsi come “personali”, posto
che, sul piano probatorio, la confessione e la chiamata ìn correità non
potevano considerarsi fra loro equivalenti e, dunque, non poteva ritenersi
sussistente “una situazione di incompatibilità di giudicati”, a prevenire la
quale sta, appunto, l’istituto della estensione della ímpugnazione (v., ad es,
Cassazione, Sezione sesta, 30 marzo 1998, Scepi). D’altra parte, hanno
puntualmente osservato i giudici a quibus, «l’incertezza che ha imposto
l’adozione della formula di cui all’articolo 530, comma 2, Cpp, costituisce la
migliore riprova dell’impossibilità di far discendere dall’assoluzione dì MAGGI
Carlo Maria e ZORZI Delfo quella dì DIGILIO Carlo»,
non appellante e prosciolto in primo grado per prescrizione.
L’assunto è del tutto condivisibíle,
posto che, in tema di valutazione della prova, la confessione, pur soggetta
come tutte le prove orali alla verifica di attendibilità,
non subisce le limitazioni di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 192 Cpp
e non ha, quindi, bisogno di riscontri esterni (Cassazione, Sezione prima, 13
gennaio 1997, Savi): derivando da ciò il corollario per il quale, pur nella
unicità della fonte dichiarativa, ben possono subire epiloghi valutativi
differenziati le narrazioni contra se rispetto a quelle contra alios, cosi da
rendere i risultati (negativi) conseguiti per queste ultime non automaticamente
traslabili quanto alle prime, e caratterizzare, dunque, come “personali” le
corrispondenti censure. Sotto altro profilo, ed a proposito, poi, della insussistenza di preclusioni derivanti dal giudicato
in ordine alla possibilità di rivalutazione dei fatti in ordine alla posizione
di altri soggetti, concorrenti in quegli stessi fatti, questa Corte ha in più
occasioni avuto modo di evidenziare che il giudicato penale formatosi nei
confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a
rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati
quali concorrenti nel medesimo reato; il che comporta, tra l’altro, che,
qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del separato
procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può
sottoporre a rivalutazione il comportamento dell’assolto, all’unico fine ‑
fermo il divieto del ne bis in idem a tutela della posizione dì costui ‑
di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell’imputato da
giudicare (Cassazione, Sezione prima, 16 novembre 1998; Cassazione, Sezione
quinta, 31 ottobre 1995, Gavìnelli). Il che, fra l’altro, ha consentito ai
giudici del merito di operare legittimamente una ampia
rivisitazione delle posizioni e degli elementi riguardantì persone già imputate
e poì assolte in ordine alla strage di Piazza Fontana, al fine di scandagliare
in un contesto unitario ‑ e non parcellizzato, come invece denunciano i
ricorrenti ‑
il materiale già acquisito nelle precedenti sedi processualí e le nuove
acquisizioni probatorie. Ragione in più, quindi, per escludere alla radice
qualsiasi contraddizione nell’aver, da un lato, non inciso sulle statuizioni
riguardanti la posizione del DIGILIO, per come definita nel, primo
grado di giudizio e senza che la relativa tematica avesse formato oggetto di
devoluzione in appello, e, dall’altro, di aver ritenuto caratterizzata da
“prova incompleta” la posizione di ZORZI e MAGGI (pag. 609 della sentenza
impugnata), con la conseguente determinazione assolutoria pronunciata a nonna
dell’articolo 530, comma 2, del codice di rito.
Altro (e connesso) aspetto sul
quale sì sono particolarmente concentrate le
doglianze, tanto del procuratore generale che dei difensori delle parti civili,
riguarda la pretesa svalutazione che avrebbe caratterizzato la delibazione da
parte dei giudici a quibus dei rapporti che si sarebbero intessuti, prima del
dicembre 1969, tra il gruppo di ordinovisti di Venezia e Mestre, da un lato, e
quello padovano, facente capo, fra gli altri, a FREDA e VENTURA, dall’altro, e
della conseguente contraddizione ìn cui quegli stessi giudici sarebbero caduti
nell’affermare la responsabilità degli stessi FREDA, VENTURA e DIGILIO per vari
attentati,’ivi compresa la strage del 12 dicembre 1969, e nel distinguere, poi,
agli effetti di quest’ultimo delitto, il gruppo padovano da quello di Venezia‑Mestre;
e ciò. malgrado che di quest’ultimo facesse parte
proprio il DIGILIO, oltre al MAGGI ‑qualificato, addirittura, come
responsabile di O.N. per il Triveneto ‑ e lo ZORZI, quale altro
elemento di spicco. Prescindendo dalle consistenti digressioni nel merito e da
talune incursionì negli atti processualí che contrassegnano le doglianze dei
ricorrentì a proposito dell’indicato “capitolo” della sentenza impugnata, il
comune motivo di ricorso, formalmente evocativo del
vizio di motivazione, mira essenzialmente a stigmatizzare la pretesa opera di
“frantumazione” che i giudici dell’appello avrebbero condotto circa la valenza
probatoria da annettere ‑ nel reciproco intrecciarsi (e rafforzarsì) degli
indizi ‑
al materiale promanante dalle fonti direttamente acquisite nel corso del
processo, e dalle risultanze scaturite dalle plurime e pregresse vicende
processuali, orinai tutte irrevocabilmente conclusesi. Da qui, l’esigenza di
somministrare o comunque proporre una “rilettura”, sia
pur sintetica, dì tutti quegli elementi, che ‑ deducono i ricorrentì ‑
soltanto ìn una disamina coerente e complessiva, possono ricevere una appagante
collocazione in termíni di convergenza o ‑ all’inverso ‑
di neutralizzazione probatoria.
Cosi, nel ricorso del procuratore
generale, si contesta la tesi “minimalista” dei giudici dell’appello ‑
secondo la quale i rapporti tra i due gruppi
ordinovistì dì Padova e Venezia‑Mestre sarebbero stati accertati, ma non nelle
dimensioni ‘3quafitative” indispensabili per ritenere dimostrata una comune
volontà nei tragici fatti dei dicembre 1969 ‑ proponendo tutta una serìe di
dati “di fatto” che smentirebbero quell’assunto, ed osservando, in particolare:
che entrambi i gruppi disponevano di armì ed esplosivo; che FREDA e VENTURA
avevano già realizzato gli attentati ai treni per i quali erano stati
condannati a Catanzaro; che vi era già stato il convegno alla White Room di
fondazione dì Ordine Nuovo, al quale avevano partecipato anche FREDA, per
Padova, e MAGGI, ZORZI e SICILIANO per Venezia; che era stato proprio SICILIANO
a dire che la strategia di Ordine Nuovo “comprendeva anche azioni annate contro
lo Stato, eliminazione fisica dell’avversario politico e attentati con bombe e
ordigni analoghi,,; che, infine ‑sottolinea il ricorrente
pubblico ministero ‑ la natura eversiva di O.N. e quindi dei vari gruppi
che la componevano risulta anche dal fatto che lo stesso fu sciolto il
21.11.1973 con decreto dei Ministro dell’Interno, a seguito della sentenza
redatta dal giudice Occorsio, che pagò con la vita questa sua decisione”.
Queste ed altre circostanze sarebbero state dunque erroneamente trascurate dai
giudici a quibus, che pertanto, sullo specifico profilo che viene qui in discorso, avrebbero svolto una motivazione in parte
lacunosa ed in parte contradditoria ed íllogica. Altrettanto analitica è stata,
in proposito, la disamína condotta anche dalle parti civili ricorrenti ‑in
particolare, quella sviluppata nella impugnazione
proposta per il Comune di Milano ‑ ove, oltre a puntualizzarsi i
vari elementi di “collegamento” fra i gruppi di Padova e quello di Venezia‑Mestre,
sulla base delle circostanze già evidenziate nella sentenza di primo grado, si
sottolineano i “fatti” e le “dichiarazioni” da cui dovrebbe dedursi ‑
quanto meno sul piano logico ‑ una risultante strategica comune assai meno
evanescente e problematica di quella evocata dai giudici dell’appello; ciò
anche per le caratteristiche organizzative che contraddistinguevano, all’epoca
dei fatti, la struttura di OX; gli incarichi ed i ruoli svolti in seno a tale
movimento dai personaggi coinvolti ‑ MAGGI responsabile del
Triveneto; DIGILIO “quadro coperto” e armiere del gruppo di Venezia; FREDA e
VENTURA, riconosciuti colpevoli, facenti parte dei gruppo padovano, anch’esso,
dunque, veneto ‑
e la stessa lettura “dìacronica” dì specifici episodi e soggetti ad essi
partecipi, plasticamente descritta dal ricorrente Comune di Milano ìn apposite
“tabelle” riepilogatíve.
La tematica
che i ricorrenti agitano presenta, all’evidenza, anche in questo caso, margini
di notevole suggestione, giacchè, ove al coacervo degli elementi e delle
considerazioni che la sentenza di primo grado ha dedicato per analizzare
l’epoca e la natura dei rapporti che si erano potuti accertare fra i vari
personaggi coinvolti nella vicenda processuale e, soprattutto, fra i diversi
nuclei ordinovisti presenti ed operanti, in specie, nel Veneto, i giudici
dell’appello si fossero limitati ‑ come deducono i ricorrenti ‑
ad una semplice operazione l’acritica” dì disarticolazione di quegli elementi e
considerazioni, per neutralizzarne, poi, i risultati complessivi, le doglianze
proposte nei ricorsi aprirebbero senz’altro uno spazio al riesame della
coerenza intrinseca e della sufficienza argomentativa dei tessuto
motivazionale. Ma basta poco per avvedersi di come ‑ al
di là di qualsiasi apparente suggestione, e della intrinseca opinabilità
che contrassegna qualsiasi operazione logica di “interpretazione” di fatti e
acquisizioni tanto complesse e stratificate ‑ la sentenza di appello non si
sìa affatto limitata ad una apodittica frantumazione dell’ìmpìanto accusatorio,
ma si sia, al contrario, meticolosamente concentrata nel rivalutare (anche alla
luce, ovviamente, delle critiche e delle censure difensive e delle nuove
acquisizioni operate nel corso del giudizio di appello) l’intera gamma degli
elementì postì a base del giudizìo rassegnato dai primi giudici sullo specifico
aspetto che viene qui in discorso: e tutto ciò ‑ va subìto detto ‑
senza quelle lacune o, peggio, “travisamenti”, che alcuni dei ricorrenti hanno
preteso di intravedere.
La sentenza impugnata, infatti,
dopo aver analíticamente passato in rassegna ‑seguendone l’iter logico‑ricostruttivo,
secondo un percorso dì rivalutazione critica condotta alla stregua e sulla
falsariga delle specifiche censure proposte dagli appellanti ‑
l’ampía dísamina svolta dai primi giudici in ordine alla
esistenza di una struttura eversiva facente capo alla organizzazione O.N. ed
operante essenzialmente nel Veneto nel 1969 (v. pagg. 442 e segg. della
sentenza dì primo grado), è pervenuta malgrado le
opposte tesi difensive ‑ ad una conclusione del tutto sovrapponibile a
quella già rassegnata al riguardo in prime cure: vale a dire che, tenuto conto
dei vari apporti dichiarativi raccolti o comunque acquisiti nel processo, e
delle enunciazíoni già poste a fondamento delle varie sentenze occupatesi in
passato della strage e di altre vicende riconducibili agli ambienti
ordinovisti, dovesse ritenersi assodato che «a Padova fu costituito, nell’alveo
di Ordine Nuovo, un gruppo eversivo capitanato da FREDA e VENTURA e che ad esso
vanno attribuiti una serie di fatti delittuosi consumati nel 1969, tra i quali
campeggiano gli attentati ai treni dell’agosto» (pag. 247 della sentenza
impugnata). Ma v’è di più. Anche sul punto specifico
delle responsabilità individuali, sia pure in chiave meramente “,storica” e di valutazione incidentale, l’approdo dei
giudici di secondo grado non si è discostato di molto dai “rìsultatì” della
indagine condotta in primo grado. Dopo approfondito esame, ìnfattì, delle varie
acquisizioni già valorizzate dai primi giudici, anche
la Corte dell’appello ha ritenuto di «dover, in definitiva, condividere
l’approdo cui la Corte di assise di Milano, peraltro in termini più impliciti
che espliciti, è pervenuta in ordine alla responsabilità di FREDA Franco e
VENTURA Giovanni per i fatti del 12 dicembre 1969, pur avvertendo che tale
conclusione ‑
cautamente puntualizza la sentenza impugnata ‑ oltre a non poter provocare
… effetti giuridici di sorta nei confronti di costoro, irrevocabilmente
assolti dalla Corte di assise di appello di Bari, è frutto di un giudizio
formulato senza poter disporre dell’intero materiale probatorío utilizzato a
Catanzaro e Bari». Ebbene, pure con tali limiti e nella circoscritta
prospettiva dell’accertamento delle responsabilità di MAGGI, ZORZI e ROGNONI,
enunciata dalla accusa nella forma del “concorso ‑
appunto ‑
con Freda Fanco e Ventura Giovanni”, il giudizio circa la responsabilità di
FREDA e VENTURA in ordine alla strage dì Piazza Fontana, afferma la sentenza
impugnata, «non può che essere uno: il complesso indiziario costituito dalle
risultanze esaminate, a cominciare dall’accertamento delle responsabilità
irrevocabilmente operate dalle Corti di assise di Catanzaro e Bari per finire
con le dichiarazioni di Fabrìs, Lorenzon, Comacchio e Pan, con particolare riferimento
al secondo, fornisce a tale quesito una risposta positiva» (v. la sentenza di
appello a pag. 399). Logico, quindi, alla stregua di tale univoco approdo, il
tentativo dei ricorrenti di valorizzarne al massimo il portato “dimostrativo”,
per avvalorare l’assunto ‑ contrario alla tesi sostenuta dai giudici di
secondo grado ‑
secondo il quale, evocandosi comunque rapporti tra la
cellula padovana (nella quale operavano, appunto, coloro che sono stati
riconosciuti come responsabili della strage) ed il nucleo ordinovista di
Venezia‑Mestre,
nel quale erano presenti, in posizione apicale, MAGGI e ZORZI, e attorno al
quale ruotava anche il “quadro coperto” DIGILIO, reputato “non estraneo” ai
fatti, ne derivava un sensibile rafforzamento della ipotesi accusatorìa, avuto
riguardo alle convergenze strategico‑operatíve che i primi giudici
avevano ritenuto di intravedere tra quei due gruppi. Ma l’assunto, certo
praticabile in linea astratta, e dei tutto coerente
anche sul piano logico (i tragici fatti del 12 dicembre 1969 non avevano
infatti rappresentato una “scheggia impazzita”, ma il frutto di un coordinato
“acme” operativo iscritto ‑ secondo le pacifiche acquisizioni evocate
concordemente dai giudici di entrambi i gradi di merito ‑ in un programma
eversivo ben sedimentato, ancorchè di oscura genesi, contorni e dimensioni),
non ha trovato positiva conferma sul piano probatorio, alla luce dei rilievi ‑
tutti dotati di incontestabile rigore logico ‑ svolti nella sentenza di
secondo grado.
Un rilievo evidentemente di primo
piano è stato assegnato, per la ricostruzione dell’epoca e della “intensità”
(qualitativa e quantitativa) dei rapporti tra i due gruppi alle dichiarazioni
rese da Martino SICILIANO, il quale fu esaminato in
dibattimento nel corso del giudizio di appello. Questi ‑ ricorda la
sentenza impugnata ‑ nel confermare sostanzialmente quanto riferito nel
corso delle indagini preliminari, aveva precisato che sia lui che ZORZI avevano partecipato ad alcune riunioni tenute nel
retrobottega della libreria Ezzelino a Padova (ove erano solite incontrarsi le
persone che appartenevano al gruppo locale che faceva riferimento ad Ordine
Nuovo e che vedeva proprio in Franco FREDA il personaggio di spicco), cosi come
FREDA, dal canto suo, si era portato alcune volte a Venezia, presso la sede di
Via Mestrina: tuttavia, soggiunge la sentenza, «da tutto ciò…non era seguita,
neppure in seguito, una vera e propria confluenza del gruppo di Padova in
Ordine Nuovo, in quanto TREDA voleva una sua collocazione … voleva essere il
duce del movimento” (pag. 254 della sentenza). D’altra parte, la stessa
sentenza rammenta come la difesa di AUGGI avesse fatto
riferimento alla decisione a suo tempo adottata da questi nella sua qualità di
responsabile di Ordine Nuovo per il Triveneto di espellere da quel sodalizio
Proprio FREDA, che da allora aveva organizzato un proprio gruppo; mentre la
tensione esistente tra i due era testimoniata da Casalini Gianni, il quale
aveva testualmente affermato che «Con MAGGI, FREDA era in una sorta di avversione personale. FREDA ne parlava male e non voleva
prendere ordini da lui … non poteva soffrire MAGGI … (gli) era
antipaticissimo … ce l’aveva con MAGGI» (v. sentenza
Pag. 253). Quindi, la principale voce collaborativa del processo, oltre a non
asseverare direttamente l’esistenza di programmi operativi specifici cogestiti
dai due gruppi, accreditava il nucleo padovano di una sfera di
autonomia “gestionale”, e se si vuole strutturale, non intravedendo in
esso una componente organica del movimento, quanto meno secondo gli auspici e
le aspirazioni personalistiche di FREDA. Ma al di là di
ciò, i giudice dell’appello, dopo aver esaminato funditus le dichiarazioni
dibattimentali del SICILIANO, giungevano ad un meditato ‑ e motivato ‑ridimensionamento
del relativo apporto, proprio sul versante della chiarificazione di quali
fossero i rapporti tra i due noti gruppi nel periodo antecedente la strage,
osservando, in particolare, che il collaboratore si era «limitato a: accennare
alquanto vagamente, e comunque solo in…sede di appello, a contatti risalenti
a ben prima del 1969; riferire genericamente di un’evoluzione nei discorsi e
nelle strategie di FREDA, dapprima “teoriche e dimostrative” e poi di tipo
“stragistá”, senza peraltro ulteriori specificazioni se non accenni ad
“attentati ai treni” ed anche (particolare, peraltro, versato solo negli
interrogatori istruttori) in altri “luoghi frequentati dal pubblico, come
banche, uffici postali, stazioni”; chiarire che, dello specifico progetto di
FREDA di compiere attentati ai treni, aveva avuto personale e diretta contezza
in una sola riunione presso la libreria Ezzelìno; precisare che, comunque,
aveva partecipato solo a parte delle riunioni tenutesi presso la libreria
Ezzelino, avendo per il resto sentito parlarne dagli altri veneziani presenti,
ed in particolare da ZORZI». Da qui la conclusione di ritenere che « … il
principale elemento di accusa in ordine alla
sussistenza, prima dei fatti del 12.12.1969 da un canto di un programma volto a
progettare, dopo gli attentati ai treni, ulteriori e più significativi atti
terroristici da parte del gruppo di Padova, e, dall’altro, e soprattutto, al
coinvolgimento in tale eventuale ed ulteriore delittuoso programma del gruppo
di Venezía‑Mestre
(dovesse) essere ridímensionato», proprio alla luce di una coerente lettura di
quelle dichiarazioni, in una con le altre acquisizioni processuali.
Conclusioni, quelle riferite, filtrate (e suffragate)
anche alla luce delle varie altre fonti di prova evocate dai primi giudici e
che, seppure in parte, sono state ricordate anche dai ricorrenti: vale a dire
le dichiarazioni di Vianello, Campaner Giuliano, Boratto Giuseppe, Siciliano
Franca, Casalini Gianni, Romani Gastone, Giannettini, ed altri ancora, ed il
cui contributo ha formato oggetto di puntuale e motivata disamina da parte dei
giudici a quibus.
Posto, dunque, che l’accertamento
della natura e della intensità dei rapporti tra gli
orinai noti gruppi di Padova e di Venezia‑Mestre non doveva essere
condotto al fine di suffragare (come, al contrario, sembrano presupporre i
ricorrenti) l’esistenza di una semplice relatio “associativa”, sia pure di tipo
terroristico‑eversivo,
tra i due gruppi, ma la programmazione e realizza ione “in comune” degli
specifici e tragici episodi delittuosi del dicembre 1969, la coerenza del
percorso logico‑argomentativo
che caratterizza la sentenza impugnata, la correttezza (e accuratezza) nella
delibazione dei materiale di prova, e la assoluta esaustività degli apporti
motivazionali sui principali e qualificanti aspetti, rende dei tutto esente da
censure il provvedimento, quanto meno sul piano del circoscritto sindacato
ritualmente devolvibile a questa Corte. Deve infatti
sottolinearsi a questo riguardo ‑ essendo stati MAGGI e ZORZI
assolti nella sentenza impugnata a nonna dell’art. 530, comma 2, Cpp ‑
che il controllo affidato alla Corte di cassazíone sulla struttura e sulla
congruenza logica della motivazione ìnvolge anche l’osservanza del principio
dell’«oltre ragionevole dubbio», che non può dirsi certamente rispettato quando
la pronuncia di condanna si fondi su un accertamento giudiziale non sostenuto
dalla certezza razionale, ossia da un grado di conferma cosi elevato da
confinare con la certezza. Il principio dell’«oltre il ragionevole dubbio»
rappresenta, infatti, il limite della libertà di convincimento del giudice, apprestato dall’ordinamento per evitare che
l’esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi,
confinanti con l’arbitrio (Cassazione, Sezione prima, 14 maggio 2004, Grasso).
Nel quadro
della comune censura di manifesta illogicità della motivazione, il
procuratore generale e l’Avvocatura distrettuale dello Stato, sulla base di
considerazioni del tutto analoghe e convergenti, denunciano come “assolutamente
inutile”, contraddittoria e inconferente, ai fini della verifica della
attendibilítà della fonte, la lunga disamina condotta nella sentenza impugnata
in merito alle dichiarazioni rese dal DIGILIO circa la sua pretesa appartenenza
alla rete informativa statunitense. In realtà,
segnalano i ricorrenti, i giudici di primo grado avevano correttamente
affrontato la questione facendo essenzialmente leva su quelle che apparivano
essere state le plausibili motivazioni dei racconti
del DIGILIO al riguardo, affertnando, appunto, che il preteso inserimento di
questi nei servizi americani doveva ‑ secondo la prospettiva dello
stesso DIGILIO ‑
consentire al collaboratore “di accreditarsi come un testimone, piuttosto che
come protagonista, dei fatti eversivi che andava riferendo”. Un assunto,
questo, che ‑
sempre secondo ì ricorrenti ‑ sarebbe stato condiviso nella sentenza impugnata,
la quale espressamente dichiara di concordare con l’interpretazione del
“movente” di quelle dichiarazioni offerto dalla sentenza di primo grado; ma che
poi, contraddittoriamente, viene smentito, nella parte
in cui i secondi giudici reputano di dover utilizzare la verifica negativa
circa le dichiarazioni inerenti alla presunta appartenenza alla rete informativa
americana, come «un rilevante parametro
per verificare l’attendibilità in genere di DIGILIO, anche se i fatti
contestati (nel) processo non (erano) intimamente connessi con quella». E tutto
ciò ad onta ‑
sottolinea il procuratore generale ‑
delle «elementari regole interpretative elaborate dalla giurisprudenza sulla
frazionabilità delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità, per cui la
eventuale non attendibilità di una parte del racconto non coinvolge
necessariamente il tutto».
Simili rilievi sono
però palesemente destituiti di fondamento, perchè, da un lato, non v’è
contraddizione alcuna nel ravvisare in uno schema di autodifesa la ragione di
un narrato in ipotesi “falso” e nel desumere, poi, valutazioni conseguenti in
punto di credibilità della fonte; dall’altro, perchè, in tanto è pertinente
evocare la possibilità di procedere ad una valutazione frazionata della
chiamata in correità, in quanto i singoli “frammenti” in cui si articola il
tessuto dichiarativo presentino fra loro connotati di autonomia contenutistica
e logica tale da ammetterne un apprezzamento separato. La cosiddetta
valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da chiamate
in correità, infatti, per la quale l’attendibilità del dichiarante, anche se
denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con
riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del
riscontro, in tanto è ammissibile, in quanto non esista una interferenza
fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti
che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate. Interferenza
‑
si è Puntualizzato ‑ che peraltro si verifica
soltanto quando, come si è gia accennato, fra la prima parte. e le altre esista un rapporto di causalità necessaria,
ovvero quando l’una sia imprescindibile antecedente logico dell’altra
(Cassazione, Sezione prima, 18 dicembre 2000, Orofino; v., anche, Cassazione,
Sezione sesta, 2 febbraio 2004, Agate). Negare, quindi, che fra la inattendibile “presa di distanza” che il dichiarante
tenti di frapporre tra se medesimo e i fatti descritti, e la sua narrazione che
coinvolga altre persone in quegli stessi fatti, sussista una logica (ed
ontologica) correlazione sul piano del giudizio di (inscindibile) affidabilità,
equivale ad impedire al giudice un sindacato effettivo sulla prova, per
“spezzettarne” lo scrutinio in tanti segmenti quante sono le frazioni di essa
che le parti intendono utilizzare. Operazione, questa,
evidentemente preclusa, con l’ovvia conseguenza di rendere del tutto
incensurabile l’opposta ‑ e contestata ‑determinazione assunta,
al riguardo, dai giudici a quibus. Deve infatti
ritenersi del tutto corretta la analitica rivisitazione ‑ peraltro
doverosamente postulata dalle specifiche doglianze degli appellanti ‑
condotta in merito alla pretesa appartenenza della fonte ai servizi informativi
americani, con un epilogo del tutto negativo circa «la concordanza interna ed
esterna del narrato» e talvolta addirittura con l’emersione di «insanabili
contrasti rispetto ai dati obiettivi» (formula ellittica per definire “false”
alcune circostanze riferite); così come corretto è l’assunto secondo il quale,
un così radicale «giudizio negativo sulla attendibilità del DIGILIO» non
potesse non riverberarsi anche sul versante delle relative dichiarazioni erga alios.
D’altra parte, la sentenza impugnata non ha mancato di sottolineare
che «nel caso del DIGILIO, più che di un ritardo ad ammettere le proprie
responsabilità, si deve, quanto meno per i fatti dei 12.12.1069, parlare di una
sostanziale mancanza di confessione, tale non potendosi qualificare il mero
racconto di aver ispezionato ordigni, genericamente destinati a Milano, per
controllarne l’efficienza e la sicurezza»; derivandone da ciò ‑e
dalla disamina dell’intero percorso dichiarativo ‑ il motivato convincimento per
il quale il comportamento processuale del collaboratore fosse «stato
condizionato dalla tutela di un suo preciso interesse processuale: il che ‑
hanno esattamente osservato i giudici dell’appello ‑ non può non
intaccare l’attendibilità del dichiarante» (v. pag. 546 della sentenza
impugnata). La conclusione, d’altra parte, è ulteriormente corroborata dalle
consonanti valutazioni espresse a proposito di altre
vicende, pur evocate dai ricorrenti per trarne da esse spunti dì opposta
valenza. Così, del tutto inattendibili sono state
reputate le dichiarazioni rese dal DIGILIO a proposito dell’attentato
all’Ufficio istruzione di Milano del 24 luglio 1969, essendo «egli caduto …
in inescusabili incoerenze con la realtà storicamente accertata», oltre ad
esser stato platealmente smentito su aspetti di essenziale rilievo riflettenti
fatti dal medesimo asseritamente compiuti, con la conseguenza di far ritenere
quelle dichiarazioni come insanabilmente in contrasto con i dati obiettivi.
Fatto reputato ancor più grave, essendosi il collaboratore deciso a parlare di
quella vicenda «a distanza di anni dall’inizio della
sua collaborazione, e solo per reazione ad un’intervista giornalistica in cui
la sua Autorità giudiziaria di riferimento aveva espresso convinzioni non
interamente collìmantí con quanto eglì era andato sino a quel momento ad essa
riferendo» (v. pag. 321 della sentenza impugnata). Prescindendo, poi, da quanto
di osserverà a proposito degli episodi più significativi
(Paese e Canal Salso), assume risalto di non poco momento ‑
sempre nella prospettiva della verifica della attendibilità del dichiarante ‑
la disamina condotta nella sentenza impugnata circa l’incontro asseritamente
avuto dal DIGILIO con il MAGGI all’ínizio del dicembre 1969: incontro nel corso
del quale il MAGGI gli avrebbe detto che «da Il ad una settimana circa, vi
sarebbero stati dei grossi attentati, per cui, in vista di reazioni ai danni
degli appartenenti alla loro area politica, era opportuno annotarsi le proprie
vicende giornaliere onde potere, all’occorrenza, allegare un alibi», e che di
ciò il DIGILIO avrebbe dovuto avvisare anche i “ragazzi”. Lungi dal valere ‑
come pretenderebbero i ricorrenti ‑ come importante elemento di
riscontro probatorio, la vicenda è stata sottoposta a puntuale verifica da
parte dei giudici dell’appello, con approdi valutativi del tutto antitetici,
avendo questi motivatamente ritenuto (sulla base, anche di elementi
obiettivi) che le dichiarazioni dei collaboratore presentassero «insuperabili
elementi, vuoi di ínverosimiglianza che di incoerenza esterna», fino a
concludere che lo stesso DIGILIO avesse addirittura «riferito circostanze non
vere in punto data di allontanamento e rientro di MAGGI». Ancora una volta,
quindi, traspaiono elementi di accertata falsità del
dichiarato, difficilmente circoscrivibili nel ristretto alveo di singoli
episodi, avuto riguardo all’importanza ed alla significatività che quelle
vicende rivestivano nel contesto globale della narrazione. Non senza
trascurare, sempre sul piano delle incoerenze esterne, «che l’incarico di
contattare e mettere in allarme gli altri appartenenti del gruppo di Ordine Nuovo di Venezia‑Mestre non poteva essere stato
da MAGGI affidato proprio a DIGILIO Carlo, notoriamente “quadro coperto” dello
stesso» (v. pag. 434 della sentenza impugnata). Non dissimili, d’altra parte,
sono le conclusioni cui la Corte di assise di appello
è pervenuta in rapporto agli incontri che il DIGILIO avrebbe avuto con lo ZORZI
dopo la strage, avuto riguardo alla palesi smentite che la fonte aveva ricevuto
a proposito della asserita consegna del calco della chiave della cella di
VENTURA per farlo fuggire dal carcere, e delle inspiegate, altalenanti
“,confessioni” ricevute dallo ZORZI, una volta partecipe materiale
dell’attentato alla Banca Nazionale della Agricoltura a Milano e altra volta
autore materiale dell’attentato alla Banca Nazionale del Lavoro a Roma (v.
pagg. 491’ segg.): evenienze, tutte, che la sentenza impugnata analizza, con
critico rigore, pervenendo a logiche conclusioni di inattendibilità,
per la verità neppure seriamente contestate, su tali specifici aspetti, dai
ricorrenti.
In tutti i ricorsi delle parti
civili ed in quello del procuratore generale, la motivazione della sentenza
impugnata è aggredita sul piano della relativa coerenza logica con specifico
riferimento a quelli che sono stati reputati, in primo grado, gli snodi
cruciali sui quali si è fondato il giudizio di responsabilità penale, poi
ribaltato in appello: snodi fra i quali assume un
risalto centrale quello relativo ai cosiddetti accessi nel casolare di Paese,
posto che ‑
come esordisce in proposito il ricorrente procuratore generale ‑
tutte le dichiarazioni rese sul punto dal DIGILIO «sono rilevanti sia per
quanto attiene alla responsabilità sua, di MAGGI e di ZORZI per Piazza Fontana
e sia per quanto attiene alla loro collaborazione con il gruppo dì Padova per
gli attentati ai trení». La decisione impugnata viene in particolare fatta
oggetto di censura perchè valorizzarebbe, in chiave di incostanza,
il ritardo con cui DIGILIO avrebbe riferito i fatti più importanti; quando,
invece, sin dai primi interrogatori, tutti antecedenti all’ictus di cui era
rimasto vittima, aveva fornito gli elementi essenziali per essere ritenuto
coinvolto. La stessa pronuncia, al contrario, non avrebbe dato il giusto
rilievo alle numerose testimonianze ed agli altri elementi che potevano fungere
da riscontro alle dichiarazioni rese dal collaboratore, mentre si sarebbe
limitata a dedurre la inattendibilità della narrazione
del DIGILIO “solo per il fatto ‑ osserva l’Avvocatura dello Stato ‑
che non si sia riusciti a trovare detto casolare a distanza di oltre 30 anni”.
Anche su tale vicenda, davvero
centrale, le doglianze dei ricorrenti ‑ tese
a contestare la logicità della motivazione e mai la relativa carenza, a
testimonianza dell’approfondimento argomentativo con cui la sentenza di appello
ha dato atto dei relativi apprezzamenti in punto di prova ‑
si rivelano per taluni aspetti palesemente infondate,
mentre sotto i restanti profili addirittura inammissibili, perchè evocative di
rilievi di puro fatto. In una diffusa ricostruzione di tale articolata vicenda,
la sentenza di appello ha infatti meticolosamente
ricomposto ‑
secondo una linea di assoluto rigore logico ‑ la sequenza degli accessi
compiuti da DIGILIO presso il fantomatico casolare di Paese, seguendone le
evoluzioni dichiarative, le epoche (non poco variegate) di riferimento, le
presenze dei soggetti chiamati in causa dalla fonte, le dichiarazioni
testimoniali evocate a conferma o smentita di quel complesso tessuto narrativo,
le ragioni stesse del “dire” o del “tacere” che hanno contrassegnato la storia ‑
certo non lineare ‑ del contributo collaborativo, fino alla più recente
(e compromettente) versione, alla luce, anche, delle contestazioni mosse dalle
difese degli imputati. Anzitutto, i giudici dell’appello hanno sottolineato come il gravissimo ritardo con cui DIGILIO ebbe
a riferire del terzo accesso a Paese ‑ a distanza di oltre tre anni da quando aveva parlato del casolare
di VENTURA utilizzato come covo di armi ed esplosivo ‑ e che di per se
rendeva «gravemente viziato sotto il profilo della costanza nel tempo» il suo
narrato, non poteva trovare spiegazione nella circostanza evidenziata nella
sentenza di primo grado: e cioè che, col parlare del terzo accesso, DIGILIO
avrebbe ammesso la sua responsabilità negli attentati ai treni e poi, con la
narrazione di Canal Salso, nella strage. Da un lato, infatti ‑
sottolinea la sentenza di appello ‑
DIGILIO non ha mai direttamente confessato la propria responsabilità in quei
fatti; dall’altro, anche dopo aver riferito del terzo accesso a Paese, «ha
preferito continuare a ritagliarsi un ruolo, più che di partecipe, di
“osservatore spinto da un incarico di intelligence, e, quindi, non si è allora
verificato quell’evento catartico che avrebbe costituito, nell’interpretazione
della sentenza impugnata, il necessario substrato logico di
quell’interpretazione. Dunque ‑ concludono sul punto i
giudici a quibus ‑ il narrato di DIGILIO appare gravemente viziato
sotto il profilo della costanza nel tempo e la sentenza (di primo grado), che
pure ha ammesso che il ritardo era una “evidente incongruenza del racconto” del
collaboratore, ha dovuto compiere, per superare il dato, un puro atto di fede»
(pag. 413).
Incoerenza nel tempo, nei
riferimenti soggettivi e nei fatti percepiti e direttamente vissuti (soltanto
nel terzo accesso si parla, con dovizia di dettagli tecnici, degli ordigni
destinati agli attentati ai treni) che, negletti in primo grado, hanno invece
ricevuto una rilettura dei tutto ‘1ogica” da parte dei
giudici dell’appello, evidentemente attenti a rifuggire da qualsiasi apodittica
“spiegazione” di aporie narrative tanto evidenti.
Anche
sullo specifico tema della “esistenza del casolare” i rilievi della sentenza
impugnata ‑
come si è accennato, vivacemente resistiti dai ricorrenti ‑
sfuggono alle prospettate censure di manifesta irragionevolezza. Se da un lato,
infatti, è in sè plausibile ‑ come ha sottolineato, fra
gli altri, l’Avvocatura dello Stato ‑ che a distanza di tanti anni
DIGILIO non avesse trattenuto memoria della ubicazione del casolare e non
avesse cosi potuto fornire indicazioni utili al rintraccio dell’immobile, non
possono tuttavia sottacersi gli approfonditi rilievi svolti al riguardo nella
sentenza impugnata, sia in merito alle più che circostanziate descrizioni
offerte dal collaboratore circa la struttura anche interna dell’immobile e le
modalità per giungervi; sia in ordine a talune singolarità che avevano
contraddistinto le indagini di polizia sulla intera vicenda. Un contesto, dunque, nel quale il mancato reperimento del
casale (o delle sue tracce catastali o testimoniali) del tutto ragionevolmente
è stato valutato come un significativo elemento di “ncoerenza esterna rispetto
alla narrazione del collaboratore, il quale, malgrado tanta precisione
descrittiva di luoghi e percorsi, «non era stato in grado di indicare il luogo
ove sorgeva il casolare». Qualcosa di più e di diverso,
dunque, rispetto ad una circostanza totalmente “neutra!’ di mancato riscontro.
D’altra parte, l’analitico esame condotto dai giudici dell’appello in merito
alle varie testimonianze che avrebbero dovuto fungere
da riscontro alle dichiarazioni rese in merito al casale di Paese, ne hanno
rivelato la sostanziale inconsistenza probatoria, o per la totale genericità
dei vari riferimenti, o per la non sovrapponibilità dei contesti narrativi
(pag. 419 e segg.); al punto che il richiamo a tali fonti, effettuato dai
giudici di primo grado, è apparso in taluni casi addirittura inconferente.
Altro aspetto che ‑
secondo l’impugnata sentenza ‑ ha fortemente compromesso l’attendibilità della
narrazione del DIGILIO in merito al casale di Paese ed alle connesse
dichiarazioni afferenti il cosiddetto terzo accesso, ruota attorno alla asserita presenza di Lino FRANCO nella seconda visita
effettuata nel casale. Alla stregua, infatti, dei riferimenti temporali offerti
dal DIGILIO, la presenza del FRANCO, deceduto il 15 luglio 1969 a seguito di
una lunga malattia invalidante, doveva reputarsi impossibile,
stanti le precise dichiarazioni rese dalla vedova, a proposito delle
condizioni di salute e delle possibilità di movimento del marito, il quale sin
dal 1968 aveva “ … smesso di andare a scuola e … non poteva guidare la macchina
… perchè i piedi non avevano più il tatto, non sentiva più”. Posto, dunque,
che il secondo accesso al casolare di Paese al quale ‑ secondo DIGILIO ‑
avrebbe partecipato il FRANCO si era verificato (stando a quanto precisato
dallo stesso collaboratore) nel luglio del 1969, se ne doveva desumere che, a
quel momento, o il FRANCO era già deceduto, o si trovava comunque
in condizioni fisiche tali da non poter essere in grado di viaggiare sino a
Paese. Pertanto, dovendosi le dichiarazioni rese dalla vedova del FRANCO
reputare attendibili ‑ la sentenza impugnata ha, infatti, puntualmente ed
esaurientemente svilito le diverse valutazioni condotte dai primi giudici sul
semplice presupposto che la donna fosse mossa
dall’esigenza di salvaguardare la figura morale del marito ‑
ne derivava un elemento di palese contrasto rispetto alla affidabilità della
narrazione. Sicchè, i rilievi e le conclusioni svolte «in tema di costanza nel
tempo (ritardo) ed incoerenza esterna (esistenza del casolare, malattia di
FRANCO)», già di per se sono stati reputati, del tutto
coerentemente, fattori che impedivano «in radice di giudicare sul punto
affidabile il collaboratore» (pag. 421). Circostanze alle quali la sentenza
impugnata coniuga i gravi contrasti in cui DIGILIO sarebbe caduto nell’indicare
gli anni in cui gli accessi al casolare di Paese si sarebbero verificati; le
altrettanto altalenanti versioni circa i personaggi che sarebbero stati
presenti nelle varie occasioni; la notorietà di alcuni
dati “tecníci” sugli ordigni, già acquisiti nel corso dei procedimenti di
Catanzaro e Bari e sostanzialmente reiterati nelle dichiarazioni di alcuni
testi ‑
come nel caso di FABRIS (v. pag. 379) ‑ (donde, il “notorio
processuale” che non può fungere da elemento di riscontro), per giungere, all’epilogo
di tale articolato e coerente percorso, alla conclusione di inattendibìlità
e assenza di elementi di conferma. Ogni considerazione alternativa è dunque, in
se, operazione legittima, ma soltanto nell’alveo e nei confini di un giudizio
di merito: agli effetti dell’odierno scrutinio, invece, è del tutto evidente
come i puntuali rilievi svolti in sede di gravame, si rivelino, non soltanto
del tutto appaganti sul piano della coerenza argomentativa e del rigore logico,
ma anzi doverosi nel sottoporre ad attenta disamìna i difetti di attendibilità ‑ intrinseci ed estrinseci ‑
di un diluito e oscillante tracciato narrativo contrassegnato da non poca
disinvoltura. In tale contesto, e per concludere sul
punto, si rivelano del tutto sterili le doglianze proposte dal pubblico
ministero in ordine al fatto che la sentenza impugnata, pur avendo dato atto
delle risultanze scaturite dagli accertamenti peritali relativi alle
conseguenze patite dal DIGILIO a seguito dell’ictus che lo aveva colpito nel
maggio 1995, nell’esaminarne le dichiarazioni e gli interrogatori, «non
distingue tra quelli resi prima dell’ictus e tra quelli resi dopo; non
distingue ‑
soggiunge il ricorrente ‑ se le risposte date in controesame sono da
ritenersi date in situazione di affaticamento (dato facilmente riscontrabile
dalla durata dell’esame cosi come trascritto) o in situazioni di freschezza e
quindi di lucidità, con ciò operando una valutazione sicuramente superficiale
delle dichiarazioni medesime». Ma tale severa censura,
oltre che ingenerosa, avendo la sentenza impugnata lungamente e perspicuamente
affrontato il tema, si rivela incongrua sul piano del motivo dedotto
(agitandosi profili chiaramente di merito) e per di più appare essere
agevolmente ribaltabile in termini reciproci a quelli prospettati, giacchè in
ipotesi ‑
ben potrebbero essere state proprio le dichiarazioni rese in condizioni di
minor “freschezza!’ o “lucidita” ad aver supportato l’accusa nel giudizio di
primo grado.
Anche a proposito dell’altro
episodio centrale descritto dal DIGILIO, vale a dire l’incontro di Canal Salso,
i ricorsi del procuratore generale e delle parti civili sono concordi nel
prospettare vizio di motivazione, sotto il profilo della illogicità
e contraddittorietà e con accenni di travisamento delle risultanze processuali.
Il pubblico ministero, in particolare, lamenta che i giudici dell’appello avrebbero addirittura fondato talune affermazioni «su
documenti e atti non presenti nel processo», in quanto, con riferimento alla
parte della sentenza in cui si prospetta l’ipotesi della “circuitazione” della
notizia relativa al tipo di esplosivo asseritamente presente nella vettura del
MAGGI ‑
secondo le indicazioni dello ZORZI ‑ si osserva come le indicazioni
a suo tempo date allo stesso DIGILIO dai Carabinieri del R.O.S. circa il furto
di “ammonal” di Arzignano, non precisavano nè che il furto fosse avvenuto ad
opera di ZORZI, nè che ZORZI avesse conservato quell’esplosivo. Si lamenta,
poi, la circostanza che i giudici a quibus avrebbero
trascurato il particolare della presenza di una borsa sportiva nel
bagagliaio della vettura, che ‑ a dire del ricorrente ‑ avrebbe
rappresentato un particolare «determinante, perché in essa doveva
necessariamente essere contenuto quell’altro esplosivo che la Corte di primo
grado (aveva) con ampia e convincente motivazione ritenuto essere stato
aggiunto a quello visibile e visto da DIGILIO». Rilievi, questi ultimi, che
compaiono pure nel ricorso proposto nell’interesse dei Comune
di Milano, ove si sottolinea anche la mancata
valorizzazione dell’alibi falso fornito per quel periodo dallo ZORZI, e
la incongruenza di reputare le dichiarazioni del DIGILIO attendibili, quanto
alla responsabilità del dichiarante, ma inattendibili e non riscontrate per ciò
che attiene alle responsabilità delle altre persone coinvolte nella vicenda
dalla stessa fonte.
Le “questioni” agitate nei
ricorsi a proposito dell’incontro di Canal Salso, specie quelle dedotte dal
pubblico ministero, oltre che coinvolgere profili fortemente
intrisi di rilievi di merito, si rivelano,a ben guardare, eccentriche o
secondarie rispetto al nucleo della decisione impugnata, la quale, in parte
qua, offre ben altri elementi di giudizio in punto di attendibilità della fonte
e carenza di elementi di verifica. Da un lato, infatti, la questione della
natura dell’esplosivo asseritamente indicata dallo ZORZI, e la relativa
“interpretazione” offerta ‑ quanto ad ipotesi di “circuitazione” delle
conoscenze somministrate dal dichiarante ‑ nell’ampia motivazione
dispiegata sul punto nella sentenza impugnata, non si presta affatto alle
censure prospettate dal ricorrente procuratore generale. La sentenza impugnata,
infatti, riproduce esattamente il passo dell’interrogatorio cui il DIGILIO fu
sottoposto il 16 marzo 1995 da parte dei Carabinieri del R.O.S. e si da atto come da esso trasparisse che proprio gli
interroganti avevano informato lo stesso
DIGILIO del furto di “ammonal” compiuto ad Arzignano: sicché, la pregressa
“conoscenza” di quella sostanza e della relativa, implicita disponibilità da
parte dell’ “ambiente”, rendevano del tutto plausibile ‑ sul piano logico ‑
la deduzione svolta dai giudici a quibus. Deduzione, questa, alla quale il
ricorrente si limita a giustapporre null’altro che una contraria illazione, non
soltanto neutra sul piano della logica, ma certamente insuscettibile di
incrinare il più che solido e coerente apparato argomentativo sul quale si
fonda il motivato giudizio di inattendibilità del
DIGILIO. Quanto, poi, all’omesso esame del particolare relativo
alla borsa sportiva che sarebbe stata presente nel bagagliaio della
vettura dei MAGGI, l’assunto si presenta probatoriamente effimero, giacche
soltanto attraverso una operazione di tipo meramente congetturale si potrebbe
annettere a quel particolare “l’importanza” che i ricorrenti hanno ritenuto di
scorgervi‑
Una borsa della quale è ignoto il contenuto, la destinazione e le ragioni del
suo posizionamento in un certo luogo ed in un determinato contesto, non si vede
proprio, infatti, come e perchè avrebbe dovuto rappresentare un particolare da
“valorizzare” da parte dei giudici dell’appello, se non in forza di un rapporto
inferenziale che pretendesse di desumere il “possíbile” dall’ “ipotetico”.
Pure la questione relativa al cosiddetto “falso” alibi dello ZORZI ‑
relativo alla sua presenza a Napoli in quel periodo ‑ ed in ordine al
quale i ricorsi, tanto del procuratore generale che di tutte le parti civili,
si sono diffusi per desumerne una grave incoerenza nella sentenza impugnata,
non sembra affatto infirmare la linearità del decisum e la logicità della
motìvazione: e ciò sia per quanto attiene alla disamina della specifica vicenda
relativa all’incontro di Canal Salso, sia sul più generale versante della
“conferma” che quella pretesa falsità offrirebbe a proposito degli indizi di
responsabilità evocati a carico dello stesso ZORZI. Al riguardo, occorre qui ribadire che ‑ come costantemente affermato
dalla giurisprudenza di questa Corte ‑mentre il fallimento dell’alibi
non può essere posto a carico dell’imputato come elemento sfavorevole, non
essendo compito di quest’ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere
dell’accusa dì provarne la colpevolezza, l’alibi falso, cioè quello rivelatosi
preordinato e mendace, può essere posto in correlazione con le altre
circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive
risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla
giustizia. L’alibi falso, quindi, ben può, in ipotesi, fungere da elemento di
riscontro circa l’attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità,
a norma dell’articolo 192, comma 3, Cpp, ma siffatto
parametro di apprezzamento, tuttavia, va saldamente iscritto, nel panorama
delle singole vicende e delle specificità che caratterizzano ciascuna di esse;
sicchè, al giudice è senz’altro consentito di valorizza e la deduzione
dell’alibi falso come indizio da considerare nel complesso delle emergenze
processuali, ma senza trascurare, però, l’esame delle specifiche situazioni
obiettive, le quali, nella loro peculiarità, possono svuotare quel
comportamento della sua rilevanza probatoria negativa. Fermo restando, in ogni
caso, che, avuto riguardo alla presunzione di non colpevolezza che ‑
per espresso disposto costituzionale ‑ accompagna ogni cittadino sino
alla condanna definitiva, soltanto l’alibi sicuramente falso può essere
valutato come indizio a carico dell’imputato, mentre la mancanza di alibi, o il suo fallimento, sono probatoriamente neutri
(cfr, sui vari profili, e tra le tante, Cassazione, Sezione seconda, 4 febbraio
2004, Gallazzi; Cassazione, Sezione seconda, 22 marzo 1996, Arena; Cassazione,
Su, 21 ottobre 1992, Marino; Cassazione, Sezione prima, 18 maggio 1992,
Modica).
Alla stregua di tali principi,
emerge che i giudici dell’appello, pur essendo pervenuti ‑
all’esito di una analitica disamina delle
dichiarazioni rese dai testi Coglitore ed Arpaja, che avrebbero dovuto
asseverare la presenza napoletana dello ZORZI all’epoca dei fatti di Canal
Salso e della strage ‑ ad un giudizio di inattendibilità di tali
dichiarazioni, avuto riguardo ad un complesso di rilievi, interni ed esterni a
quelle narrazioni (pagg. 457 e segg. della sentenza impugnata), pur tuttavia
non si sono spinti ad affermarne la falsità, anche perchè, al fulcro del
reputato giudizio di inaffidabilità, è stata posta ‑ non la accertata
presenza altrove dello ZORZI in quel periodo ‑ ma, essenzialmente, la
circostanza che (al di là del sospetto ritardo con cui i due testimoni erano
intervenuti nel processo), taluni dei particolari descritti dai medesimi si ponevano
in Contrasto rispetto a quanto dichiarato dallo stesso ZORZI in occasione dei
suoi interrogatori resi a Parigi il 12 ed il 13 dicembre 1995. V’è quanto
basta, quindi, per far ritenere più che coerente, da un lato, l’apprezzamento di inattendibilità della versione rispettivamente offerta
dai “tardivi” testi a discarico; e, dall’altro, non ribaltabile tale giudizio
come indizio contro lo stesso ZORZI, non potendosi da quella inattendibilità
ritenere eo ipso provata la consapevole e preordinata falsità di quelle stesse
dichiarazioni.
Una minuziosa riproposizione
delle varie tematiche, lungamente dibattute in
entrambi i gradi di merito, e relative al tipo di esplosivo asseritamente visto
da DIGILIO a Canal Salso nella autovettura del MAGGI, ha, poi, formato oggetto
di, un apposito e diffuso motivo di impugnazione da parte del difensore delle
parti civili Luigi Passera ed altri. In tale motivo, pero, nel quale
formalmente si censura la sentenza di appello «per
manifesta illogicità della motivazione circa la non riconosciuta compatibilità delle
dichiarazioni di Carlo DIGILIO con le valutazioni tecniche acquisite sugli
esplosivi utilizzati il 12 dicembre 1969», in realtà si procede ad una
rivisitazione delle emergenze processuali, non soltanto evocativa degli atti
raccolti nel corso del processo e delle varie acquisizioni desunte dalle
numerose perizie e consulenze effettuate anche in un orinai lontano passato, ma
addirittura si tenta di introdurre e asseverare una lettura alternativa di
quelle risultanze attraverso una autonoma base documentale, avendo il
ricorrente accluso, nel corpo dell’atto di impugnazione, varie copie di
documenti relativi, proprio, al tema dell’esplosivo. Il tutto, dunque, in una
prospettiva bensì “critica” delle deduzioni svolte e delle conclusioni
rassegnate dai giudici a quibus a proposito di tale peculiare ‑
ma, evidentemente, importante tematica ‑
e tuttavia realizzata attraverso strumenti argomentativi sicuramente “tecnici”,
ma, appunto perchè esclusivamente tali, destinati a spiegare un qualche risalto
solo agli effetti di un giudizio di merito. Argomenti tecnici, vale la pena di
aggiungere, non soltanto resistiti dalla accurata
disamina condotta dai giudici dell’appello per asseverare i punti di maggior
contrasto emersi rispetto ai diversi approdi cui erano pervenuti i giudici del
primo grado, ma anche vivacemente contrastati dalla difesa dello ZORZI,
particolarmente puntuale ed approfondita nel contestare la fondatezza
dell’analogo quinto motivo di ricorso del procuratore generale (v. pagg. 96 e
segg. della memoria ZORZI in riferimento alle
deduzioni svolte a pagg. 23 e segg. del ricorso del procuratore generale,
nonchè la dettagliata disamina condotta a pagg. 50 e segg. della “Nota
riassuntiva della discussione orale” allegata alla indicata memoria). Ciò
rende, quindi, la tematica introdotta dai ricorrenti ‑
e per il modo stesso in cui risulta evocata nei ricorsi ‑ alla stregua di
profilo strutturalmente eccentrico rispetto ai confinì entro i quali può
trovare margine applicativo il vizio dedotto; essendo noto che, come già si è
accennato, l’íllogicità della motivazione, censurabile a norma dell’articolo
606, comma 1, lett. e, Cpp, è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale
da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul
discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendosi
il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà
del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo,
senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle
acquisizioni processuali (Cassazione, Su, 24 settembre 2003, Petrella;
Cassazione, Su, 23 giugno 2000, Jakani; Cassazione, Su, 16 settembre 1999,
Spina). Il tutto non senza sottolineare gli obiettivi
margini di opinabilità derivanti da ricostruzioni di complesse operazioni di
valutazioni “tecniche”, a loro volta ricostruttive ex post, della natura,
qualità e quantità delle sostanze esplosive impiegate per gli attentati del 12
dicembre 1969, e delle modalità di confezionamento degli ordigni, avuto
riguardo alla mancata campionatura e conservazione di reperti relativi
all’ordigno rinvenuto inespioso alla Banca Commerciale di Milano. Una omissione, quest’ultima, tanto sorprendente quanto
deprecabile, posto che il suo verificarsi ha senz’altro impedito accertamenti
che ‑
sia nella immediatezza che in prospettiva ‑ avrebbero senz’altro offerto
spunti di ineludibile importanza. Ebbene, la sentenza impugnata, alla luce dei
dati offerti dalle risultanze peritali, ha puntualmente
dato atto di come, dovendosi pacificamente escludere l’identità tra l’esplosivo
impiegato per l’attentato di Piazza Fontana e quello descritto dal DIGILIO a
proposito dell’incontro di Canal Salso, avallare l’ipotesi accusatoria, secondo
la quale si sarebbe potuta realizzare «una successiva miscelazione di sostanze
esplosive, tra le quali anche, ma non esclusivamente, la gelatina dinamite,
materiale quest’ultimo, non visto a Canal Salso» e invece certamente presente
nell’ordigno deflagrato, equivalesse null’altro che ad accreditare
“un’invenzione processuale”: ciò, in particolare, avuto riguardo alla
“faticosa” configurazione di quella ipotesi (pag. 734 della sentenza di primo
grado e pag. 477 della sentenza di appello), dettata dall’esigenza di rendere
in qualche modo compatibile con i dati della strage la versione offerta dal
collaboratore, e considerata anche la incertezza del peso dell’ordigno non
esploso posizionato nella Banca Commerciale (presa pure in considerazione per
la ricostruzione dei fatti), nonchè i riferimenti desumibili dalla «nuova
consulenza tecnica del prof. Berry, anch’essa del tutto incontestata ex
adverso». Non senza trascurare ‑ hanno puntualmente messo in risalto i giudici
dell’appello ‑
la circostanza che l’ipotesi configurata nella sentenza di primo grado, oltre a
rinvenire una chiara smentita alla luce delle nuove
acquisizioni peritali e ad essere formulata su base meramente congetturale,
risultava dei tutto priva di riscontri e supporti probatori, «a cominciare
dalla parola dello stesso collaboratore, il quale anzi (aveva) parlato di
ordigni già predisposti in tutto e per tutto compreso l’innesco», affermando
che «quel materiale sarebbe solo stato riversato in altri contenitori (al solo
fine di evitare che, in un occasionale controllo, la polizia si potesse
insospettire per la presenza di cassette militari) e non certo ad essere
miscelato con altro esplosivo» (pag. 478). In tale quadro di riferimento,
dunque, andare oltre, equivarrebbe a formulare un terzo giudizio sui fatti e
sul loro significato probatorio, al di fuori di qualsiasi effettiva
correlazione con il prospettato vizio di motivazione, per quel che si è detto
manifestamente infondato.
Sempre a proposito dell’incontro
di Canal Salso, l’aspetto che comunque assume risalto
assorbente nella economia della decisione adottata dai giudici dell’appello
risiede, essenzialmente, nella disamina del coacervo di elementi che la
sentenza impugnata ha posto in risalto, per sostenere ‑ sulla base di un
tracciato argomentativo ispirato a criteri di assoluto rigore logico e senza
far mostra di alcuna preconcetta volontà di neutralizza ione dell’opposto iter,
sviluppato, a proposito della vicenda, dai giudici di primo grado ‑
il severo giudizio di totale inaffidabilità delle gravi indicazioni di reità
propalate dal DIGILIO: non solo e non tanto per l’assenza di riscontri
individualizzanti, quanto ‑ e forse soprattutto ‑ per la ridda di contrarie
emergenze che, sul piano logico e fattuale, gravemente ne hanno compromesso la
credibilità. Una disamina, quella compiuta dai giudici a quibus, che se, per un
verso, finisce col risultare avvalorata ‑
quanto meno sul piano della relativa logicità ‑ dalla assenza di specifiche
censure da parte dei ricorrenti, assume ‑ sotto altro e più generale
profilo ‑
i connotati della assoluta centralità agli effetti della decisione di
proscioglimento, essendo del tutto evidente che, screditata la principale e
diretta fonte di accusa sull’episodio che costituiva l’immediato antecedente
“logico‑operativo”
della strage (fino a consentire la formulazione di dubbi più che fondati circa
il fatto che quell’episodio si fosse davvero realizzato nei termini descritti,
fra le persone indicate e nel contesto riferito), era evidente che l’intero
castello accusatorio finiva per risultare minato alle fondamenta.
A proposito delle dichiara ioni rese dal DIGILIO in merito all’episodio di Canal Salso.
i giudici del merito hanno infatti ritenuto di poter
prescindere da taluni accenni difensivi (v. memoria ZORZI e allegati), incentrati
su una problematica credibilità di ordine, per così dire, generale, circa
l’episodio in se, avuto riguardo alla dubbia plausibilità di una rischiosa e
compromettente “consulenza” su ordigni esplosivi già predisposti, effettuata su
una macchina parcheggiata in mezzo ad una strada e con l’impiego di torce
elettriche, perchè la via non era illuminata (pag. 699 della sentenza di primo
grado): “consulenza”, per di più, commissionata a persona che asseriva essere
nota «nell’ambiente come esperto di armi e non di esplosívi» (v. sentenza di
primo grado pag. 701) e che lo stesso perito Berry ha definito come « …
totalmente a digiuno in merito ad ordigni esplosivi, a esplosivi, a materie
esplosive … » (pag. 715 della sentenza di rimo grado).
Allo stesso modo, non sono state
reputate conclusive, ai fini del giùdizio di inattendibilità,
le prime quattro “contestazioni”. mosse alla
narrazione del DIGILIO da parte delle difese e “giustificate” in vario modo
nella sentenza di primo grado; contestazioni in particolare riguardanti le
contraddittorie indicazioni fornite circa il numero delle cassette viste nella
vettura del MAGGI; la possibilità di effettuare l’operazione di controllo al
buio; il quantitativo di esplosivo contenuto nelle cassette e, infine, la
descrizione del contenitore del congegno di innesco. I giudici dell’appello, comunque, pur non assegnando una particolare valenza ai vari
elementi di contrasto evocati dalle difese, ne hanno tuttavia dato atto, come
circostanze «pur sempre dimostrative della incoerenza interna (variazione del
contenuto delle cassette, quantitativo dell’esplosivo in esse contenuto,
contenitori del congegno di innesco) ed esterna (condizioni di visibilità) del
collaboratore, nonchè della sua attitudine ad adattarsi alle contestazioni che
gli venivano volta per volta mosse» (pag. 441 e segg. della sentenza impugnata;
v., a proposito dell’ultimo rilievo citato dai giudici dell’appello,
l’osservazione, già formulata dai giudici di primo grado, che avevano definito
il DIGILIO come « … una persona indisponibile ad ammettere contraddizioni nel
suo dictum, a riconoscere di essere stato reticente su alcuni profili delle
vicende descritte, a ritenere che possa incorrere in qualche difetto della
memoria»: pag. 760 della sentenza di primo grado).
Ma sono altre, e ben più
radicali, le contraddizioni ed aporie che, presenti e non dipanate all’interno
del contorto percorso dichiarativo del collaboratore, hanno determinato la
sostanziale evaporazione di qualsiasi risalto probatorio annesso in primo grado
all’importante episodio che viene qui in discorso.
Accanto, infatti, alle obiettive smentite che, come già si è rilevato, la
ricostruzione operata dai primi giudici ha ricevuto a proposito dell’esplosivo
asseritamente visionato a Canal Salso dal DIGILIO (v. anche pagg. 442 e segg.
della sentenza di appello), ed al consistente ritardo
con cui la vicenda ha trovato ingresso nelle pagine del processo, la sentenza
di appello, infatti, ha analizzato ‑ sviluppandone le conseguenze
desumibili in punto di prova, sulla falsariga ed alla luce delle “spiegazioni”
offerte dalla sentenza di primo grado e dei rilievi svolti dagli appellanti ‑
tutta una serie di evenienze palesemente in contrasto con il giudizio di
attendibilità del narrato, formulato, al riguardo, in termini positivi, dai
primi giudici. La sentenza impugnata, infatti, ha rammentato le gravi
contraddizioni in cui DIGILIO era caduto a proposito della presenza o . meno del fratello di ZORZI,
Rudy, che doveva svolgere funzioni di autista pur essendo privo della patente
di guida; il ripiegamento sulla persona del MARIGA; il cambio della vettura a
Padova; il coinvolgimento del FACHINI e le errate indicazioni di dove la
vettura sarebbe stata parcheggiata; le indicazioni altalenanti circa il tipo di
vettura; i fluttuanti adattamenti nel tempo della narrazione, a seconda delle
contestazioni e delle nuove acquisizioni processuali; le confusioni circa la
fonte della notizia dei cambio della autovettura: circostanze, tutte,
pacificamente acquisite e neppure, come si è accennato, contestate nei ricorsi
delle parti civili e dal procuratore generale. Non può, dunque, stupire ‑
e deve reputarsi, anzi, quale corollario del tutto ineluttabile ‑che
i giudici dell’appello, dopo essere giunti al termine della lunga e approfondita
disamina della vicenda di Canal Salso, abbiano ritenuto di dover «rilevare che
la sommatoria delle incongruenze esterne ed interne, nonché
l’esistenza di suggestioni operate sul collaboratore e di inverosimiglianze del
suo dire, non consent(issero) che una conclusione: il grado di attendibilità
del narrato dei collaboratore in ordine a tale episodio (era), anche se non
tutte le censure e le allegazioni difensive (fossero) da condividere,
modestissimo, se non inesistente» (pag. 463).
Sono infondati
anche i motivi di ricorso dedotti nell’interesse del Comune dì Milano, della
Provincia di Lodi e di Milano e di altre parti civili
nei quali, in sostanza, si lamenta la mancata valorizzazione, in chiave
indiziaria, degli elementi raccolti a proposito degli attentati di Trieste e
Gorizia, e di quello commesso ai danni dei magazzini COIN di Mestre tra il 27
ed il 28 marzo 1970. Quanto ai primi, infatti, per i quali si è affermata la
responsabilità di ZORZI e MAGGI, la riconducibilità delle azioni ad un medesimo
alveo finalistico che poi avrebbe condotto alla strage del 12 dicembre, e
qualsiasi ulteriore congettura sul piano delle
responsabilità soggettive, non sono state ritenute ipotesi suffragate da
elementi obiettivi, posto che, al contrario, tra quelle azioni e gli attentati
successivi furono riscontrate differenze giudicate a questi fini dirímenti da
parte dei giudici a quibus. Differenze puntualmente individuate, infatti, nella
maggior potenza, temperatura d’esplosione e potere dirompente dell’esplosivo
impiegato per la strage di Piazza Fontana, al punto che «i periti di Milano
avevano, dopo aver effettuato un esperimento con la
gelignite, materiale viceversa usato a Trieste e Gorizia, completamente escluso
che si potessero verificare con quel tipo di gelignite gli effetti che sono
stati riscontrati nei cinque attentati del 12 dicembre»; nell’impiego, per il
fallito attentato al cippo di confine di Gorizia ‑ ove l’ordigno venne rinvenuto
inesploso il 4 ottobre 1969 ‑ di un contenitore costituito da una cassetta per
munizioni, e quale temporizzatore di un orologio (o di una sveglia,
nell’attentato alla scuola slovena di Trieste), mentre a Milano fu utilizzata
una cassetta portavalori marca “Juwel” e fu impiegato un timer; nella
circostanza, infine ‑ indubbiamente sintomatica di linee strategiche
assai diverse (avuto riguardo, anche, alla “natura” fin troppo chiara degli
obiettivi prescelti) che nelle azioni di Gorizia e Trieste gli ordigni «erano
stati programmati per esplodere durante la notte e, quindi, gli attentati erano
di natura dimostrativa» (v. la sentenza impugnata a pagg. 337 e segg. e 481 e
segg.).
A proposito,
poi, dell’attentato ai magazzini COIN del marzo 1970 (e, quindi, successivo
alla strage: v., al riguardo pagg. 465 e segg. della sentenza impugnata),
la dìsamína condotta sull’episodio, alla luce, anche, delle dichiarazioni di
SICILIANO, ha indotto i giudici dell’appello ad escludere che gli elementi
acquisiti fossero di. spessore tale da consentire di
affermare che ZORZI fosse con certezza responsabile del fatto, sia perchè
quest’ultimo si era limitato a chiedere allo stesso SICILIANO di effettuare una
specie di sopralluogo, cui non era stato poi dato alcun seguito, sia perchè
l’ANDREATTA, che gli aveva richiesto l’ordigno da far esplodere, non aveva
fatto cenno di un suo collegamento con ZORZI, chiarendogli, anche, che la
motìvazione dell’attentato risiedeva in ragioni “personali” e non “politiche”
(v. anche pag. 482). In tale contesto, dunque, il
mancato riferimento alla intercettazione nel corso della quale ANDREATTA aveva
riferito che “se parlo di COIN comincia tutto” ben si spiega in ragione della
perdita del valore sintomatico dell’episodio, coniugandosi invece appieno ‑
come deduce la difesa dello ZORZI (v. memoria a ag. 168) ‑
con il peculiare contesto delle indagini in corso proprio per Piazza Fontana e
con il plausibile conseguente timore che lo stesso ANDREATTA poteva nutrire per
lo sviluppo delle stesse.
La sentenza di appello,
come si è incidentalmente accennato, ha, in varie parti, doverosamente
analizzato in chiave critica il contributo dichíarativo offerto dal DIGILIO, al
fine di desumerne ‑ in stretta aderenza alle tematiche più direttamente
investite dagli atti di appello ‑ valutazioni sulla relativa
attendibilità, sugli spunti esterni che potessero fungere da riscontro, e sulla
stessa linearità e coerenza della relativa condotta processuale. I conclusivi e
diffusi approdi cui i giudici dell’appello sono pervenuti, analitici nel
ripercorrere i tratti salienti della personalità, la vita anteatta e il
comportamento processuale, convergono, però, verso un pi ú che motivato epilogo
dal tenore decisamente negativo: giacche, accanto alle
importanti vicende in cui le dichiarazioni della fonte, più che non trovare
riscontri, hanno addirittura rinvenuto consistenti smentite su profili neppure
secondari ‑
quali l’intricata matassa relativa ai pretesí rapporti con la rete ínformativa
americana; l’attentato all’ufficio istruzione di Mìlano; gli accessi al
casolare di Paese; la vicenda di Canal Salso; il calco della chiave della cella
di Ventura, e simili ‑ la sentenza impugnata pone in risalto, non soltanto
la assenza dei requisito del disinteresse (in realtà, il DIGILIO non rese mai
una vera e propria “confessione”, e il suo comportamento ‑
sottolinea la sentenza ‑ « … fu condizionato da un suo preciso interesse:
il che non può non intaccare l’attendibilità dei dichiarante», dal momento che
il suo contributo fu reso ontologicamente parziale dalla esigenza, appunto, di
non compromettere troppo la propria posizione), ma anche l’ulteriore profilo
della mancanza di spontaneità e autonomia delle sue narrazioni. Ciò, per i rapporti privilegiati intrattenuti dalla fonte con
alcuni ufficiali di polizia giudiziaria, e per gli elementi di suggestione che
derivavano dallo stretto raccordo esistente tra i “colloqui” investigativi e il
successivo “riversaggío” negli atti processuali. In tal senso depone la
circostanza ‑
puntualizzano i giudici a quibus ‑ «che gli interrogatori di
DIGILIO effettuati dall’Autorità giudizíaria, furono intervallati, non solo da
detti “colloqui investigativi” ma anche a volte condotti sulla falsariga delle
relazioni di servizio redatte da colui che aveva
“colloquiato” con il collaboratore, e da veri e propri verbali di polizia
giudiziaria, anch’essi non infrequentemente poi presi a spunto dal Giudice
istruttore». Da tutto ciò, ed in perfetta sintonia, quindi, con le valutazioni
espresse a proposito dell’esame delle singole vicende, il grave ‑
ma coerentemente motivato ‑ corollario secondo il quale, in
relazione a quasi tutte le vicende narrate, ma comunque per quelle di
«maggior spessore accusatorio, la conclusione non può essere che le
dichiarazioni di DIGILIO Carlo ‑ testualmente conclude la sentenza ‑
a) non sono attendibili, e b) non sono quasi mai corredate dai necessari
elementi esterni di convalida, se si eccettua il mero riscontro logico connesso
alla comune appartenenza sua e dei chiamati alla stessa organizzazione
eversiva, nonchè agli accertati collegamenti con analoghi gruppi di altre
città» (pagg. 528 e segg. della sentenza impugnata).
La pretesa di valorizzare in
chiave accusatoria gli incontrì asseritamente avuti dal DIGILIO dopo il 12
dicembre 1969, così come quella di annettere valore indiziante al contenuto dei
relativi colloqui o confidenze, altrettanto asseritamente ricevute dalla
medesima fonte, si rivela, quìndi, come una prospettiva del tutto
impraticabile, stante la totale assenza di elementi di
verifica, atti ad accreditare di una qualche attendibilità il contenuto del
narrato. Le censure, pertanto, che compaiono nei ricorsì del procuratore
generale, della Avvocatura dello Stato, del Comune di
Milano e di altre parti civili, a proposito dell’omesso apprezzamento dì
episodi come la cena della vigilia di Natale del 1969 presso il ristorante “Lo
Scalinetto” con MAGGI e Marcello SOFFIATI, la vicenda del litigio tra
quest’ultimo e lo ZORZI, e gli incontri avuti con lo ZORZI in Piazza del
Popolo, si rivelano del tutto inconsistenti, alla luce delle più che adeguate
puntualizza ioni a tal proposito offerte dalla sentenza impugnata (pagg. 487 e
segg.).
Il diverso, anche se ugualmente
articolato, percorso ricostruttivo che la sentenza impugnata ha svolto per
analizzare il “personaggio” SICILIANO ed il suo altalenante contributo
dichiarativo, ha ìndotto il procuratore generale e tutte le partì civili a
censurare ‑
sotto il profilo della pretesa illogicità della motivazione ‑
la sostanziale antinomia che sarebbe dato cogliere nello sviluppo argomentatívo
adottato dai giudici dell’appello, nella parte in cui, mentre hanno fatto
mostra di conferire una patente di globale credibilità
alle dichiarazioni rese da quella fonte, non ne avrebbero poi tratto coerenti
conclusioni sul piano della valutazione probatoria, e, dunque, del significato
che ‑
in chiave di accusa ‑ doveva attribuirsi agli episodi “centrali” dallo
stesso descritti. Il tutto, evidentemente, in un contesto
teso a stigmatizzare opzioni delibative del tutto antagoniste rispetto a quelle
invece prescelte in prime cure.
Cosi, il ricorso del procuratore
generale segnala come la sentenza impugnata abbia rìtenuto Martíno SICILIANO
attendibile, a differenza di DIGILIO; ha ritenuto di dover esaminare anche le
sue dichiarazioni relative al pagamento ricevuti da
Delfo ZORZI Per ritrattare le sue accuse; ha escluso fenomeni di
“circuitazioni” di notizie apprese dagli inquirenti; eppure, a fronte di tali
positive emergenze, non avrebbe saputo trarre le conseguenze dovute, secondo i
canoni interpretatìvi dettati dall’articolo 192 del codice di rito. SICILIANO, sottolinea, infatti, la ricorrente parte pubblica, «non è un
chiamante in correità, ma è un teste, un teste assistito, e le sue
dichiarazioni ‑
pur se da valutare ex articolo 192 n. 3 per il preciso disposto dell’articolo
197 bis n. 6 ‑
sono pur sempre dichiarazioni di un teste, e quindi interpretabili con una
diffidenza minore di quella doverosa nei confronti di chi ‑
personalmente coinvolto in quello stesso reato ‑ tenta inevitabilmente di
ridurre la sua responsabilità». Del tutto analoghe le
osservazioni poste a base del consimile motivo di ricorso rassegnato dalla
Avvocatura dello Stato; cosi come lo sono, nella sostanza, quelle svolte nel
quarto motivo del ricorso proposto per il Comune di Milano, ove, peraltro,
l’accento si sposta sulla presenza partecipativa del SICILIANO ai “fatti” di
quegli anni, accreditando, dunque, la configurazione del proprio contributo
dichiarativo per quello ‑ puntualizza il ricorso ‑ di un “testimone
del proprio ruolo”. Ma il punto, in diritto, è proprio questo: tanto più la
posizione del dichiarante si accosta a quella dei soggetti coinvolti nei fatti
che lo stesso descriva, tanto maggiore diviene
l’esigenza di calibrare l’apprezzamento delle relative dichiarazioni sulla
falsariga delle regole rafforzate tracciate dall’articolo 192, commi 3 e 4,
Cpp. Nè ha senso, e men che mai base normativa, la pretesa del procuratore
generale di affievolire la caratura dei riscontri, in ragione della attribuibilità al dichiarante della figura del
cosiddetto “teste assistito” considerato che, al di là del nomen con cui può
essere formalmente etichettata la posizione dei soggetto che viene esaminato,
ne è dirimente ‑
ai soli effetti che veramente contano, vale a dire della individuazione del
regime giuridico che regola l’assunzione e la valutazione di quelle
dichiarazioni ‑
il connotato “sostanziale” di persona coinvolta o già coinvolta nei fatti
oggetto delle dichiarazioni o in fatti a quelli collegati. Il delicato crinale
sul quale è posta la linea di displuvio tra chi è
teste e chi non lo è ‑ pur nella contorta congerie delle figure soggettive
scaturite dalla legge 63/2001 ‑ passa, dunque, attraverso l’analisi della garanzia
del nemo tenetur contra se edere, e di quella della cosiddetta corroboration
che, per scelta normativa, deve assistere le dichiarazioni eteroaccusatorie di
chi, per la posizione ricoperta in relazione ai fatti narrati, non è rispetto
ad essi, totalmente terzo e processualmente “indifferente”. E’ evidente,
allora, che ‑
contrariamente all’assunto del pubblico ministero ricorrente ‑
una volta che le dichiarazioni accusatorie siano
normativamente assoggettate alla disciplina dell’articolo 192, comma 3, Cpp,
sarebbe non soltanto arbitrario distinguere il quantum di riscontri, necessario
per confermare l’attendìbilità, in ragione del ruolo “formale” attribuito al
dichiarante (in forza del brocardo ubi lex non distinguit nec nos distingere
debemus), ma anche privo di qualsiasi logica e coerenza sistematica, posto che
lo scrutinio di attendibilità è scrutinio di “relazione” il quale presuppone
verifiche variabili che non possono porsi in rapporto esclusivo con le qualità
“processuali” del dichiarante (come mostra di presupporre il ricorrente), ma
che devono tener conto di tutta l’ampia ed innominata gamma dei parametri
(anche di ordine logico) che possono fungere da criteri di apprezzamento dei
riscontri ab extrinseco del narrato. SICILIANO, dunque, non è affatto ‑
nè giuridicamente, nè, soprattutto, in “concreto” ‑ un osservatore
neutrale dei fatti che si limiti a riportare episodi e discorsi che lo abbiano
visto asetticamente presente, ma è un qualificato ed attivo partecipe delle
tragiche vicende di quegli anni: direttamente coinvolto in episodi di violenza
eversiva, in attentati, nell’intessere ed assecondare vincoli di sodalità
all’interno di una organizzazione che perseguiva,
anche con l’uso di armi ed esplosivi, finalità antidemocratiche di destabilizza
ione del sistema, e che, proprio in tale veste, e nel quadro di un
evidentemente consolidato rapporto di sodalità, ebbe a percepire con estrema
chiarezza la linea di accelerazione terroristico‑eversiva che FREDA ed altri
intendevano imprimere a quella struttura associativa. La sentenza impugnata
tiene, quindi, doverosamente conto di tutto ciò, traendone le ineluttabili
conseguenze in punto di applicabilità della regola di
cui all’articolo 192, comma 3, Cpp, senza “infingimenti” di sorta circa la
qualità del dichiarante ai fini di un preteso affievolimento delle esigenze di
riscontro in ordine alla attendibilità di quelle dichiarazioni.
La sentenza impugnata ha
meticolosamente ricostruito, in numerose pagine, la vicenda “processuale” di
SICILIANO (pagg. 559 e segg.), dando atto dei contatti con il
SISMI e con lo ZORZI, delle varie somme percepite, degli intermittenti
contributi dichiarativi strettamente correlati alle promesse o alle dazioni di
denaro provenienti da apparati pubblici, da un lato, e dallo ZORZI o
nell’interesse dello ZORZI, dall’altro: vicende che diedero vita ad altre
indagini e procedimenti e che hanno visto addirittura coinvolto direttamente
nei pagamenti lo stesso giudice istruttore del processo. Vicende che, a tutta
prima, potrebbero rappresentare imbarazzanti ipoteche sulla attendibilità
della fonte ‑
e come tali ampiamente rimarcate, rammenta la sentenza, dalle difese degli
imputati ‑
ma che i giudici dell’appello, all’esito di una dettagliata e logicamente
coerente analisi, non hanno ritenuto di dover qualificare alla stregua di
episodi denotativi di inaffidabilità generale del dichiarante. Da un lato,
infatti, i giudici dell’appello hanno ritenuto provato il
fatto che SICILIANO si fosse «inizialmente sottratto al contraddittorio
esclusivamente in ragione dell’interesse di ZORZI Delfo ed in cambio di una
lauta retribuzione»; desumendone, da ciò, che «nessuna censura di
inattendibilità (potesse) essere ragionevolmente formulata per questo verso nei
confronti del collaboratore per il suo pregresso comportamento in incidente
probatorio e al dibattimento di primo grado, ma che, anzi, (fosse) lecito
trarre, da tanto, ragione per stigmatizzare, piuttosto, la condotta
dell’imputato ZORZI». Sul versante opposto, invece ‑ vale a dire quello
del denaro che la fonte ebbe a percepire da pubblici ufficiale per la sua
collaborazione ‑
la sentenza impugnata non ha mancato di sottolineare
come proprio il comportamento processuale di SICILIANO costituisse «la migliore
riprova dei fatto che il denaro abbia per lui costituito lo stimolo per
collaborare, ma non per mentire: se, infatti ‑puntualizzano i giudici a quibus
‑
egli fosse stato governato in tutto e per tutto dalla sua avidità, non avrebbe
tenuto quell’atteggiamento altalenante tra la collaborazione con l’Autorità
giudiziaria e l’obbedienza alle ragioni dello ZORZI, se non altro perchè
quest’ultimo gli aveva corrisposto ed avrebbe potuto corrispondergli somme
assai maggiori, e non lo avrebbe esposto a quelle conseguenze che (lo stesso)
SICILIANO ha dovuto patire ogni volta che si è messo nuovamente a disposizione
dell’Autorità giudiziaria di Brescia». Ci si muove, come è
evidente, all’estremo confine entro il quale può ritenersi plausibile un
apprezzamento di attendibilità generale, pur in presenza di scelte dichiarative
tanto compromissorie e “altalenanti”; sicchè pretendere ‑ come ipotizzano le
ricorrenti parti civili ed il pubblico ministero ‑di utilizzare quel giudizio di
attendibilità come attestato circa valenza dimostrativa delle relative
dichiarazioni ed apprezzarlo in termini di spessore tale da abbisognare
soltanto di un minimum di riscontri, si rivela, pertanto, operazione, non
soltanto impraticabile sul piano del disposto normativo (si è detto, che
l’articolo 192, comma 3, Cpp non ammette “graduatorie” quanto alla relativa
applicabilità), ma anche su quello del rigore logico. Che da un fatto ‑
pagamento di somme per dichiarare o ritrattare ‑ non possa automaticamente
dedursi l’inattendibilità delle dichiarazioni comunque
rese, non deriva, infatti, il (paradossale) reciproco: e cioè che il
dichiarante “prezzolato” sia, per ciò solo, attendibile. L’essersi, quindi, i
giudici dell’appello saldamente attestati ad un rigoroso criterio di verifica
di ciascun singolo episodio narrato dal SICILIANO, piuttosto che enfatizzarne o
sminuirne la credibilità generica, rappresenta un
percorso del tutto corretto e certamente esente da quelle censure di
illogicità, addirittura manifesta, che il ricorrente pubblico ministero e le
parti civili hanno invece preteso di intravedere nella sentenza impugnata.
Quanto ai fatti di maggior
significato descritti dal SICILIANO, i ricorsi, della parte pubblica e delle
parti civili, sono ancora una volta concordi nel denunciare l’intima
contraddittorietà che infirmerebbe la coerenza logica delle statuizioni
adottate dai giudici di appello, posto che, per
ciascuna delle vicende analizzate, dopo aver positivamente scrutinato la
sostanziale credibilità delle indicazioni e delle circostanze riferite dalla
fonte, ne avrebbero, poi, sminuito il contributo indiziante, in forza di
rilievi, volta a volta, reputati dagli stessi ricorrenti o contrastati da
opposte considerazioni di ordine logico, o, in taluni casi e per taluni
aspetti, non in linea con le risultanze processuali.
Così, a proposito della
cosiddetta cena del tacchino, il pubblico ministero lamenta che nella sentenza
impugnata i giudici dell’appello, da un lato mostrino di credere che il
SICILIANO dica il vero; esaminano le dichiarazioni del VIANELLO che nega sia la
cena che il discorso compromettente dello ZORZI; ritengono che queste non
inficino nè convalidino quanto detto da SCILIANO, ma poi non condividano il
valore che il giudizio di primo grado aveva attribuito alla frase pronunciata
dallo ZORZI, interpretandola piuttosto come una “generica rivendicazione di attentati da altri progettati e commessi”. Al tempo
stesso, il ricorrente contesta la fondatezza dei rilievi ‑
che compaiono in sentenza ‑ circa la incostanza e la
diluizione nel tempo delle dichiara ioni dello stesso SICILIANO, in quanto la
sentenza di appello avrebbe omesso fra l’altro di considerare «che i cospicui
versamenti di denaro effettuatì da ZORZI a SICILIANO si sono concretizzati
anche nel memoriale, di cui pure parla la sentenza, nel quale SICILIANO
espressamente ritratta due particolari, uno dei quali è questa cena del
tacchino!».
Nel ricorso proposto per il Comune
di Milano, invece, si pone l’accento sul duplice e concorrente rilievo della attendibilità del SICILIANO e delle plurime emergenze
che, al contrario, smentirebbero VIANELLO: le ragioni del cui mendacío, dunque,
finirebbero per avvalorare la narrazione della fonte di accusa. Nel ricorso
proposto nell’interesse delle parti civili Luigi Passera ed altri si segnala, fra l’altro, che le frasi pronunciate da ZORZI
nella nota circostanza della cena, altro non sarebbero che «una confessione
stragiudiziale, quantomeno, del concorso morale nella strage», considerato che
la giurisprudenza, in particolare con riferimento ai reati di matrice politica,
ha sottolineato che “l’adesione morale e rafforzativa dei correi è la stessa
base giustificativa dell’azione”.
Le doglianze, in larga misura
attestate su una rilettura del quadro fattuale alternativa
rispetto a quella motivatamente offerta dai giudici a quibus, sono tutte prive
di fondamento. La sentenza impugnata, infatti, ancora una volta estremamente Puntuale nell’esaminare funditus apporti
dichiarativi, scrutinio della relativa intrinseca attendibilità, elementi
esterni di verifica, contesto ed evoluzione diacronica dei percorsi
“soggettivi” dei dichiaranti, e ‑ ovviamente ‑
censure che alla ricostruzione operata dai primi giudici erano state proposte
dagli appellanti, giunge a conclusioni del tutto coerenti con i risultati
scaturiti da tale approfondito esame, a sua volta condotto con metodologia
critica e rigore logico assolutamente corretti. Dopo aver, infatti, rammentato
le dichiarazioni del SICILIANO ed il loro “evolversi”, la diversa versione del
VIANELLO, le tesi affermate in primo grado e quelle poste a fondamento degli
atti di appello, in particolare dello ZORZI
(evidentemente principale “interessato” a quella vicenda), la sentenza
impugnata ‑
in ciò contraddicendo la pronuncia di primo grado, la quale, sulla base del
dichiarato, aveva ritenuto che VIANELLO “avesse fornito un vero e proprio
riscontro al collaboratore” (ammissione di cene con ZORZI e SICILIANO caratterizzate
da atmosfera cameratesca, con bevute e scherzi e con la consumazione del famoso
tacchino) ‑
ha puntualmente osservato come nella specie, ciò che era controverso, non era
«tanto la verificazione di un evento (la cena) con determinate caratteristiche
(bevute, scherzi, presenza tra i cibi di un tacchino), quanto la data (31
dicembre 1969) ed il contenuto dei discorsi. ovvero di
un determinato discorso, nell’occasione fatti: se VIANELLO ‑affermano
i giudici a quìbus ‑ si fosse limitato a confermare quell’evento e
quelle caratteristiche, si sarebbe potuto parlare di elemento di convalida
esterno; ma poichè il teste ha esplicitamente e recisamente negato i punti
centrali (data e discorsi), deve ammettersi ‑ conclude sul punto la sentenza
‑
che più che di riscontro si deve parlare di smentita». Quanto, poi, ai dubbi
espressi dai primi giudici in ordine alla
attendibilità ed in particolare al viaggio in Svezia che lo stesso VIANELLO
avrebbe effettuato proprio nel dicembre 1969, tali dubbi ‑
mai concretamente dipanati ‑hanno del tutto logicamente indotto i giudici
dell’appello a «non attribuire alla (sua) testimonianza una forza probatoria
superiore al narrato di SICILIANO: certo è che tale soluzione ‑
esattamente conclude la sentenza ‑ se non inficia l’attendibilità
del collaboratore, comunque fa mancare alle sue dichiarazioni l’indispensabile
elemento esterno di convalida» (pag. 519 della sentenza impugnata). Derivando
evidentemente da ciò che le narrazionì di SICILIANO non potevano,
su questo come sugli altri episodi descritti, fungere ‑ proprio perchè
privi di riscontri ‑ da elementi probatori tali da asseverare la
responsabilità dei chiamati, “al di là di ogni ragionevole dubbio” (v.
Cassazione, Sezione prima, 14 maggio 2004, Grasso, già citata).
Nello stesso alveo si colloca,
infine, anche l’episodio relativo all’incontro con
GRADARI: episodio, questo, valorizzato in primo grado sul presupposto della
“sospetta!’ decisa negazione dello stesso GRADARI circa la confidenza
asseritamente rivoltagli dal SICILIANO (v. pag. 787 della sentenza di primo
grado). La confidenza relativa ai “sospetti” che nella
strage di Piazza Fontana fossero coinvolti degli ordinovisti, che SICILIANO ha
asserito di aver formulato al GRADARI, è rimasta, infatti, circostanza priva di
riscontri; sicchè il dubbio sulla attendibilità della negazione promanata dal
GRADARI (dubbio che i giudici dell’appello in parte condividono: v. pag. 526
della sentenza impugnata), non può certo valere da “elemento di conferma” di un
episodio che, tutto sommato, non assume neppure specifiche connotazìoni di
risalto, considerato che, anche nella economia delle
doglianze dei ricorrenti, la vicenda è solo fugacemente accennata. Ciò che
conta è che, ancora una volta, non v’è contraddizione alcuna (come invece prospetta
il Procuratore generale) nell’avere i giudici dell’appello, per un verso
ritenuto in se credibile la narrazione del SICILIANO, e, per l’altro, omesso di
trarre da ciò specifiche conclusioni in punto di prova, avuto riguardo, non
solo alla assenza di elementi di verifica, ma anche
allo scarso valore denotativo dell’episodio, per la verità neppure esaltato in
primo grado. Che la responsabilità della strage sia infatti
riconducibile a frange ordinoviste, è circostanza non controversa nella
sentenza impugnata.
Il ricorso del procuratore
generale, quello proposto dalla Avvocatura dello Stato
ed il ricorso presentato nell’interesse del Comune di Milano, convergono nel
lamentare vizio di motivazione per il fatto che ‑ contrariamente a quanto
ritenuto nella sentenza di primo grado ‑ nella pronuncia impugnata
sarebbe stata sostanzialmente sottovalutata sul piano indiziante l’attività di
condizionamento posta in campo direttamente o indirettamente da Delfo ZORZI per
subornare o intimidire testi o dichiaranti e per indurre nel processo fonti di
prova non veritiere a proprio favore. Sottolinea in
particolare il ricorso del Comune di Milano come la sentenza impugnata si sia
lungamente intrattenuta per fornire la esatta ricostruzione dei vari contatti
intervenuti fra SICILIANO e gli “emissari” di ZORZI, i quali in più circostanze
avrebbero tentato di indurlo a ritrattare quanto dichiarato a carico di
quell’imputato. Nei confronti del SICILIANO sarebbero state cosi formulate
offerte di vario genere: dalle proposte di lavoro, a quelle di
assistenza legale, e, infine, di somme di denaro; offerte che, sia pure
temporaneamente, avrebbero raggiunto il loro scopo, attraverso la sottrazione
del SICILIANO alla giustizia o mediante le sue ritrattazioni. Mentre, dunque, tali vicende sono state accuratamente
scandagliate nella sentenza impugnata per “salvare” l’attendibilità del teste,
non altrettanta cura sarebbe stata rivolta dai giudici dell’appello
nell’analizzare le ragioni per le quali ZORZI, afferma il ricorrente, si fosse
«attivato così tanto e così a lungo per “eliminare” dal processo un soggetto le
cui dichiarazioni, posta la sua conclamata estraneità ai fatti, non avrebbero
potuto nuocergli».
Il tema della “subornazione” di
SICILIANO, dei contatti dal medesimo avuti con forze di polizia, apparati dei
servizi, autorità giudiziaria, da un lato, ed “emissari” di ZORZI, dall’altro,
e delle corrispondenti promesse, offerte o dazioni effettive di denaro o altri
benefici, in vista di obiettivi processuali
evidentemente antagonisti fra loro, è argomento che ‑ come si è
accennato e come riconoscono gli stessi ricorrenti ‑ha formato oggetto
di una approfondita rivisitazione da parte dei giudici di appello, davanti ai
quali soltanto, il SICILIANO rese ampie dichiarazioni, senza sottrarsi al
relativo contraddittorio (v. pagg. 560 e segg. della sentenza impugnata). La
prospettiva di tanta accuratezza nella disamina di vicende che avevano visto il
coinvolgimento di pubblici ufficiali e dello stesso giudice istruttore del
processo, era evidentemente quella di verificare se, ed eventualmente in che
misura, l’essersi il SICILIANO trovato al centro di due alternative fonti di
guadagno, avesse potuto negativamente incidere sulla sua credibilità.
Ma, una volta ritenuto che il SICILIANO si fosse inizialmente
sottratto al contraddittorio soltanto in ragione dell’interesse di ZORZI
«ed in cambio di una lauta retribuzione», ne derivava ‑ come si è già
accennato ‑
che nessun rilievo di inattendibilità potesse dedursi, per tale aspetto, dalla
mancata condotta collaborativa serbata dal SICILIANO nel corso dell’incidente
probatorio e al dibattimento di primo grado, posto che l’indicata vicenda
poteva invece soccorrere per « … stigmatizzare … la condotta dell’imputato
ZORZI» (pag. 580). Ciò significa, pertanto, che soltanto entro questi
circoscritti e ben delineati confini poteva
“utilizzarsi”‘ il comportamento processuale dello ZORZI a suo carico, ma non
certo per desumere da esso l’obbligo del giudice di procedere ad una
motivazione in negativo circa la inesistenza di profili probatorí in ordine ad
un “fatto” processuale in sè privo di simili connotazioni (si è detto, il
tentativo di “avvicinamento” dei teste avverso, non è di per sè prova di
colpevolezza che il giudice deve motivatamente escludere ove intenda assolvere
l’imputato), in particolare, ai fini di una lettura “alternativa” delle
elargizioni provenienti dallo ZORZI, si sarebbe dovuto svolgere una disamina
motivazionale dell’intero episodio senz’altro eccentrica rispetto all’oggetto
del decidere, e comunque invasiva «del diverso e separato procedimento pendente
presso l’Autorità giudíziaria bresciana, quello per favoreggiamento ed altro a
carico, oltre che desso stesso SICILIANO, anche dei suoi difensori»: donde,
l’affermata impossibilità, da parte dei giudici a quibus, di conferire al
proprio giudizio sulla intera vicenda «quella completezza e definitività che
sono prerogativa esclusiva del giudice competente» (v. pagg. 578, 578 della
sentenza). Dal testo del provvedimento impugnato traspare, quindi,
contrariamente all’assunto dei ricorrenti, un apprezzamento del tutto congruo in ordine al comportamento “processuale” dello ZORZI ed ai
relativi tentativi di “condizionamento” del SICILIANO: un apprezzamento del
quale ‑
può concludersi sul punto ‑ la sentenza offre una più che esauriente e logica
motivazione, ancorchè sviluppata, come è ovvio, nell’ambito dei doverosi limiti
connessi ad un accertamento di natura meramente incidentale.
Deve invece reputarsi
manifestamente inammissibile l’ottavo motivo dei ricorso
rassegnato nell’interesse delle parti civili Luigi Passera ed altri,
nonchè della Provincia di Lodi e Milano, nel quale si prospetta illogicità e
contraddittorietà della motivazione, nonchè travisamento dei fatti, in ordine
alla ritenuta esistenza di sentimenti di astio e propositi di vendetta da parte
di DIGILIO Carlo nei confronti di ZORZI Delfo, a causa delle accuse a lui
rivolte dal SICILIANO a Tolosa nel settembre 1994. Anche a voler prescindere,
infatti, dal profilo del tutto secondario che lo specifico aspetto oggetto di
censura presenta nel panorama dei complesso tessuto
argomentativo che caratterizza la sentenza impugnata, nella parte in cui tratta
ex professo delle valutazioni conclusive in ordine alla attendibilità dei
DIGILIO, le doglianze del ricorrente, ancorchè formalmente evocative dei
dichiarati vizi di legittimità, sono in concreto articolate sulla base di
semplici deduzioni di merito, tese ad una rivalutazione dei motivati
apprezzamenti condotti sul punto dai giudici a quibus. I rilievi, quindi
(peraltro puntualmente contrastati a pag. 83 e segg. della memoria ZORZI),
esulano dal perimetro entro il quale può svolgersi l’odierno scrutinio, a
prescindere, quindi, da qualsiasi valutazione circa la relativa ipotetica
idoneità demolitoria del provvedimento impugnato.
Palesemente inammissibile è anche
il tredicesimo ed ultimo motivo rassegnato nel medesimo ricorso, posto che la
mancata partecipazione del consulente tecnico del pubblico ministero ad una
riunione con il perito e gli altri consulenti ‑ nel corso di una nuova perizia
trascrittiva di una intercettazione ambientale ‑
è questione che avrebbe dovuto semmai dedurre lo stesso pubblico ministero, e
non altra parte privata, facoltizzata a nominare un proprio consulente tecnico.
Il procuratore generale,
l’Avvocatura dello Stato ed il difensore delle parti civili Luigi Passera ed
altri, ricorrono anche avverso la assoluzione di
ROGNONI Giancarlo, deducendo, pure per tale imputato, vizio di motivazione,
ancorchè variamente articolato. Nel ricorso delle parti civili Passera ed
altri, le censure, addirittura corredate da varia produzione documentale,
sono peraltro incentrate esclusivamente su aspetti di merito, attraverso una
diffusa riproduzione delle dichiarazioni rese da varie fonti o mediante
citazioni di altre emergenze processuali, tese, tutte, ad avvalorare le opposte
conclusioni rassegnate nella sentenza di primo grado (v. pagg. 62 e segg.
dell’atto di impugnazione). Il ricorso è pertanto, in
parte qua, inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti. Il
procuratore generale, invece, deduce due profili di illogicità
della motivazione della sentenza di appello. Da un lato, infatti, nella stessa
sentenza “si sostiene che la prospettiva di eventuali
benefici carcerari è motivazione usuale per tutti i collaboratori e pertanto
non può di per se influire negativamente sul giudizio di attendibilità; sicchè,
sarebbe .contraddittoria con tale impostazione la
scelta dei giudici a quibus di ritenere inattendibile BONAZZI proprio per essersi
questi “determinato a parlare con la prospettiva di godere dei benefici
penitenziari”. Inoltre, segnala ancora il ricorrente, la affermata
“mancanza di rapporto di cooperazione eversiva tra Milano e Padova (darebbe)
per dimostrato quello che è invece l’oggetto della dimostrazione”: di tal che
la sentenza impugnata avrebbe, “ancora una volta, identificato come postulato,
ciò che invece deve essere ancora dimostrato”. Al tempo stesso ‑
conclude il ricorrente pubblico ministero ‑
la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare a proposito delle
dichiarazioni rese dal SICILIANO in ordine agli incontri da lui avuti assieme
allo ZORZI con il ROGNONI nel 1969. Nella sostanza analoghe
sono le censure svolte nel ricorso proposto dalla Avvocatura dello Stato, ove
in particolare si sottolinea la incongruenza di aver fondato la decisione
assolutoria del ROGNONI sulla mancanza di prove circa l’esistenza di
qualificati contatti con il gruppo padovano di Ordine Nuovo, Posto che ‑
a parere della ricorrente ‑ nel corso del processo sarebbero state raccolte
prove, la cui valutazione è stata omessa dai giudici dell’appello, e che,
“viceversa, dimostravano in via del tutto autonoma il coinvolgimento del
ROGNONI nella strage”.
Anche per ciò che attiene alla
posizione del ROGNONI i ricorsi non sono fondati. A
proposito delle censure dedotte dal pubblico ministero, può subito osservarsi,
infatti, che la pretesa contraddizione in cui sarebbe caduta
la sentenza impugnata nel ritenere inattendibile BONAZZI perchè spinto a collaborare
solo in vista di benefici di tipo penitenziario e nell’afférmare, al tempo
stesso, che simili motivazioni sarebbero “usuali” Per tuttì i collaboratori, è,
non soltanto insussistente, ma frutto di un palese errore di lettura della
sentenza impugnata. E’ ben vero, infatti, che la stessa sentenza accenna al
fatto che il conseguimento di trattamenti processuali o penitenziari più
benevoli rappresenta una «motivazione … usuale per tutti i collaboratori di
giustizia» (pag. 624); ma ciò lo fa esclusivamente nel
riprodurre ‑
in chiave fortemente critica ‑ quanto sostenuto nella sentenza dì primo grado (v.
pag. 312 della sentenza di primo grado) proprio per “gíustificare” sul piano della attendibilità le motivazioni che avevano indotto
BONAZZI a rendere quelle dichiarazioni eteroaccusatorie. D’altra parte, anche
l’assenza di elementi atti a dimostrare l’esistenza,
quanto meno prima della strage, di rapporti qualificati tra il ROGNONI e gli
esponenti del gruppo padovano di O.N., in particolare di FREDA e VENTURA,
ritenuti dagli stessi giudici dell’appello responsabili dei fatti del 12
dicembre 1969, è un assunto cui la sentenza impugnata perviene all’esito di un
accurato percorso ricostruttivo, sulle cui premesse metodologiche e di fatto
neppure i ricorrenti hanno sollevato obiezioni di sorta; sicchè, si rivela
erronea, prima ancora che infondata, la
censura del pubblico ministero per la quale i giudici a quibus avrebbero dato
per scontato ciò che invece avrebbe dovuto costituire oggetto di prova.
L’analisi critica che la sentenza
impugnata conduce a proposito degli elementi di accusa
posti a base del giudizio di responsabilità penale dei ROGNONI, rassegnato dai
primi giudici, si rivela ‑ contrariamente a quanto assumono i ricorrenti ‑
del tutto coerente ed immune da censure di ordine logico argomentativo. A
proposito, infatti, della principale fonte di accusa,
rappresentata dalle dichiarazioni rese da Edgardo BONAZZI, i giudici
dell’appello ne hanno puntualmente ricostruito la genesi e gli sviluppi
dell’iter collaborativo e delle relative motivazioni, pervenendo alla
formulazione di un giudizio di attendibilità «gravemente inficiato» dalle
finalità perseguite dalla fonte: non senza trascurare, a questo riguardo, i
significativi elementi di incostanza che avevano contrassegnato le sue
dichiarazioni (v. pagg. 620 e segg.della sentenza impugnata). Aggiungendo a ciò
la circostanza che le dichiarazioni del BONAZZI erano
relative a fatti non da questi conosciuti per scienza diretta, ma a lui noti
unicamente perchè appresi da confidenze asseritamente ricevute da Nico AZZI
durante la comune detenzione; e considerato che AZZI, a sua volta, aveva negato
tale circostanza, il corredo indiziante che ne residuava è stato reputato del
tutto incongruo, attesa, anche, la «totale assenza di elementi esterni di
conferma in grado di riempire i vuoti di quella deposizione» (pag. 629 della
sentenza). Sfumano, quindi, in questa prospettiva, i tentativi della Avvocatura dello Stato ricorrente di valorizzare
circostanze “esterne” allo screditato narrato della fonte principale di accusa,
quali il sospetto e repentino allontanamento dei ROGNONI dalla Banca
Commerciale Italiana, presso la quale lavorava, proprio dopo gli attentati del
12 dicembre 1969 (dettato, secondo ì gìudici dell’appello, da motivazioni meno
implausibili di quelle ritenute in primo grado e, comunque, all’evidenza
insuscettibile dì fungere ‑ di per s’è ‑ da prova autonoma di
responsabilità), così come i rapporti asseritamente avuti con SICILIANO e
ZORZI: significativi, anch’essi, ove collocati in un contesto di sodalìtà
eversiva, ma privi di reale valenza, ove riferiti ai tragici eventi di cui qui
si tratta. Da tutto ciò, deriva, dunque, la perfetta linearità ed esaustività
del percorso motivazionale adottato dai giudici dell’appello per ribaltare il
gìudizio di responsabilità formulato, sul conto del ROGNONI,
nella sentenza di primo grado.
Quanto, infine, al ricorso
proposto nell’interesse di TRINGALI Stefano, i primi due motivi dì gravame si rivelano palesemente inconsistenti: a proposito, infatti,
della pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto, con la
sentenza di primo grado, sarebbe venuta meno l’aggravante del terrorismo
contestata per il favoreggiamento e, dunque, l’ipotesi di reato (strage o,
comunque, fatti di terrorismo) in base alla quale le intercettazioni erano
state autorizzate, l’eccezione è manifestamente infondata,
in quanto il “titolo” in forza del quale l’intercettazione è ritualmente
autorizzata è quello ravvisabile ex ante, al momento, cioè, in cui il mezzo di
ricerca della prova viene dìsposto, e non certo ex post, sulla base del fatto
accertato ìn sentenza. Quanto, poi, alla presunta omessa motivazione sul motivo
di appello relativo alla mancata applicazione della
diminuente di cui all’articolo 438 Cpp, nessuna motivazione era dovuta se non
quella relativa alla tardività della richiesta di giudizio abbreviato. Del pari infondata è la censura concernete il diniego delle circostanze
attenuanti generiche, avendo i giudici del merito congruamente dato conto in
sentenza delle regioni in forza delle quali hanno ritenuto di non poter
concedere il richiesto beneficio. Così come ugualmente non fondato è il motivo relativo alla prescrizione che si sarebbe maturata prima
della sentenza di appello, in quanto, attesi i periodi di sospensione e l’epoca
dei fatti, come contestata e ritenuta in sentenza, il reato a quella data non
era prescritto. Allo stesso modo non fondati sono
anche gli ultimi due motivi, giacchè la sentenza impugnata, con ampia ed
articolata motivazione, ineccepibilmente ha scandagliato la condotta di
“inquinamento” ascritta al TRINGALI , puntualmente evidenziando i presupposti
soggettivi ed oggettivi per ritenere nella specie integrato il contestato
delitto di favoreggiamento personale, ed escludendo al tempo stesso ‑
con rilievi dei tutto corretti sul piano giuridico ‑ la sussistenza dei
presupposti per la applicazione della causa di non punibilità prevista
dall’articolo 384, primo comma, Cp, nuovamente sollecitata nel sesto ed ultimo
motivo di ricorso. Tuttavia, non potendosi dichiarare inammissibile il ricorso
e non sussistendo, al tempo stesso, i presupposti per la declaratoría
di proscioglimento nel merito a norma dell’articolo 129, comma 2, Cpp, il reato
ascritto al TRINGALI deve essere dichiarato estinto per intervenuta
prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata.
Devono pertanto essere respinti i
ricorsi del procuratore generale e delle parti civili, le quali ultime vanno ex
lege condannate, a norma dell’articolo 616 Cpp, al pagamento delle spese
processuali.
PQM
Annulla senza
rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TRINGALI Stefano perchè il reato
è estinto per intervenuta prescrizìone.
Rigetta il ricorso dei
Procuratore generale e i ricorsi delle parti civili: Presidenza del Consiglio
dei ministri, Ministro dell’interno, Comune dì Milano, Provincia di Lodi,
Provincia di Milano, nonché China Gabriella, China
Silvana, Passera Luigi, Garavaglia Eugenia, Gerli Clementina, Scaglia Anna
Maria, Valè Lucia, Dendena Francesca, Perego Alessandro, Maiocchi Anna Maria,
Silva Paolo, Silva Giorgio, Gaiani Giovanni, Meloni Mario, Arnoldi Giuseppina,
Arnoldi Carlo Alfredo Maria; ricorsi proposti nei confronti di Maggi Carlo
Maria, Zorzi Delfo e Rognoni Giancarlo.
Condanna tutte le predette parti
civili ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.