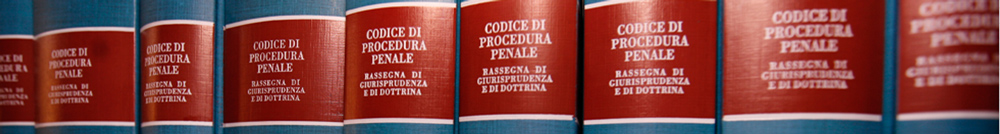Imprese ed Aziende
La relazione annuale del presidente della Confindustria D’Amato.
La relazione annuale del presidente della Confindustria D’Amato.
Relazione annuale del presidente all’Assemblea della Confindustria 22 maggio 2003
Autorità, signore, signori, colleghe e colleghi:
appare ormai chiaro che col nascere del nuovo secolo tre elementi si sono presentati congiuntamente e hanno creato una netta cesura con il mondo che abbiamo conosciuto finora.
Si è arrestato il meccanismo di sviluppo che ha sostenuto l’economia mondiale negli ultimi quindici anni.
Si è radicato il processo di globalizzazione, che comporta mutamenti profondi della struttura sociale e delle condizioni produttive sia nei paesi sviluppati sia nei paesi in via di sviluppo.
È esploso il fenomeno del terrorismo, connesso a una nuova fase di incertezza e di conflittualità a livello internazionale.
Le prospettive di ripresa dell’economia sono oggi più lontane e problematiche di quanto non sembrasse. L’Europa sta vivendo una fase di grande delicatezza sul piano politico e di grande difficoltà sul piano economico. Il nostro paese non riesce a darsi un accettabile sistema di convivenza civile e politica. E questo rende più faticoso e incerto quel processo di riforme che pure ha avuto inizio.
La crisi delle istituzioni e alleanze internazionali
Dodici anni fa, dopo la guerra del Golfo e il crollo dell’Unione sovietica, Bush padre lanciò lo slogan di un “nuovo ordine internazionale”. Molti lo intesero allora come l’annuncio di un disegno strategico. In realtà, non era altro che l’enunciazione di un problema. Si trattava di trovare un nuovo assetto, un quadro di nuovi equilibri rispetto a quelli che per tutta la lunga stagione della guerra fredda erano stati garantiti dal bipolarismo Usa-Urss.
È un problema che rimane irrisolto. Con l’aggravante che nel frattempo la situazione è diventata ancora più difficile.
Focolai di crisi si accendono continuamente in tutto il mondo. Ma il punto di maggiore criticità è ancora una volta il Medio Oriente.
A dispetto delle speranze fiorite nei primi anni ’90, c’è stata una violenta recrudescenza del conflitto arabo-israeliano, una spirale di morte che non si riesce a spezzare. E a tutto ciò si è aggiunto, o piuttosto di tutto ciò si è alimentato e si alimenta, un terrorismo di dimensioni internazionali che dall’11 settembre è diventato la dominante delle questioni politiche.
La crisi irakena ha reso fin troppo evidente che tutto il sistema delle tradizionali istituzioni e alleanze internazionali, dall’Onu alla Nato, ormai non regge più di fronte ai nuovi rapporti geopolitici. Oggi occorre perciò che il problema di stabilire un nuovo ordine internazionale acquisti finalmente un effettivo carattere di priorità assoluta.
Non spetta certo a noi suggerire ricette, né tanto meno trovare le soluzioni. Semmai, restando nei limiti del nostro ruolo, possiamo consentirci un’osservazione di buon senso.
Da una parte, un sistema rigidamente unipolare, ovvero tutto imperniato sulla superpotenza americana, alla lunga non sarebbe sostenibile per gli stessi Stati Uniti. È risaputo che qualsiasi politica estera deve basarsi su un ben calcolato equilibrio tra impegni e risorse. Significa che, quando anche volessero fare i “gendarmi del mondo”, neppure gli Stati Uniti disporrebbero delle risorse necessarie allo scopo.
D’altra parte, il mondo occidentale, ma diciamo con maggior precisione il mondo delle grandi democrazie industriali, non può prescindere dalla leadership degli Stati Uniti, non può farne a meno.
Non è questione di essere più o meno filoamericani. È questione di trarre le debite conseguenze da quello che è ormai un dato storico. È la storia del Novecento che ha legato in un binomio indissolubile l’immagine politico-sociale degli Stati Uniti e quella costellazione di valori come libertà, democrazia, uguaglianza degli uomini di fronte a Dio e alla legge, che sono la quintessenza della civiltà occidentale.
È grazie all’impegno degli Stati Uniti che siamo riusciti ad abbattere i due grandi mostri del Novecento: lo stalinismo e il nazismo. Ed è questo il motivo per cui gli Stati Uniti sono diventati il simbolo dei valori, gli ideali, i principi costituitivi della nostra civiltà.
Ecco perché è imperativo che l’Europa si costituisca come soggetto politico ed economico in grado di affiancare gli Stati Uniti.
Non si tratta solo, genericamente, di recuperare e rinsaldare l’unità del mondo occidentale incrinata dai contrasti sull’intervento in Iraq. Si tratta di farlo dando il massimo di rilievo e consistenza al ruolo dell’Europa.
Da questo dipende se il sistema internazionale potrà ritrovare stabilità. Una stabilità che oggi può essere ben diversa, in un clima più sereno, da quella che a suo tempo veniva garantita dall’equilibrio del terrore.
È solo nel contesto di un sistema internazionale abbastanza stabile che la crescita dell’economia, lo sviluppo del commercio internazionale, gli stessi processi di globalizzazione potranno esplicare tutto il loro potenziale di effetti positivi. E condizioni di stabilità sono indispensabili per quel governo mondiale dell’economia che appunto la globalizzazione ha reso sempre più necessario.
Uno sviluppo sostenibile sul piano ambientale, una risposta efficace alle aspettative dei paesi più deboli, in generale una partecipazione più equilibrata ai benefici del progresso: sono questi gli obiettivi cui deve tendere il governo della globalizzazione.
Tempi e difficoltà
della ripresa economica
Nonostante l’urto della guerra in Iraq sia stato assorbito senza troppe difficoltà, smentendo certe previsioni catastrofiche, tuttavia l’economia mondiale resta dominata dall’incertezza, dalla mancanza di fiducia, dalla preoccupazione.
Le previsioni più recenti non sono ottimistiche. Secondo il nostro Centro Studi, quest’anno il commercio internazionale crescerà del 3-4 per cento, quindi non molto più del modesto livello raggiunto nel 2002.
I primi segnali di ripresa si dovrebbero cogliere a partire dai prossimi mesi, a mano a mano che gli operatori riacquisteranno fiducia. Dovrebbero cominciare a farsi sentire gli effetti delle politiche macroeconomiche espansive avviate dai principali paesi, nonché gli effetti legati al forte calo del prezzo del petrolio.
Bisogna tuttavia rendersi conto che, al di là degli shock così frequenti negli ultimi anni – compreso quello degli scandali finanziari americani – l’incertezza delle prospettive economiche dipende da fattori strutturali di squilibrio, ben noti e da tempo materia di discussione, ma ancora da rimuovere.
Accanto ai problemi ormai decennali del Giappone e alle antiche contraddizioni dell’America Latina, l’insorgenza della Sars minaccia di provocare contraccolpi su quelle economie asiatiche – a cominciare dalla Cina – che negli ultimi anni stavano vivendo un ciclo di forte espansione. E la stessa economia americana, che è stata e resta anche per l’immediato futuro il motore fondamentale dell’economia mondiale, vive una fase di rallentamento che rende sempre più incombente il rischio di una deflazione.
Dopo lo scoppio della bolla speculativa e l’interrompersi del lungo ciclo di crescita dei mercati azionari, è apparso di drammatica evidenza che occorreva mettere mano con urgenza ad aggiustamenti di grande entità. La necessità di un processo di riequilibrio fisiologico, tale da ricreare le condizioni per lo sviluppo dell’economia americana, pone serie ipoteche sulla capacità degli Stati Uniti di continuare a trainare l’economia mondiale. O almeno sulla loro capacità di farlo con la forza dello scorso decennio.
In realtà, non possiamo aspettarci di tornare in tempi brevi ai ritmi di sviluppo che hanno caratterizzato la fine degli anni ’90 e hanno portato a una crescita degli scambi internazionali che nel 2000 ha perfino superato il 12 per cento, un valore doppio rispetto a quello medio dell’intero decennio.
Quei risultati furono raggiunti, negli Stati Uniti e in Europa, alla fine di un ciclo espansivo che aveva avuto una eccezionale durata e che per di più, nell’ultima fase, era stato drogato da un’eccessiva fiducia nelle virtù della cosiddetta “nuova economia”. Ne erano derivati valori dei corsi azionari del tutto slegati dalle effettive capacità di profitto delle aziende quotate, un boom dei consumi e degli investimenti che aveva condotto a un eccesso di indebitamento.
Oggi i corsi azionari si sono drasticamente ridimensionati. Le valutazioni degli operatori sono più ancorate ai fondamentali. Si è fortemente ridotta la crescita dei consumi e degli investimenti. In diversi settori restano considerevoli margini di capacità produttiva inutilizzata, che andrà assorbita prima che riparta un nuovo ciclo di investimenti.
L’amministrazione Bush ha messo in campo una serie di massicci investimenti sulla sicurezza e sulla difesa, insieme a una ingente riduzione del prelievo fiscale. Questi interventi, accompagnati da un dollaro basso che dovrebbe dar fiato alle esportazioni, potranno determinare quest’anno un tasso di incremento poco superiore al 2 per cento, che potrebbe salire l’anno prossimo a circa il 3 per cento. Tassi indubbiamente inferiori al potenziale di crescita degli Stati Uniti, ma certamente migliori rispetto alla media europea.
Lisbona come Maastricht
È infatti soprattutto l’Europa, più precisamente l’Europa continentale, che si trova a soffrire di pesanti squilibri strutturali.
Secondo le stime del nostro Centro Studi, quest’anno nell’area dell’euro la crescita sfiorerà a stento l’1 per cento e l’anno prossimo dovrebbe attestarsi su un modesto 1,8 per cento. La stessa Commissione europea, nelle sue previsioni, parla di prospettive che “restano fosche nell’immediato”.
Sono ormai quasi due decenni che il nostro continente ha consegnato le sorti della sua crescita a un soggetto esterno. In venti anni il prodotto interno lordo degli Stati Uniti si è quasi raddoppiato, mentre quello europeo è cresciuto solo del 60 per cento. E oggi l’Europa si trova a dover fare i conti con un duplice problema. Gli Stati Uniti da una parte non sono più in grado di trainarla come hanno fatto in passato e dall’altra, grazie al dollaro basso, stanno diventando un concorrente sempre più temibile e aggressivo. A questo si aggiunge la pressione dei nuovi concorrenti, che dall’Europa orientale all’Asia si vanno continuamente moltiplicando.
È arrivato il momento che l’Europa si svegli. Che affronti finalmente quei ritardi di competitività e sviluppo che condizionano il suo avvenire.
Tutti i paesi dell’Europa continentale, tolta in parte l’eccezione della penisola scandinava, si trovano a patire, chi più chi meno, gli stessi problemi. Popolazioni che invecchiano, servizi pubblici che stentano a reggere la pressione della domanda, insufficienti livelli di liberalizzazioni – per giunta con asimmetrie arbitrarie ed inique tra un paese e l’altro – infrastrutture spesso inadeguate, mercati del lavoro troppo rigidi, aliquote fiscali scoraggianti per le imprese, sistemi di previdenza sociale che minacciano di diventare insostenibili, poche risorse per la ricerca scientifica e i processi di formazione.
Se andiamo a vedere più da vicino, sono quasi tutti problemi che rimettono in discussione il rapporto tra sviluppo economico e protezione sociale, cioè quello che è stato finora il modello tradizionale di Welfare State.
Non è una novità, anzi è proprio in questi termini che ha posto la questione tre anni fa il Vertice europeo di Lisbona.
Alle indicazioni uscite da quel Vertice ci siamo spesso richiamati, da allora in poi, nei documenti di Confindustria. Abbiamo sostenuto e sosteniamo che Lisbona deve diventare la nuova Maastricht. Le sue direttive dovrebbero avere lo stesso carattere cogente di quelle che ci hanno portato alla moneta unica.
Ma forse occorre intenderci con maggiore chiarezza sul messaggio lanciato da Lisbona.
La sua originalità non consiste semplicemente negli obiettivi che l’Unione europea si assegna: diventare entro dieci anni “l’area più competitiva del mondo”, nell’ambito della nuova economia della conoscenza, ed entro lo stesso termine portare il livello dell’occupazione almeno al 70 per cento delle forze in età di lavoro.
Questi sono appunto gli obiettivi. Ma alle loro spalle c’è una grande consapevolezza dei problemi da mettere in agenda.
Per difendere il livello di benessere e di qualità della vita cui in Europa siamo abituati, e al tempo stesso per dare risposta ai nuovi problemi di emarginazione che si manifestano anche in queste nostre società cosiddette opulente, abbiamo bisogno di continuare a garantirci un’adeguata capacità di creazione di ricchezza e di sviluppo.
Tutto questo mentre la nostra leadership sui mercati internazionali, che davamo ormai per acquisita, viene ogni giorno erosa dai paesi emergenti. Grazie a standard sociali ed ambientali più bassi e a un sempre più facile accesso alle nuove tecnologie, all’informazione e all’innovazione, questi paesi tendono a metterci fuori gioco offrendo prodotti non solo a costi minori, ma anche di qualità crescente.
Di fronte a una sfida di questa portata non possiamo e non vogliamo scivolare in una logica neoprotezionistica, né al contrario possiamo pensare di ridurre il nostro grado di protezione sociale e di tutela ambientale.
La risposta che dobbiamo saper dare è quella di riposizionare l’economia europea sullo scacchiere della competizione globale, aumentando le dosi di intelligenza e di conoscenza incorporate nei nostri prodotti, migliorando i contenuti di professionalità, rendendo più flessibile il mercato del lavoro in modo da facilitare l’incontro tra domanda e offerta.
Il messaggio di Lisbona è questo.
Lo condividiamo senza riserve. E diciamo a chiare lettere che è del tutto estranea alle nostre intenzioni, come imprenditori responsabili che vivono in azienda a fianco dei loro lavoratori, l’idea di passare dal Welfare State alla Welfare Society. Di passare cioè a un sistema dove il mercato è l’unico regolatore sociale, l’unico meccanismo che discrimina i bisogni e distribuisce le risorse.
Noi vogliamo invece passare dal Welfare State tradizionale a un nuovo Workfare State. Si tratta di muoversi lungo due direttrici. In primo luogo, preparare le giovani generazioni a svolgere con competenza le funzioni che richiede il nuovo modo di fare impresa, di fare economia. In secondo luogo, predisporre percorsi di riqualificazione per coloro che non trovano più posto nel sistema produttivo, ma sono ancora in grado di dare un loro contributo.
È la logica del Workfare State come sistema che, senza trascurare altri aspetti, è soprattutto impostato sull’obiettivo di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro a chi ne è ancora fuori o ne è stato escluso. E verso un tale modello dovrebbe orientarsi l’Europa per potere ristabilire un circuito virtuoso tra protezione sociale e sviluppo economico.
È così che si riacquista un alto livello di competitività. Ed è così che si risponde a una delle più profonde ansie del nostro tempo. La continua crescita esponenziale della conoscenza e la sua diffusione immediata su scala mondiale migliorano la qualità e la durata della vita, aprono nuove frontiere, allargano l’orizzonte delle opportunità. Ma al tempo stesso rendono subito obsoleto il nostro patrimonio di sapere e di professionalità.
È questa la fonte di quella insicurezza, di quella che tutti avvertono come precarietà. Non ci sono più punti di riferimento fissi, non ci sono certezze che durano.
Questo processo di cambiamento è ineluttabile. Non si può arrestarlo. Una società che cerca di rifugiarsi dietro le sue tradizionali barriere protettive, è destinata al declino. Al contrario, una società che si apre, che supera la paura del nuovo, che allenta le sue vecchie rigidità, governa le flessibilità sconfiggendo la precarietà e moltiplicando le opportunità.
Il rilancio dell’economia europea
Dobbiamo però constatare che, rispetto agli obiettivi di Lisbona, in questi tre anni proprio i paesi più direttamente interessati si sono mossi poco o niente.
Non riesce ad entrare nel senso comune l’idea che l’Europa, se vuole rilanciarsi, deve ringiovanire le sue strutture economiche e sociali, i suoi modelli di convivenza, la sua stessa cultura.
E non è da oggi che l’Europa è in ritardo nell’affrontare i nodi della sua competitività. Molti degli obiettivi fissati da Delors nel suo Libro Bianco del ’93 non sono stati ancora realizzati: dal completamento del mercato unico alla piena liberalizzazione dei mercati, dall’integrazione della rete logistica alla riforma dei mercati finanziari, solo per citare gli esempi più evidenti.
Ci sono riforme che devono essere fatte dai singoli Stati: per esempio appunto il Welfare, il mercato del lavoro, i sistemi di istruzione e formazione. E ci sono invece questioni che possono e debbono trovare una loro risposta a livello comunitario. Anzitutto un disegno complessivo di politica economica che integri e al tempo stesso sostenga le politiche economiche nazionali.
La creazione dell’euro avrebbe implicato che accanto alla Banca Centrale Europea, come istituzione tecnica responsabile del governo monetario, si individuasse al più presto un’istituzione politica capace di impostare e gestire la politica economica europea per rilanciare competitività e sviluppo.
Il ruolo che l’Europa deve assumere nel contesto mondiale esige una sua capacità di articolare politiche macroeconomiche di ampio respiro.
Oggi, di fronte alla grave crisi di crescita che l’Europa sta vivendo, paghiamo tutto il costo di una costruzione esclusivamente monetaristica dell’Unione europea. Un costo aggravato da una gestione della moneta focalizzata sulla difesa da un’inflazione che non rappresenta più un pericolo reale in una fase in cui tutto il mondo teme la deflazione. Il minimo da fare è abbassare i tassi.
In un modello rigorosamente coerente, anche questa istituzione politica avrebbe dovuto avere, come la Banca, un carattere federale. Ma finché non sarà possibile l’unità europea su basi federaliste, bisognerà procedere col rafforzamento del metodo intergovernativo, che nelle attuali condizioni è l’unico agibile.
Questo è uno dei punti sui quali ci aspettiamo che la Convenzione possa fornire indicazioni chiare e risolutive.
Nel frattempo la competitività del nostro continente resta per lo più affidata alla responsabilità dei singoli Stati, naturalmente secondo i criteri e i parametri fissati dal Patto di stabilità e crescita. Quel Patto che peraltro mette l’accento più sulla stabilità che sulla crescita.
La crisi di competitività e la lunga congiuntura sfavorevole rendono necessario rilanciare gli investimenti pubblici qualificanti, che oggi sono soprattutto quelli sulla ricerca e le infrastrutture. L’effetto benefico sarebbe duplice: sostenere la domanda e l’occupazione nel breve termine e al tempo stesso mettere in moto un processo di crescita più forte e duraturo.
Una visione troppo ragionieristica del Patto di stabilità impedisce oggi di procedere in tal senso.
Per questo pensiamo sia importante reinterpretare il Patto applicando la “golden rule”, cioè quel criterio che permette di sottrarre al calcolo del disavanzo gli investimenti in infrastrutture e ricerca che possono avere una positiva ricaduta sulla competitività di tutta l’area.
La golden rule, se correttamente interpretata, non indebolisce l’unione monetaria, ma la rafforza.
In materia di finanza pubblica non contraddice la politica del rigore, che deve continuare. Mentre, ridando slancio al processo di crescita, permette di consolidare il ruolo dell’euro e di allargare l’ambito dei paesi che intendono accedere all’unione monetaria.
La nuova grande Europa
I temi di carattere economico, per quanto nell’edificio comunitario facciano da chiave di volta, sono tuttavia solo un aspetto della questione europea come si presenta attualmente. Insieme ai problemi della sua competitività economica, l’Europa deve infatti risolvere problemi di integrazione e coesione sociale, di unità politica, di identità, di rinnovamento e riorganizzazione istituzionale.
Tutto ciò nel fuoco di una situazione che non potrebbe essere più contraddittoria: tanto da apparire, per certi versi, anche paradossale.
Da una parte, con l’etichetta riduttiva del cosiddetto allargamento, sta entrando in dirittura d’arrivo un processo di riunificazione che, ricongiungendo l’Europa dell’Est a quella occidentale, l’Europa del Sud Mediterraneo a quella nord-centrale, ha una portata non solo storica ma addirittura epocale.
Dall’altra parte, al tempo stesso, tra tutti i paesi in campo, sia quelli già comunitari, sia quelli ormai alle soglie, sono scoppiate, sulle scelte relative alla guerra in Iraq, divisioni così laceranti che l’Europa unitaria sta vivendo in questi mesi la più grave crisi politica di tutta la sua storia ormai cinquantennale.
Di fatto la vicenda irakena ha dimostrato, o meglio ha reso evidente che oggi l’Europa non c’è. Non esiste come soggetto politico. Se certo non è solo un’espressione geografica, non può però nemmeno rimanere solo un’espressione di carattere economico.
In questi ultimi anni un sincero entusiasmo, peraltro troppo spesso condito di un pericoloso eccesso di euroretorica, ci ha indotto a nasconderci contraddizioni che vanno finalmente affrontate.
La Convenzione può e deve essere la sede dove si sciolgono questi nodi, che ruotano essenzialmente intorno ai problemi di come si rafforza la coesione e l’unità politica dell’Europa, come si accorciano le distanze tra i cittadini europei e le loro istituzioni, come e soprattutto da chi viene governata l’Unione europea.
Occorre che la riforma delle strutture di governance sia fatta con grande chiarezza e senza ambiguità, prima che entri in vigore l’allargamento già deciso.
Oggi si sta andando verso un incrocio tra i due modelli in discussione, quello comunitario e quello intergovernativo. Se questa sarà la soluzione conclusiva, rischiamo di trovarci di fronte a una “non scelta”, un compromesso che magari migliora la qualità e la velocità del processo decisionale, ma lascia irrisolta la questione di un assetto definitivo più coerente e razionale.
Ben difficilmente così i cittadini europei si sentiranno più vicini a istituzioni sulle quali hanno un potere di controllo minimo e del tutto indiretto, mentre sono sempre più soggetti alle loro decisioni.
Se vogliamo evitare che, moltiplicando le esigenze e le esperienze da far convivere, lo stesso allargamento finisca col rendere la fisionomia dell’Unione europea ancora più grigia e indistinta di quanto già non lo sia. Se vogliamo porre le premesse perché l’Unione possa finalmente mettere a frutto la sua natura di coalizione internazionale al tempo stesso moderna e antica, la sua originalità come centro di attrazione e insieme irradiazione culturale, il suo millenario patrimonio di sapienza politica e sociale, insomma il suo ruolo di pilastro della civiltà occidentale, a fianco di quell’altro pilastro che sono gli Stati Uniti. Se vogliamo tutto questo, allora dobbiamo anzitutto preoccuparci che l’Europa metta radici nel cuore dei suoi cittadini, riscuota la loro fiducia, venga effettivamente vissuta e riconosciuta come patria comune.
Per avere un pò più di Europa, abbiamo bisogno di più politica. E dal momento che oggi non è politicamente agibile la via del modello federale, piuttosto che scegliere l’Europa delle tecnocrazie, scegliamo l’Europa dei governi.
E per una buona governance dell’Unione sarà necessaria una “cabina di regia” che abbia un ruolo di guida e di indirizzo.
Qui c’è da mettere bene in chiaro un punto, e può essere significativo che siamo noi imprenditori a farlo: l’Europa non è solo un fatto di convenienze economiche.
L’idea che potesse essere l’economia a trainare l’Europa verso la sua unità fu a suo tempo una felice intuizione dei Padri Fondatori. Ma il loro progetto era fin dagli inizi quello dell’unità politica.
E per quanto un’integrale realizzazione di questo obiettivo sia ancora problematica, tuttavia noi siamo una generazione cui l’Europa ha già assicurato un dividendo di valore inestimabile: la pace, la riappacificazione di popoli che si sono combattuti nel corso di tutta la loro storia.
È paradossale che divisioni laceranti si siano prodotte nel momento in cui si chiede all’Europa di contribuire insieme con gli Stati Uniti ad esportare oltre i suoi confini quei valori di pace e democrazia che sono costitutivi della sua unità.
I traguardi del semestre italiano
Il compito di recuperare lo strappo tra i paesi europei e tra questi e gli Stati Uniti rappresenta la più immediata priorità del semestre italiano di presidenza dell’Unione europea.
Continuando sul registro della politica internazionale, un’altra delle grandi priorità del semestre italiano dovrebbe essere l’assunzione di un ruolo attivo nel ricostituire un quadro di stabilità e pace nel Medio Oriente.
L’Europa può avere in questo senso una parte estremamente importante a fianco degli Stati Uniti. Israele tende a privilegiare il rapporto con gli Stati Uniti. Gli Stati Arabi tendono a privilegiare il rapporto con gli europei. Solo europei e americani insieme possono avere la forza e la credibilità necessaria per bilanciare reciproche paure e aspettative.
E questo l’Europa potrà farlo solo se saprà assumere una posizione coesa e unitaria, chiara e netta, senza equivoci né ammiccamenti, sui rapporti euro-atlantici e sulla lotta al terrorismo.
Finora abbiamo mancato di farlo, perché i singoli paesi hanno preferito badare ai propri specifici interessi, spesso non senza tatticismi e ambiguità, e nessuno si è preoccupato di dare all’Europa, come soggetto unitario, un suo titolo di presenza e di intervento.
Oggi si può e si deve. Non è più possibile continuare ad essere assenti. Siamo arrivati a un punto di svolta. O si stabilisce la pace adesso, oppure il Mediterraneo rischia di incendiarsi. E quella è casa nostra.
A parte le questioni di geopolitica, è interesse di noi paesi mediterranei e di tutta l’Europa che si diffondano in quest’area condizioni di benessere e prosperità. Anche per alleggerire quei flussi migratori che diversamente non riusciremmo né ad assorbire, né a mettere sotto controllo.
Negli ultimi anni, grazie allo sviluppo delle economie asiatiche, il Mediterraneo sta riacquistando nei traffici internazionali quella centralità che aveva perduto cinque secoli fa con la scoperta dell’America.
E la ritrovata centralità del Mediterraneo non fa bene solo all’Europa del Sud, ma a tutta la nuova grande Europa che stiamo costruendo. Perché è proprio attraverso il Mediterraneo che ci possiamo collegare ai mercati dell’Estremo Oriente.
Perciò occorre costruire infrastrutture europee che non solo colleghino Est e Ovest e integrino nel mercato europeo i paesi entranti, ma colleghino anche Nord e Sud.
Non è dunque solo per un pur legittimo interesse nazionale che l’Italia, proprio durante questo suo semestre di presidenza, deve battersi perché si realizzino i Corridoi 5 e 8, che sono vitali per le imprese italiane.
Peraltro, l’impegno sulle infrastrutture transnazionali è solo un aspetto di quell’operazione di rilancio della competitività europea che deve essere l’asse portante del semestre di presidenza italiana.
Il progetto di Lisbona deve essere non solo ripreso con determinazione, ma deve diventare un vero e proprio piano d’azione.
Insieme alle infrastrutture, gli altri due punti chiave sono una nuova politica della ricerca e la riforma del Welfare.
Dobbiamo cambiare radicalmente il modo in cui si fa la politica della ricerca in Europa.
In realtà, oggi una politica europea della ricerca non c’è. C’è solo un insieme di politiche nazionali cui si sovrappone un minimo di politica europea.
Lisbona ha fissato l’obiettivo di portare entro il 2010 la spesa complessiva di ciascuno Stato membro al 3 per cento del prodotto interno lordo. Raggiungere questo obiettivo sarebbe di per sé già uno straordinario successo. Ma la questione non è solo aumentare l’impegno di ciascun paese, quanto piuttosto fare massa critica a livello comunitario e avere la capacità di individuare e coinvolgere gli Stati membri su progetti integrati, finalizzati a migliorare il livello di competitività dell’economia europea.
Si tratta non solo di avere più risorse a disposizione, ma di non sprecarle. E questo vale non solo per i paesi membri, Italia in testa, ma anche per l’intera Europa.
Cambiare radicalmente la ricerca in Europa vuol dire anche riqualificare il sistema universitario in modo che possa attrarre e mantenere i cervelli. Non è un problema che affligge solo l’Italia, ma anche la più gran parte dei paesi europei.
Il confronto statistico tra Stati Uniti ed Europa è impietoso. Nel 2001 la spesa totale in ricerca ha superato i 280 miliardi di dollari negli Stati Uniti, mentre non ha raggiunto i 180 miliardi in Europa. Nello stesso anno, per ogni milione di abitanti l’Europa ha registrato 80 brevetti, contro i 322 degli Stati Uniti. Nel settore ricerca e sviluppo l’Europa occupa l’1,3 per cento della sua forza lavoro, gli Stati Uniti il 7,4 per cento.
Quanto alla riforma del Welfare State, se è vero che la più gran parte dei paesi continentali hanno su questo terreno problemi comuni, nondimeno è anche vero che in ogni paese questi problemi si presentano con profili diversi in quanto riflettono variabili nazionali come lo stock del debito pubblico, la dinamica demografica, il ritmo di crescita del prodotto interno lordo, la configurazione complessiva della spesa sociale e la sua articolazione, i vincoli del sistema politico-istituzionale.
Questo comporta che ciascun paese dovrà trovare le sue soluzioni. Ma l’importante è che tutti si muovano lungo direttrici che convergono verso i traguardi indicati da Lisbona: più competitività, più occupazione, più economia della conoscenza.
Le politiche per la crescita
La situazione dell’economia italiana è negativa. Permane un quadro di stagnazione che per il momento non presenta segnali di ripresa.
Non ci consola il fatto che tutta l’area dell’euro si trovi in una situazione più o meno simile alla nostra. Certo, la crisi è mondiale. Ma non dobbiamo dimenticare che, pur in crisi, Stati Uniti e Gran Bretagna cresceranno quest’anno sopra il 2 per cento.
Quello che più preoccupa è che per tutti gli anni ’90 l’Italia, pur in una fase di relativa espansione, è cresciuta meno della media europea e molto meno degli Stati Uniti.
In questi mesi dobbiamo adottare quelle riforme strutturali che consentano all’economia italiana di riprendersi con maggior vigore, sfruttando al massimo le nuove norme sul mercato del lavoro.
Con il Patto per l’Italia si sono destinate ingenti risorse (circa 4 miliardi di euro) a una manovra di riduzione dell’Irpef nella speranza che si creasse fiducia e si sostenessero i consumi.
I dati Istat, purtroppo, ci dicono che nel primo trimestre del 2003, cioè nel periodo in cui la riduzione dell’Irpef avrebbe dovuto dare i suoi effetti, abbiamo avuto un segno negativo nella crescita del Pil, cosa che non accadeva dal trimestre successivo all’11 settembre.
È giusto ridurre le tasse. È giusto sostenere i consumi. Ma oggi bisogna puntare a misure che nel breve diano una spinta agli investimenti e nel medio rafforzino la competitività dei nostri prodotti.
Il Governo ha davanti a sé gli appuntamenti del Dpef e della legge finanziaria. È allora che potrà dimostrare la sua volontà di rilanciare l’economia.
Per poter fare una Finanziaria per lo sviluppo, l’Italia dovrà però presentarsi con le carte in regola in Europa. Non solo perché si sarà ulteriormente avvicinata agli obiettivi di riduzione del deficit, ma anche perché avrà definitivamente messo mano a una riforma strutturale del sistema pensionistico, che ponga la nostra finanza pubblica al riparo da gravi squilibri per gli anni a venire.
Non si può continuare con provvedimenti una tantum che certo sono serviti a fronteggiare l’emergenza, ma non hanno avviato un effettivo processo di risanamento.
Solo facendo una riforma strutturale delle pensioni prima della Finanziaria, il Governo potrà fare una manovra per rilanciare l’economia.
Intanto, stiamo lavorando con Cgil, Cisl e Uil su quattro capitoli essenziali per migliorare la capacità competitiva del paese.
In vista del Dpef avanzeremo delle proposte al Governo. Sono proposte per rilanciare la ricerca, la formazione, le infrastrutture, il Mezzogiorno.
Queste sono le nostre priorità, che del resto erano state già accolte nel Patto per l’Italia.
Sulla ricerca si tratta di fare un intervento di ampio respiro. Non i soliti piccoli accantonamenti che servono a mala pena a risolvere qualche problema pregresso.
La ricerca deve essere nel 2004 la vera grande priorità del nostro paese.
Deve essere l’anno della svolta nel rilancio degli investimenti, nella riorganizzazione dei centri di eccellenza. Serve uno straordinario impegno.
Sulle infrastrutture c’è un rinnovato impulso che vede coinvolto operativamente lo stesso Presidente del Consiglio.
È importante che il 2004 sia l’anno delle realizzazioni, dei cantieri che si aprono. Le infrastrutture daranno un forte sostegno allo sviluppo sia nella loro fase di realizzazione che per il miglioramento delle condizioni produttive del paese.
La formazione è il grande impegno delle parti sociali per i prossimi mesi. La nuova legge ha reso più moderni gli strumenti e le regole del mercato del lavoro. Ora dobbiamo avere strumenti che aggiornino e migliorino la professionalità delle persone.
La vera tutela del lavoratore è la sua professionalità.
Il 2003 è stato l’anno delle nuove regole. Il 2004 dovrà essere l’anno della persona: dobbiamo valorizzarla, investire sulla sua formazione.
Questo è il concetto di adattabilità, l’evoluzione della flessibilità. È il concetto tanto caro a Marco Biagi.
Le politiche per l’adattabilità sono quelle politiche che migliorano l’incontro di qualità tra domanda e offerta di lavoro, sono quelle politiche che creano le professionalità e le fanno incontrare con la domanda di lavoro professionalizzato delle imprese.
Ma è evidente che nel breve bisogna puntare a una rapida ripresa degli investimenti. Bisogna creare le condizioni per stimolare gli investimenti e attrarne di nuovi dall’estero.
Signor Presidente del Consiglio,
la riduzione fiscale è stata il principale impegno della sua campagna elettorale.
Ha dovuto affrontare problemi di finanza pubblica, ha dovuto fare i conti con un ciclo economico negativo, con una grave crisi internazionale. Tutto ciò è vero. Ma ora è il momento di intervenire.
A fianco di politiche di qualificazione e aumento della domanda pubblica con le spese di investimento, il Governo deve ridurre la pressione fiscale sulle imprese.
Ancora una volta, in questi mesi, gli oneri del riaggiustamento della finanza pubblica si sono riversati sulle imprese. Ed è stato fatto in un modo brusco, da noi contestato, che ha modificato in corso d’anno la base imponibile delle imprese.
È stata una misura che ha dato molto gettito alle casse dello Stato e che ha risolto gran parte dei problemi di finanza pubblica di breve periodo: ha migliorato i conti del trimestre. Ma è stata una misura che non ha certo migliorato il clima di fiducia delle imprese, né dato certezze agli investitori esteri.
Se a questo aggiungiamo il condono e il forte ritardo nei pagamenti dei crediti fiscali, il ritardo nei pagamenti delle forniture pubbliche, possiamo dire che sono soprattutto le imprese che stanno sostenendo l’impegno del paese di mantenere basso il deficit.
Questo dovrebbe preoccupare il Governo.
Le imprese non votano, Signor Presidente, ma fanno lo sviluppo e l’occupazione.
Quanto può durare una situazione nella quale nessuno trova più convenienza ad investire in Italia?
Metta mano, con la prossima Finanziaria, alla riduzione dell’aliquota Irpeg. Applichi da subito la riforma Tremonti. Metta mano all’Irap, tassa odiosa, iniqua e soprattutto tassa che colpisce il lavoro.
Dia un forte segnale di sostegno agli investimenti.
La ripresa arriverà, speriamo, nel 2004. Dobbiamo presentarci a quell’appuntamento con un paese nel quale è più conveniente investire. Verrà crescita, verrà ricchezza, verrà occupazione.
Razionalizzi pure il sistema di incentivi e di trasferimenti inefficienti alle imprese pubbliche e private.
Ma adesso riduca le tasse anche per le imprese.
Faccia dell’Italia un’area in cui sia conveniente investire. Non rinvii questa decisione.
La prossima Finanziaria è l’ultima occasione. Dovrà generare la ripresa.
La nostra Confindustria
La realtà dell’impresa italiana in questi anni è profondamente cambiata.
C’è chi ha parlato di declino industriale. In realtà, sono anni che il nostro paese soffre di una forte crisi di competitività, ma non c’è mai stata e continua a non esserci una crisi di vocazione imprenditoriale. Anzi.
Alcune grandi crisi aziendali – è vero – hanno moltiplicato, sul piano mediatico, la sensazione di un impoverimento del paese, che pure c’è stato. Ma oggi quelle stesse imprese stanno compiendo uno straordinario sforzo di ristrutturazione e di rilancio. Noi sappiamo, e lo abbiamo anche chiarito e dimostrato a Torino, che non c’è nessun declino imprenditoriale.
Il sistema delle imprese italiane è vivo e attivo. C’è un capitalismo di mercato che si confronta ogni giorno con la concorrenza globale, pronto a investire.
Crediamo in noi stessi, nella nostra capacità di fare prodotti innovativi, di sfidare la concorrenza sui mercati mondiali. E in questo sappiamo di poter contare su un talento imprenditoriale che non ha eguali.
Insomma, siamo orgogliosi di essere imprenditori italiani, di esportare lavoro, di produrre e vendere nel mondo.
Siamo preoccupati, questo sì, per la situazione di stagnazione dell’economia mondiale che si protrae da troppi mesi, ma siamo fiduciosi sul futuro e intendiamo continuare a creare opportunità di lavoro, a promuovere sviluppo e benessere.
Questa Confindustria ha voluto cogliere i segni del cambiamento che stava maturando e ha dato fino in fondo rappresentanza a quel capitalismo di mercato che accetta le sfide della competizione globale, rinunciando a ogni tentazione di vecchie e nuove protezioni.
Una nuova generazione di imprenditori sta emergendo, si afferma sui mercati internazionali, vuole far crescere le proprie imprese. Non crede più che piccolo sia bello, ma sa che per reggere la concorrenza nell’economia globale deve continuamente cambiare il modo di produrre, il modo di organizzare la propria impresa. Vuole il cambiamento, sa di avere bisogno di un paese più moderno, ha ansia di riforme.
Le frontiere della crescita sono oggi la ricerca, l’innovazione, la formazione del capitale umano. Sono un efficiente sistema di infrastrutture e di logistica, l’uso intelligente delle tecnologie informatiche.
Confindustria in questi anni, senza ambiguità e senza ipocrisie, ha lavorato per difendere un così grande patrimonio nazionale. Siamo convinti che questo patrimonio resta il migliore investimento per assicurare all’Italia un futuro solido. Sarà il paese intero a trarne vantaggio.
La qualità della nostra vita, il benessere dei cittadini italiani dipendono dalla capacità del nostro paese e delle nostre aziende di produrre ricchezza e di avere sistemi equi ed efficienti per redistribuirla.
Confindustria ha scelto di battersi per la modernizzazione del sistema paese e dello stesso sistema produttivo.
Per questo lavoriamo.
Per questo abbiamo posto con forza la questione della competitività. Sappiamo che è la grande questione europea e nazionale. E oggi finalmente constatiamo che tutte le forze politiche, di centrodestra e di centrosinistra, le stesse organizzazioni sindacali, la riconoscono come tale.
Siamo consapevoli che solo più crescita e più occupazione potranno risolvere gran parte dei nodi strutturali del nostro paese. E sappiamo quali sono le scelte che devono essere compiute per ridare slancio alla nostra economia. Le elencammo a Parma nel 2001 e non abbiamo mancato di ribadirle in ogni occasione. Sono state la bussola della nostra azione.
Confindustria è impegnata a diffondere la cultura dell’innovazione. Vogliamo radicare questi valori di modernizzazione e competitività in tutto il sistema imprenditoriale e in tutta la società italiana. Noi crediamo nel modello di una rappresentanza industriale che non scambia favori, ma negozia riforme utili per tutti.
Noi abbiamo fatto questa scelta. Sappiamo che il processo di cambiamento non è finito. E sappiamo che c’è sempre il rischio di tornare indietro. Ma noi in quelle scelte ci abbiamo creduto, abbiamo combattuto battaglie anche dure per realizzarle.
Mettiamo al centro della nostra strategia di sviluppo la persona, l’individuo. Puntiamo sui nostri giovani, sulla loro preparazione professionale, sulla loro voglia di emergere, di affermarsi, di diventare liberi e autonomi.
Vogliamo avere una scuola migliore, un sistema universitario e d’impresa che imparino a lavorare insieme per la ricerca e per l’innovazione. È per questo che condividiamo la riforma Moratti.
Dobbiamo dare a tutti la possibilità di contribuire allo sviluppo del nostro paese. Dobbiamo dare a ognuno la possibilità di esprimersi al massimo delle sue attitudini.
Dobbiamo credere nei giovani, bisogna che siano davvero al centro delle nostre priorità, del nostro impegno.
L’Italia che invecchia deve essere generosa verso le nuove generazioni e rinunciare ad antichi egoismi.
È in questo spirito che dobbiamo ripensare il nostro Welfare. Dobbiamo inquadrarlo in una visione più ampia che vada oltre gli interessi di coloro che stanno per andare in pensione e le necessità immediate della prossima Finanziaria.
Occorre attuare una chiara, forte, condivisa azione di riequilibrio intergenerazionale, lasciando – sì – libera la scelta di andare in pensione, ma ponendo tutti di fronte alla responsabilità di assicurare un futuro anche alle nuove generazioni.
Chi sceglierà la pensione anticipata dovrà percepire qualcosa in meno di chi sceglierà di restare al lavoro, accorciando così la durata del suo pensionamento.
Sia ben chiaro, questa riforma non va fatta solo per i giovani di domani, ma anche per i giovani di oggi. Il loro ingresso nel mercato del lavoro è ostacolato dal più oneroso cuneo fiscale e contributivo d’Europa.
Dobbiamo ridurre da subito il peso della contribuzione, perché ci sia una maggiore propensione ad assumere. Dobbiamo da subito assicurare ai giovani i vantaggi di questa riforma. E per questo siamo disposti anche a rinunciare agli attuali incentivi per le nuove assunzioni, che rischiano di drogare il mercato del lavoro.
Da questa riforma deve uscire un’Italia in cui le persone lavorano più a lungo offrendo la loro professionalità e ci sono più giovani che entrano nel mercato del lavoro.
Grazie alla riforma, questi giovani non vedranno ridursi il livello di copertura pensionistica. Anzi, attraverso una forte previdenza integrativa, potranno vederlo accresciuto.
In Italia stiamo realizzando un nuovo mercato del lavoro.
Il Governo ha varato una riforma che potrà finalmente assicurarci un collocamento più moderno dove si potranno incontrare in modo più efficiente domanda e offerta di lavoro.
Sono state create nuove tipologie di contratti per adattare il lavoro alle nuove esigenze del mondo produttivo e dell’individuo.
Altro che precarietà.
La legge Biagi aumenta le opportunità per tutti e crea più lavoro stabile.
È la flessibilità la vera arma contro la precarietà.
Abbiamo introdotto nuove tutele e stabilizzato i rapporti di lavoro.
Anche il nuovo contratto a termine introdotto con l’avviso comune del 2001 sta dando i suoi frutti. Ci siamo allineati all’Europa e abbiamo creato uno strumento utile per consentire un’esperienza professionale a tanti giovani.
Ci siamo battuti per creare un contesto più semplice e più flessibile per la governance delle imprese.
Nello stesso tempo ci siamo posti l’obiettivo di dare più fiducia ai mercati, ai risparmiatori. Le gravi crisi societarie internazionali, ma anche domestiche, hanno prodotto un diffuso clima di sfiducia al quale dobbiamo rispondere con la trasparenza nella gestione delle nostre imprese.
Il nuovo diritto societario, recentemente varato dal Governo, i nuovi codici di autoregolazione e di governance, i nuovi modelli organizzativi che possono essere oggi adottati dalle imprese, vanno nella giusta direzione.
Scuola, lavoro e diritto societario sono dunque tre grandi riforme strutturali di cui diamo merito al Governo.
Ora però deve riprendere con forza la battaglia ormai abbandonata della riforma della Pubblica Amministrazione.
In tutte le classifiche mondiali della competitività l’Italia è agli ultimi posti soprattutto a causa della gravissima inefficienza della Pubblica Amministrazione.
Ci sono stati in Italia anni in cui sembrava essersi radicata la convinzione che occorreva un cambiamento. Tutto si è fermato.
È tornata una cultura della conservazione, della salvaguardia delle caste dei dipendenti pubblici, di nuovo considerati un serbatoio di voti e non più i protagonisti, attivi e responsabili, della riforma.
I recenti contratti dei settori pubblici stanno lì a dimostrarlo. Di nuovo aumenti fuori dalle regole fissate dall’accordo del 23 luglio, di nuovo soldi dati a pioggia, a tutti, a chi lavora bene e a chi fa poco, senza premi per la qualità, la produttività, il rendimento.
Lo stesso processo di semplificazione va avanti a rilento in una logica di piccoli e piccolissimi passi, che non porta da nessuna parte.
Signor Presidente del Consiglio,
non è la quantità delle leggi approvate dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento che deve essere portata a dimostrazione della azione di governo.
Al contrario, Lei dovrebbe enumerare le leggi abolite, i procedimenti eliminati, le amministrazioni inutili chiuse.
Non serve approvare più leggi, ma sciogliere più lacci.
Dobbiamo ridurre il perimetro d’azione della Pubblica Amministrazione, non aumentarlo e difenderlo come una roccaforte.
Apra una grande stagione parlamentare di semplificazione. Non si governa solo legiferando. Si governa anche e soprattutto riducendo e semplificando il nostro apparato normativo, liberando da inutili vincoli l’economia e l’iniziativa privata.
La giustizia civile e amministrativa, non solo quella penale, è sicuramente, in Italia, fonte di incertezze e di lungaggini, per le imprese come per i cittadini.
Tutto ciò pesa sulla competitività dei nostri prodotti e sulla capacità del nostro paese di attrarre investimenti. Ma quanta di questa inefficienza è dovuta anche al complesso, oceanico quadro legislativo, normativo e giurisprudenziale nel quale opera il nostro sistema giudiziario?
Immagini che cosa potrebbe succedere se il federalismo diventasse l’ennesima occasione per moltiplicare leggi, vincoli e apparati pubblici, invece che deregolamentare, ridurre e semplificare.
Ci siamo battuti per il Mezzogiorno perché ci crediamo.
Quest’area rappresenta la grande potenzialità di sviluppo del paese, soprattutto per il Nord che è saturo e sempre più costretto a produrre con risorse sempre più scarse, naturali ed umane.
L’Italia e l’Europa hanno bisogno di un Sud in grado di attrarre investimenti interni ed esteri.
Nel corso dell’ultima Finanziaria abbiamo dovuto intraprendere una dura battaglia, alleati con le organizzazioni sindacali, per evitare un tentativo di ridurre e modificare gli interventi di rilancio del Mezzogiorno.
Non ci ha mosso la vecchia logica assistenzialista, ma la consapevolezza che il Sud soffre la concorrenza di aree del mondo, anche a noi molto vicine, dove si può produrre a costi infinitamente più bassi.
Ma non sono solo i costi che fanno il prodotto competitivo. Nel Sud c’è un patrimonio di cultura industriale e di civiltà che rappresenta un grande valore per le imprese. Mancano però le infrastrutture, una Pubblica Amministrazione efficiente, un clima favorevole all’iniziativa privata.
Nella logica del Patto per l’Italia il Governo ha convenuto con noi sulla necessità di riposizionare il Mezzogiorno al centro delle politiche di sviluppo del paese. E ha messo a disposizione le risorse perché questo accada.
Sono risorse, peraltro ammesse dall’Unione europea, per aiutare gli investimenti. Le Regioni devono dimostrare da subito di saper spendere – e bene – i fondi comunitari.
La capacità di attrarre investimenti, unico autentico indicatore di una vera svolta per il Sud, dipenderà molto dall’impiego intelligente di quelle risorse.
Non abbiamo più tempo. Tra qualche anno, con l’ingresso nell’Unione europea dei nuovi paesi, quelle risorse non saranno più disponibili.
Apriamo allora da subito, proprio nel semestre di presidenza italiana, una grande questione europea perché vengano ammesse nelle aree meno sviluppate aliquote fiscali differenziate.
Altre aree europee con questo strumento hanno registrato negli ultimi anni tassi di crescita molto alti.
Anticipiamo la riduzione dell’Irap, a cominciare dal Sud. Facciamolo con la prossima Finanziaria.
Se riusciamo ad impostare un regime fiscale differenziato, più leggero, stabile e certo nel tempo, ci potremmo liberare da mille procedure complesse e incerte sotto il profilo della finanza pubblica e genereremmo una forte crescita di investimenti e di reddito che potrà avere positivi effetti anche per le casse dello Stato.
Il nuovo dialogo sociale
Le parti sociali possono essere le protagoniste di molte di queste riforme e in questi anni, in Italia, le più responsabili lo sono state.
Abbiamo costruito un nuovo metodo di relazioni industriali, il nuovo dialogo sociale.
Appena due anni fa fummo accusati di voler distruggere il sistema delle relazioni sindacali, di volere solo lo scontro sociale. Non era vero. E i fatti lo hanno dimostrato.
La nuova forma di dialogo ha generato importanti riforme, ha creato una nuova cultura che si va radicando nel mondo del lavoro, nel mondo delle imprese, nel paese.
Credo che solo la politica sia pienamente legittimata a rappresentare gli interessi generali della società. Noi parti sociali possiamo dare il nostro contributo. E potremo farlo solo se sapremo guardare anche al di là degli immediati interessi dei nostri associati.
Ecco il nuovo modello che abbiamo costruito in Italia in questi anni. Non abbiamo cercato uno scambio reciproco di convenienze, ma abbiamo guardato al di là del nostro perimetro di rappresentanza.
Lo ha fatto il mondo delle imprese quando ha lanciato la sua offensiva contro l’economia sommersa, quando ha fatto sua l’esigenza di maggiore equità con un nuovo progetto di tutele e di sostegni sociali per chi è ai margini del mondo del lavoro.
Lo ha fatto il sindacato quando ha accettato di aumentare la flessibilità del mercato del lavoro, riuscendo così a rappresentare effettivamente anche i disoccupati.
Lo facciamo, ancora, quando rinunciamo al diritto di veto e chiediamo di farlo anche alle nostre controparti, nella convinzione che rinunciare tutti a qualcosa è il solo modo per non bloccare il processo riformatore.
Chi non ha voluto rinunciare a nulla lo ha fatto per affermare la propria presenza politica.
Crediamo nella contrattazione.
Crediamo nella possibilità di chiedere al legislatore un maggior ruolo della contrattazione sia nel definire normative e regole del mercato del lavoro sia nella gestione delle politiche attive del lavoro.
Ma dobbiamo dimostrare, continuare a dimostrare, che non è un semplice scambio flessibilità/salario a esclusivo vantaggio delle imprese e dei propri dipendenti, ma che la contrattazione è lo strumento per lo sviluppo delle imprese e del lavoro.
Siamo stati sommersi da una rappresentazione mediatica distorta, dove a far notizia non è stata la firma dell’intesa e il suo contenuto, ma lo strappo di chi da quella firma si è dissociato.
Siamo andati avanti lo stesso. E continueremo ad andare avanti, convinti che questa è la strada di una rappresentanza moderna degli interessi di parte che svolge il suo ruolo, quale che siano le forze politiche che governano il paese. Così si vive in modo maturo la cultura dell’alternanza.
Oggi che si è diradato il polverone della demagogia. Oggi che sono state compiute scelte personali che hanno reso chiaro a tutti, anche a coloro che si ostinavano a non voler vedere, che chi non accettava il confronto lo faceva per puro calcolo politico e non certo per ragioni di merito sindacale. Bene, oggi si possono rileggere quelle pagine di storia sindacale con le lenti della verità: noi tutti, ben 36 sigle di rappresentanza del mondo del lavoro e del mondo delle imprese abbiamo continuato il confronto sindacale, aspro, duro, ma alla fine costruttivo.
E lo abbiamo fatto nonostante le strumentalizzazioni, nonostante lo scontro politico in atto, nonostante qualcuno abbia voluto mettere la più grande organizzazione sindacale al servizio di un disegno politico antagonista non solo del Governo, ma delle stesse forze di opposizione. Nonostante la straordinaria campagna di disinformazione orchestrata.
Non siamo certo noi ad aver pagato i prezzi più alti di quella degenerazione. Non parlo solo della vita di Marco Biagi, di quella tremenda ferita che è ancora nel cuore di tutti noi, della quale non sappiamo darci una ragione.
Parlo anche di quelle continue, vergognose manifestazioni di intolleranza antidemocratica, e in alcuni casi di natura terroristica, che subiscono con troppa frequenza la Cisl e personalmente Savino Pezzotta.
Negli ultimi 30 mesi abbiamo fatto 56 contratti di lavoro, che interessano quasi 4 milioni di lavoratori, cioè quasi il 90 per cento dei dipendenti delle imprese associate. Abbiamo introdotto importanti innovazioni. Tutti questi contratti rispettano la stessa logica, lo stesso riferimento: l’accordo interconfederale sulla politica dei redditi del luglio del 1993. Di tutti, solo uno non è stato firmato dalla Cgil: quello dei metalmeccanici.
Anche con i meccanici abbiamo fatto un buon contratto nazionale di categoria, nel rispetto della politica dei redditi.
Quello che abbiamo fatto è “il contratto”. Non un contratto separato.
Qualcuno si è voluto separare dal contratto dei meccanici, mettendosi così al di fuori dall’accordo del 23 luglio.
Speriamo che ci ripensi, che abbandoni quel terreno di scontro politico per tornare a fare sindacato.
L’articolo 18
Oggi stiamo per venire a capo di una vicenda che ha segnato la vita politica e sindacale del nostro paese negli ultimi anni.
Tre anni fa abbiamo proposto di aprire un confronto sull’istituto del reintegro nel posto di lavoro per il lavoratore licenziato.
Abbiamo detto che il reintegro forzato nel posto di lavoro è un istituto che lede la dignità del lavoratore e riduce la propensione dell’azienda ad assumere.
Negli altri paesi, dove non a caso il tasso di occupazione è più alto, l’articolo 18 non esiste. Esiste l’istituto del risarcimento economico.
Abbiamo dimostrato che un efficiente mercato del lavoro, dove la domanda è più alta e dove ci sono più opportunità per chi ha perso un lavoro, offre più garanzie di un giudice che obbliga l’azienda a riprendere il lavoratore. È vero che, su richiesta dello stesso lavoratore, spesso quest’obbligo si traduce in un risarcimento economico. Solo che da noi avviene dopo una lunghissima vicenda giudiziaria che lascia per molti mesi, a volte per anni, nell’incertezza il lavoratore e l’azienda. Il lavoratore non cerca un altro posto, l’azienda non assume in attesa della sentenza.
Abbiamo detto: proviamo a discutere. Il risarcimento esiste già altrove. Esiste anche in Italia nelle imprese fino a quindici dipendenti.
Ci hanno accusato di voler toccare un diritto fondamentale.
Ci hanno accusato di volere libertà di licenziamento.
Siamo stati sommersi da demagogia e falsità. Non abbiamo potuto parlarne per mesi, fino a che siamo riusciti ad affrontare il problema e a trovare un accordo con il sindacato. Un buon accordo. Abbiamo detto: proviamo per qualche anno.
Oggi che è stato proposto un referendum per estendere l’articolo 18 anche alle aziende con meno di 16 dipendenti, il dibattito si sta facendo finalmente più chiaro.
La stragrande maggioranza delle forze politiche e sindacali ha dichiarato che è contro il referendum. Ha detto che se vincessero i SI ci sarebbero più disoccupazione e più lavoro nero.
Siamo d’accordo, lo abbiamo sempre affermato anche noi.
Forse non si sentiva, sommersi dal fragore della demagogia.
Oggi ci si accorge che non è un diritto fondamentale, che bisogna salvaguardare le piccole imprese da questa norma che ne limiterebbe lo sviluppo.
Siamo d’accordo. Lo abbiamo sempre pensato anche noi.
Con altre 15 organizzazioni di rappresentanza delle imprese abbiamo costituito il Comitato per il NO. Ci batteremo attivamente perché il SI non prevalga, ci batteremo perché un dibattito così importante, che riguarda la civiltà giuridica del nostro paese, non venga svilito da un mero quesito a cui rispondere SI o NO. Un quesito proposto solo per un regolamento di conti tra due frange massimaliste della sinistra.
Ovviamente comprendiamo che possano esserci idee diverse dalle nostre, ovviamente sappiamo che la questione è delicata e tocca sensibilità politiche e sociali.
Non abbiamo mai voluto imporre le nostre idee a nessuno.
Credo però che dopo il 15 giugno, dopo che la maggior parte degli italiani avrà votato NO o avrà detto NO al referendum non andando a votare, sarà più facile parlarne. Più facile trovare delle soluzioni, dopo la fase di sperimentazione prevista dal Patto per l’Italia, per affrontare questo problema e aumentare la propensione ad assumere da parte delle imprese italiane. Per combattere la disoccupazione e il lavoro nero.
Conclusioni
Signor Presidente del Senato, Signor Presidente della Camera, Signor Presidente del Consiglio, signore e signori,
l’Italia sta vivendo da molti anni una situazione del tutto particolare che non ha eguali nei paesi ad economia avanzata.
Viviamo in un clima inquinato da uno scontro politico anomalo che non accenna a placarsi. È ormai una grande questione nazionale.
Credo sia giusto parlarne non certo per entrare in ambiti politici che non sono propri della rappresentanza delle imprese, ma perché gli imprenditori, come tutti i cittadini italiani, vivono con grave e crescente disagio questa situazione.
Il continuo discredito di tutta la classe politica nazionale incide in modo determinante sulla nostra immagine all’estero. Ne risente pesantemente la stessa competitività del nostro sistema economico.
In una fase così difficile dell’economia nazionale e mondiale è grave che tante energie del Governo e dell’opposizione siano concentrate su polemiche che riguardano solo il passato.
Per anni, il nostro handicap è stata l’instabilità politica, quei continui cambiamenti di governo che erano tanto criticati a livello internazionale.
Oggi abbiamo in teoria un sistema più stabile, ma la continua delegittimazione dell’avversario ci rende sempre meno credibili nel mondo.
Lo dico da cittadino. Lo dico da imprenditore che opera sui mercati internazionali. Lo dico da presidente dell’associazione che rappresenta le imprese italiane.
Basta.
Non si può continuare a mortificare così il nostro orgoglio di essere italiani. Non si può dilapidare così la credibilità del nostro paese.
Vogliamo vivere in un paese nel quale la dialettica politica si sviluppa nelle sedi proprie, quelle dell’agone politico, e non nelle aule giudiziarie.
Ma qual è il paese dove chi aspira ad essere, diventa o è stato Presidente del Consiglio viene quasi certamente coinvolto, o direttamente o dalla polemica politica, in accuse di malaffare?
È una lunga lista di nomi che non ha eguali in nessun altro paese al mondo. Questo è il sintomo più evidente di una patologia del nostro sistema politico che deve essere sanata.
L’uso politico della giustizia danneggia sia la classe politica che la magistratura e lede gravemente la fiducia degli italiani in queste fondamentali istituzioni della democrazia.
Negli anni ‘80 c’era un sistema d’illegalità diffuso, un intreccio perverso tra la politica e gli affari che doveva essere rimosso.
Sono stato uno dei primi a denunciarlo.
Avrei voluto che la politica avesse avuto la forza e la capacità di non far degenerare il sistema fino a quel punto.
Avrei voluto che il ricambio del gruppo dirigente del paese avvenisse senza traumi giudiziari.
E tuttavia ho avuto rispetto per quei magistrati che hanno affrontato con determinazione il problema.
Aver avuto allora quella posizione mi consente oggi di dire con franchezza quello che penso.
Credo che il lavoro della magistratura in quegli anni, ancorché traumatico, abbia diffuso una più vigile coscienza della legalità.
Oggi c’è una maggiore attenzione dei media, della magistratura, delle imprese e della politica stessa. Non mancano certo episodi specifici, ma sono presto denunciati ed affrontati.
Non si può più parlare di una magistratura disattenta e di una classe politica generalmente corrotta. Non ci sono più porti delle nebbie, né tra i magistrati né nei rapporti tra politica ed economia. Lo dico riferendomi sia al centrodestra che al centrosinistra.
Questo è avvenuto grazie a quella maggiore sensibilità creatasi nei drammatici anni ’90, grazie a un atteggiamento più severo da parte di tutti, ad iniziare dal legislatore.
Le nuove leggi sugli appalti, il nuovo sistema per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, i nuovi sistemi di controllo, la stessa lotta al sommerso: tutti questi strumenti hanno ridotto quei margini di manovra nei quali l’illegalità diffusa si muoveva.
Tutto ciò, però, rischia di non funzionare se si inceppa il sistema politico fondato sull’alternanza.
Questo è il principale strumento della lotta all’illegalità.
Il sistema maggioritario ha eliminato l’inamovibilità dei partiti al governo e ha consentito di creare un’alternanza tra due poli nella gestione della cosa pubblica.
Il sistema si dota così di ineluttabili e automatici meccanismi di controllo. Ha funzionato bene nei Comuni, nelle Province. Comincia a funzionare nelle Regioni.
Per un assessore o un sindaco è un importante deterrente sapere che domani al suo posto potrà sedere non un compagno di partito ma un esponente dell’opposizione. Un avversario che potrà controllare dall’interno il suo operato.
Quando chi governa ha la sensazione di non correre il rischio di essere sostituito, allora è più probabile che una cortina di opacità avvolga la gestione della cosa pubblica. Quando invece c’è la concreta possibilità dell’alternanza, le zone d’ombra si disperdono.
È la competizione che dà trasparenza alla gestione del rapporto tra economia e politica. Governabilità, alternanza, legalità sono le tre condizioni che garantiscono un corretto funzionamento sia della democrazia sia del mercato.
Oggi l’asprezza dello scontro, l’uso politico delle vicende giudiziarie di questo o quel leader, depotenzia di fatto il sistema dell’alternanza, ne devìa il corso naturale.
A chi giova questo continuo massacro? Alla politica no di certo, alla credibilità dell’azione giudiziaria nemmeno, al buon nome del paese tanto meno.
Noi vorremmo che la competizione tra le forze politiche si svolgesse sulla loro capacità di governo, sulla loro visione del paese, non sulla loro capacità di accumulare dossier sul passato di questo o quel Presidente del Consiglio.
Si è detto che quella che è nata dopo tangentopoli fosse la seconda Repubblica. Non so come la vogliamo chiamare. Certo è che, se la seconda Repubblica è ancora impigliata negli scandali della prima, tanto vale cominciare fin d’ora a costruire la terza Repubblica.
Dobbiamo chiudere una fase storica nella quale si guarda sempre al passato e mai al futuro.
I politici italiani parlano più di vicende accadute negli anni ‘80 che dei problemi dai quali dipende il nostro futuro.
Chiudiamola finalmente col passato, non si costruisce così il futuro.
Io chiedo alle forze politiche di ascoltare il messaggio del Presidente della Repubblica: difendiamo la legalità del nostro paese guardando avanti.
Abbiate la forza di darci un paese civile, con una sana e trasparente competizione politica.
Abbiate la forza di chiudere subito con il vostro passato, e giocate la partita vera della politica, quella alta, quella che l’Italia si merita.
Abbiate la forza politica e la lungimiranza di promuovere una autentica pacificazione nazionale.
Fatevi meritare dagli italiani, dai cittadini che si sentono italiani, prima ancora di essere di questo o di quel partito.
Abbiate la stessa forza e lungimiranza che ebbero i nostri Padri costituenti.
La giustizia è un bene di tutti, non di una casta. È una questione fondamentale di democrazia: lo è per i cittadini, lo è per le imprese. Troppa incertezza del diritto, troppa lentezza nei processi, troppa confusione di ruoli all’interno della magistratura. Tutto ciò rende impellente una riforma organica dell’ordinamento giudiziario.
L’Italia ha bisogno che finisca questo scontro di potere tra corporazioni. Ogni paese ha adottato degli strumenti per regolare il difficile rapporto tra il potere giudiziario e quello legislativo ed esecutivo. Dobbiamo anche noi regolare questo rapporto. Oggi è squilibrato, non funziona.
È un problema vero. Adottate un modello aperto, tra sistemi che dialogano, non tra sistemi che si fanno la guerra. Trovate una soluzione chiara, trasparente, non frutto di sotterfugi procedurali.
Chiudere con il passato, riformare la giustizia, dare a chi governa e a chi è all’opposizione piena autonomia e autorevolezza: questa è la risposta che gli italiani si aspettano.
L’Italia sta per assumere la presidenza dell’Unione europea. Deve arrivare a quell’appuntamento avendo realizzato la pacificazione nazionale.
Lo vogliamo per il bene delle imprese ma soprattutto perché lì si giocherà il nostro futuro. L’Italia pacificata sarà più forte e più autorevole.
È interesse di chi governa oggi e di chi aspira a governare domani.
È soprattutto interesse del paese.
I nostri padri, dopo le devastazioni della guerra, seppero costruire un’Italia democratica e prospera come mai prima. Oggi molti italiani temono che il futuro dei propri figli sarà peggiore del presente.
È nostra responsabilità dare a loro, a noi stessi, ai nostri figli, un’Italia in cui avere fiducia.