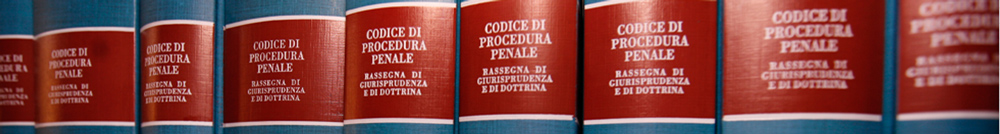Civile
Il testo dell’ ordinanza del Tribunale di Roma sul caso Welby.
Il testo dell’ordinanza del
Tribunale di Roma sul caso Welby.
Tribunale di Roma
Sezione Prima Civile
Ordinanza 15
– 16 dicembre 2006
(Giudice
Istruttore: Salvio)
Premesso in fatto
Con ricorso ex art. 700 C.P.C. proposto ante
causam dal sig. Piergiorgio Welby nei confronti della ANTEA Associazione Onlus
ed il Dott. Giuseppe Casale è stato chiesto: "accertato
e dichiarato il diritto del ricorrente ad autodeterminarsi nella scelta delle
terapie mediche invasive alle quali sottoporsi e, quindi, il diritto del
medesimo ricorrente di manifestare il proprio consenso a taluni trattamenti ed
il rifiuto ad altri; presto atto ed accertato, altresì che il Signor
Piergiorgio Welby ha espresso, e ribadisce con il presente atto, la propria
libera, informata, consapevole ed incondizionata volontà a che sia
immediatamente cessata l’attività sulla propria persona di sostentamento a
mezzo di ventilatore artificiale mentre sia proseguita e praticata la terapia
di sedazione terminale; sia ordinato al Dott. Giuseppe Casale ed alla Antea
Associazione Onlus, soggetti che hanno in cura il ricorrente, di procedere
all’immediato distacco del ventilatore artificiale che assicura la respirazione
assistita del Signor Welby, contestualmente somministrando al paziente terapie
sedative che, in conformità con le migliori ed evolute pratiche e conoscenze
medico-scientifiche, risultino idonee a prevenire e/o eliminare qualsiasi stato
di sofferenza fisica e/o psichica del paziente stesso con modalità tali da
rispettare momento per momento, sia all’atto del distacco dal respiratore che
successivamente, il massimo rispetto delle condizioni di dignità e di
sopportabilità del suo stato da parte del paziente; disporre, in ogni caso,
tutte le misure ritenute più adeguate a dare concreta attuazione agli interessi
e ai diritti esercitati dal ricorrente".
Il ricorrente ha esposto: di
essere affetto da anni da un gravissimo stato morboso degenerativo,
clinicamente diagnosticato quale "distrofia fascioscapoloomerale; che il
progredire della malattia, seguendo un decorso non inatteso, ha comportato che,
allo stato odierno, al ricorrente è inibito qualsiasi movimento di tutto il
corpo, ad eccezione di quelli oculari e labiali, e la sua sopravvivenza è
assicurata esclusivamente per mezzo di un respiratore automatico al quale è
collegato dal 1997; che la tipologia del morbo è tale che, sulla base delle
attuali conoscenze medico-scientifiche, i trattamenti sanitari praticabili non
sono in condizione di arrestarne in nessun modo l’evoluzione e, quindi, hanno
quale unico scopo quello di differire nel tempo l’ineludibile e certo esito
infausto, semplicemente prolungando le funzioni essenziali alla sopravvivenza
biologica ed il gravissimo stato patologico in cui versa il ricorrente; che,
nonostante sia, nel fisico, completamente immobilizzato, il deducente conserva intatte le proprie facoltà mentali ed è, dunque, in
grado di esprimere una volontà pienamente informata e consapevole circa
l’accettazione o il rifiuto dei detti trattamenti, che, in considerazione del
suo grave e sofferto stato di malattia in fase irreversibilmente terminale,
dopo essere stato debitamente informato dei trattamenti praticabili e delle
relative conseguenze, ha consapevolmente ed espressamente richiesto alla
struttura ospedaliera ed al medico dai quali è professionalmente assistito, di
non essere ulteriormente sottoposto alle terapie di sostentamento in atto e di
voler ricevere assistenza nei limiti in cui sia necessario a lenire le
sofferenze fisiche; che il ricorrente, in particolare, ha dichiarato, in data
24 novembre 2006, con volontà chiaramente ed univocamente espressa, che non
consente a proseguire l’utilizzo, sulla propria persona, del ventilatore
polmonare, chiedendo espressamente che si proceda al distacco di tale
apparecchio, peraltro "sotto sedazione terminale", e, dunque, con
espressa indicazione circa la contestualità tra il distacco medesimo ed il
trattamento sedativo teso a scongiurare ulteriori patimenti; che la struttura
ospedaliera ed il medico curante, in data 25 novembre 2006, hanno, per
iscritto, opposto un rifiuto alla richiesta del Signor Welby, assumendo di non
poter dare seguito alla volontà espressa dal paziente, in considerazione degli
obblighi ai quali si ritengono astretti; che, in particolare, il medico
curante, pur non negando di essere "obbligato per legge a rispettare la
volontà" del sig. Welby, e dunque ad essere obbligato al distacco del
ventilatore polmonare sotto sedazione, rilevato che ciò comporta "pericolo
di vita", ha opposto che quando il paziente fosse sedato, e dunque
"non più in grado di decidere" scatterebbe immediatamente in
relazione al rischio di vita, l’obbligo di "procedere immediatamente"
a riattaccare il ventilatore polmonare medesimo al fine di "ristabilire la
respirazione"; che il rifiuto opposto alla richiesta del ricorrente è
ingiustificato in base alle seguenti argomentazioni: 1) è principio pacifico
che il consenso informato costituisce la base di ogni trattamento terapeutico;
2) che esso riceve protezione direttamente da norme di rango costituzionale
(artt. 2, 13 e 32 Cost.) e ne consegue che ogni persona può vantare un vero e
proprio diritto perfetto a liberamente e consapevolmente determinarsi in ordine
al compimento o al rifiuto del compimento di qualsiasi attività invasiva di
trattamento o terapia di natura medica e che tale diritto comprende quello di
interrompere le terapie alla cui somministrazione sia stato in precedenza,
manifestato il proprio assenso – cosa che, tra l’altro non è dato riscontrare
nella specie in quanto l’applicazione, all’epoca, del respiratore automatico
non venne preceduta da assenso del ricorrente,
trovandosi in quel momento nella impossibilità di esprimerlo; 3) che il
rapporto tra la libertà di disporre consapevolmente in ordine ai trattamenti
terapeutici e la tutela del bene vita deve essere riconsiderato alla luce della
evoluzione scientifica che incide sugli eventi naturali, quali il concepimento
e la morte, qualificati, per i riflessi che hanno su di essi i progressi
scientifici, quali "processi gestibili" e che, in conseguenza, di ciò
si chiede, non tanto di opporsi agli eventi naturali, bensì di poter
interloquire con quei soggetti (medici) che gestiscono la fase terminale della
vita; 4) in forza del diritto ad autodeterminarsi nella scelta sulle
caratteristiche, sui termini e sui limiti dei trattamenti cui il paziente
intende sottostare, il principio del consenso informato alla interruzione della
terapia comporta che il rifiuto cosciente e volontario dei trattamenti sanitari
non desiderati viene espresso anche per la situazione successiva alla
sedazione, in quanto ben rappresentata ed attuale nella coscienza e volontà del
soggetto allorquando consente alla interruzione, ed i successivi eventi non
costituiscono situazioni nuove o imprevedibili rispetto al momento in cui il
consenso cosciente e volontario è stato manifestato: che sussiste la necessità
di protezione urgente dei diritti del ricorrente, risultando particolarmente
intollerabile, a livello psicologico, dover sottostare a terapie sanitarie che
egli, a ragione, considera quale indebita ed illecita intrusione nella propria
sfera personale e che ritiene, stante la loro sostanziale inutilità per il
miglioramento della propria salute, profondamente lesive della propria dignità
in quanto non utili neppure a perseguire benefici in termini di qualità della
vita, e che il pregiudizio può essere rimosso solo rimuovendo senza indugio le
cause che lo determinano.
Instauratosi il contraddittorio,
si sono costituiti la Antea Associazione Onlus ed il Dott.
Giuseppe Casale, medico e coordinatore della Associazione stessa, ed hanno
richiesto, in via preliminare, rigettare la domanda per difetto di
legittimazione passiva; nel merito, respingere il ricorso.
Il Pubblico ministero è
intervenuto in giudizio, ai sensi dell’art. 70 Cpc ed ha concluso che, sotto il
profilo dell’esistenza del diritto ad ottemperare il trattamento terapeutico
non voluto, con le modalità richieste, il ricorso è
ammissibile e va accolto; per ciò che riguarda la possibilità di ordinare ai
medici di non ripristinare la terapia, il ricorso è inammissibile, perché
trattasi di scelta discrezionale del medico.
Ritenuto in diritto
In primo luogo deve essere
affermata la non ritualità del deposito di note di chiarimento in data
14/12/2006 da parte degli avvocati di parte ricorrente, quando già il fascicolo
era stato preso in riserva del Giudice, ed al di fuori
della regolare esplicazione del contraddittorio all’interno del processo.
Pertanto dello scritto non
autorizzato non può tenersi conto; peraltro, va anche osservato, la non
influenza, ai fini del decidere, delle argomentazioni illustrative aggiuntive
ivi prospettate, in quanto il thema decidendum era già stato integralmente
puntualizzato, in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, negli scritti
precedenti e nell’udienza di trattazione del ricorso.
Va, preliminarmente, respinta
l’eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dai resistenti, in
quanto di fatto superata, sia sulla base della documentazione allegata al
ricorso (v. cartella clinica del sig. Welby, dalla quale risulta la presa in
carico del paziente da parte dell’Associazione Antea Onlus, sottoscritta dal
Dott. Casale), sia dalle stesse dichiarazioni rese in udienza dal Dott.
Giuseppe Casale (v. verbale del 12/12/2006).
Il principio
dell’autodeterminazione e del consenso informato è una grande conquista civile
delle società culturalmente evolute; esso permette alla persona, in un’epoca in
cui le continue conquiste e novità scientifiche nel campo della medicina
consentono di prolungare artificialmente la vita, lasciando completamente nelle
mani dei medici la decisione di come e quando effettuare artificialmente tale
prolungamento, con sempre nuove tecnologie, di decidere autonomamente e
consapevolmente se effettuare o meno un determinato
trattamento sanitario e di riappropriarsi della decisione sul se ed a quali
cure sottoporsi.
Nel corso degli anni è
profondamente mutato il modo di intendere il rapporto medico-paziente, e il
segno di questa trasformazione è proprio nella rilevanza assunta dal consenso
informato, che ha spostato il potere di decisione del medico al paziente, in cui
quest’ultimo è diventato protagonista del processo terapeutico.
Il quadro di riferimento dei
principi generali si rinviene innanzitutto negli artt. 2, 13 e 32 Cost., ed abbraccia la tutela e promozione dei diritti
fondamentali della persona della sua dignità ed identità, della libertà
personale e della salute.
La giurisprudenza della Corte di
Cassazione e della Corte Costituzionale ha fatto emergere l’ampiezza di tale
principio, nel senso che qualsiasi atto invasivo della sfera fisica, sia di
natura terapeutica che non terapeutica, non può avvenire senza o contro il
consenso della persona interessata, in quanto l’inviolabilità fisica
costituisce il nucleo essenziale della stessa libertà personale; mentre,
l’imposizione di un determinato trattamento sanitario può essere giustificato
solo se previsto da una legge che lo prescrive in funzione di tutela di un
interesse generale e non a tutela della salute individuale e se è comunque
garantito il rispetto della dignità della persona (art. 32 Cost.)
Il principio trova riconoscimento
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nella Convenzione
europea sui diritti dell’uomo e la biomedicina di Oviedo del 1997, ratificata
con Legge 28 marzo 2001 n.145 nel Codice di deontologia medica, in molte leggi
speciali, a partire dal quella istitutiva del Servizio
sanitario nazionale.
Il codice di deontologia medica
prescrive al medico di desistere dalla terapia quando
il paziente consapevolmente la rifiuti (art. 32) e, inoltre, nel caso in cui il
paziente non è in grado di esprimersi, la regola deontologica prescrive al
medico di proseguire la terapia fino a quando la ritenga "ragionevolmente
utile" (art. 37).
Pertanto, il principio
dell’autodeterminazione individuale e consapevole in ordine ai trattamenti sanitari
può considerarsi ormai positivamente acquisito ed è collegato al dovere del
medico di informare il paziente sulla natura, sulla portata e sugli effetti
dell’intervento medico, che è condizione indispensabile per la validità del
consenso, ed è il presupposto dialettico del rapporto medico-paziente nonché
fondamento di obblighi e responsabilità di quest’ultimo; esso, tuttavia,
presenta aspetti problematici in termini di concretezza ed effettività rispetto
al profilo della libera e autonoma determinazione individuale sul rifiuto o la interruzione delle terapie salvavita nella fase terminale
della vita umana.
Ritiene il giudicante, alla
stregua dei principi sopra richiamati, e considerati i seguenti elementi: 1) le
applicazioni pratiche che dei detti principi ha effettuato la giurisprudenza –
che ad esempio, per quel che più può interessare il caso oggetto di esame, ha
ritenuto di sussistere in capo alla persona un vero e proprio diritto
soggettivo perfetto a rifiutare liberamente e consapevolmente la terapia, anche
nel caso in cui quest’ultima consentirebbe di salvare la vita al paziente (ad
esempio rifiuto della trasfusione per motivi religiosi), ravvisando il reato di
violenza privata nel comportamento del medico che imponesse la terapia contro
la volontà del paziente (ad es. Cass. Sez. I, 11
luglio 2002, n. 26646) o che ha ritenuto scriminante dal consenso informato del
paziente prestato prima dell’anestesia tutte le attività mediche, i trattamenti
e i rischi prevedibili al momento della prestazione del consenso, che siano
stati preventivamente illustrati al paziente e volontariamente accettati prima
della perdita di coscienza (v. fra le altre Cass. Sez. III n.
14638/2004) -; 2) le indicazioni contenute nel codice di deontologia medica,
che all’art. 34 prescrive: "… se il paziente non è in grado di esprimere
la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto
di quanto precedentemente manifestato dallo stesso"; 3) la disposizione di
cui all’art. 9 della Convenzione di Oviedo (ratificata, anche se mancante
dell’attuazione della delega di cui all’art. 3 della Legge 28 marzo 2001 n.145
), che dispone che in caso di perdita irreversibile della coscienza bisogna
tener conto delle direttive precedentemente espresse dal paziente; 4) l’intervento
del Comitato nazionale di bioetica (18 dicembre 2003) che si è occupato delle
"dichiarazioni anticipate di trattamento", affermando che esse si
iscrivono in un positivo processo di adeguamento dell’atto medico al principio
di autonomia decisionale del paziente, che non possa negarsi la rilevanza
centrale assunta dal consenso informato del paziente e la positivizzazione del
principio dell’autodeterminazione della persona in ordine ai trattamenti
sanitari nella sua massima espansione, fino a comprendere il diritto di
scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico e di terapia, di
eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di
interrompere la terapia, in tutte le fasi della vita, anche in quella
terminale, in cui deve ritenersi riconosciuta all’individuo la libertà di
scelta del come e del quando concludere il ciclo vitale, quando ormai lo
spegnimento della vita è ineluttabile, la malattia incurabile e per mettere
fine alle proprie sofferenze.
Il tema della rilevanza della
volontà individuale nel caso dei malati terminali da tempo anima il dibattito
scientifico, filosofico, religioso e giuridico – anche sulla spinta del
confronto con le esperienze di altri Paesi europei e non, in cui in qualche
misura si è colto l’impegno negli ultimi anni per la predisposizione di una
regolamentazione della materia: v. in particolare Olanda, Belgio, Stati Uniti,
Canada, Australia, Inghilterra – e appare segnato da questioni eticamente
laceranti, che tuttavia non possono essere ignorate perché già penetrate
profondamente nella coscienza civile e nella pratica della medicina, specie
laddove la terapia di mantenimento in vita viene
continuata contro la volontà del paziente, quando si trovi in condizioni
talmente gravi da far ritenere di voler negare al malato una morte dignitosa,
prolungando una sofferenza ormai insostenibile.
Il nodo centrale è che, siccome
l’ordinamento giuridico va considerato nell’intero complesso, appare non
discutibile che esso non preveda nessuna disciplina specifica sull’orientamento
del rapporto medico-paziente e sulla condotta del medico ai fini
dell’attuazione pratica del principio dell’autodeterminazione per la fase
finale della vita umana, allorché la richiesta riguardi il rifiuto o
l’interruzione di trattamenti medici di mantenimento in vita del paziente;
anzi, il principio di fondo ispiratore è quello della indisponibilità del bene
vita: v. art. 5 del codice civile, che vieta gli atti di disposizione del
proprio corpo tali da determinare un danno permanente e, soprattutto gli artt.
575, 576, 577, I comma n. 3, 579 e 580 del codice
penale che puniscono, in particolare, l’omicidio del consenziente e l’aiuto al
suicidio.
Rispetto al bene vita esiste,
altresì, un preciso obbligo giuridico di garanzia del medico di curare e
mantenere in vita il paziente: "anche su
richiesta del malato non deve effettuare né favorire trattamenti diretti a
provocare la morte" (art. 35 del codice deontologico) e "in caso di
malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il
medico deve limitare la sua opera all’assistenza morale e alla terapia atta a
risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati a
tutela, per quanto possibile, della qualità della vita. In caso di
compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella
terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile. Il sostegno
vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia
accertata la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo" (art.
37 del codice deontologico).
E allora lo sforzo di attuazione
del principio della libertà individuale e di elaborazione del contenuto del
consenso per le scelte di trattamento medico di fine vita nei malati terminali,
tema molto presente nella sensibilità culturale, scientifica, etica e religiosa
generale, richiede necessariamente il superamento della impostazione formale
della generale doverosità giuridica del mantenimento in vita del paziente e il
leale ripensamento delle categorie distintive fra comportamenti passivi e
comportamenti attivi del medico, in particolare valorizzando l’essenza e il
rispetto della dignità umana, la qualità della vita, e facendo ricorso ai
concetti di futilità o inutilità del trattamento medico, di incurabilità della
malattia, di insostenibilità della sofferenza e di condizioni degradanti per
l’essere umano.
Il Comitato nazionale per la
bioetica è intervenuto muovendo dalla premessa che la morte non può essere
considerata come un mero evento biologico o medico, essendo essa portatrice di
un significato nel quale deve essere individuata la radice della dignità
dell’essere umano. La morte assegna all’essere umano un compito morale, che è
quello di trovare un senso che guidi e assicuri la sua libertà.
Alla luce di questa visione, il
Cnb considera criticamente ogni ipotesi di accanimento terapeutico, che volendo
prolungare indebitamente il processo irreversibile del morire si pone contro la
consapevolezza del soggetto alla propria invincibile caducità. L’accanimento
terapeutico viene definito come un trattamento di
documentata inefficacia in relazione all’obiettivo, a cui si aggiunge la
presenza di un rischio elevato per il paziente di ulteriori sofferenze, in un
contesto del quale l’eccezionalità dei mezzi adoperata risulta chiaramente
sproporzionata rispetto agli obiettivi.
L’art. 14 del codice deontologico
medico vieta l’accanimento diagnostico terapeutico: "Il medico deve
astenersi dall’ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente
attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della
qualità della vita".
Alcuni spunti di elaborazione,
del tutto condivisi da questo Giudicante, possono trarsi dal decreto della
Corte d’Appello di Milano del 26/11/1999 (anche se
riguarda un caso differente di paziente in stato vegetativo persistente, per il
quale era stata richiesta l’interruzione delle cure mediche che consentivano il
protrarsi dello stato vegetativo, nonché l’alimentazione artificiale) :
"Il dovere giuridico, etico, deontologico del medico si arresta di fronte
all’incurabilità della malattia, giacché ogni protrazione della terapia,
trasformando il paziente da soggetto ad oggetto, viola la sua dignità.
Nell’eccezione più accreditata invero l’accanimento terapeutico, si presenta
come una cura inutile, futile, sproporzionata, non appropriata rispetto ai
prevedibili risultati, che può, pertanto, essere interrotta, perché
incompatibile con i principi costituzionali, etici e morali di rispetto, di
dignità della persona umana, di solidarietà".
Può, pertanto, affermarsi che il
divieto di accanimento terapeutico è un principio solidamente basato sui
principi costituzionali di tutela della dignità della persona, previsto nel
codice deontologico medico, dal Comitato nazionale per la Bioetica, dai trattati internazionali,
in particolare dalla Convenzione Europea, nonché condiviso anche in prospettiva
morale religiosa.
Esso, tuttavia, sul piano
dell’attuazione pratica del corrispondente diritto del paziente ad esigere ed a
pretendere che sia cessata una determinata attività medica di mantenimento in
vita (il problema si è posto, in particolare, per l’alimentazione e
l’idratazione forzate e, come nel caso di specie, per la respirazione assistita
a mezzo di ventilatore artificiale), in quanto
reputata di mero accanimento terapeutico, lascia il posto alla interpretazione
soggettiva ed alla discrezionalità nella definizione di concetti si di
altissimo contenuto morale e di civiltà e di intensa forza evocativa (primo fra
tutti la dignità della persona), ma che sono indeterminati e appartengono ad un
campo non ancora regolato dal diritto e non suscettibile di essere riempito
dall’intervento del Giudice, nemmeno utilizzando i criteri interpretativi che
consentono il ricorso all’analogia o ai principi generali dell’ordinamento.
Ciò perché i principi sono
incerti ed evanescenti, manca una definizione condivisa ed accettata dei
concetti di futilità del trattamento, di quando l’insistere con trattamenti di
sostegno vitale sia ingiustificato o sproporzionato, sugli stessi concetti di
insostenibilità della qualità della vita o di degradazione della persona da
soggetto ad oggetto e perché non esistono linee-guida di natura tecnica ed
empirica di orientamento dei comportamenti dei medici che, in definitiva,
riempiano di contenuti il divieto di accanimento terapeutico ed il correlativo
diritto a far cessare l’accanimento stesso con la richiesta di interruzione
della terapia di sostentamento vitale (va ricordato, altresì, che non sono
ancora stati emanati i decreti per l’attuazione della Legge 28 marzo 2001 n.145
).
Siccome un diritto può dirsi
effettivo e tutelato solo se l’ordinamento positivamente per esso
prevedeva la possibilità di realizzabilità coattiva della pretesa, in caso di
mancato spontaneo adempito alla richiesta del titolare che intenda esercitarlo,
va osservato che, nel caso in esame, il diritto del ricorrente di richiedere la
interruzione della respirazione assistita e distacco del respiratore
artificiale, previa somministrazione della sedazione terminale, deve ritenersi
sussistente alla stregua delle osservazioni di cui sopra, ma trattasi di un
diritto non concretamente tutelato dall’ordinamento; infatti, non può parlarsi
di tutela se poi quanto richiesto al ricorrente deve essere sempre rimesso alla
totale discrezionalità di qualsiasi medico al quale la richiesta venga fatta,
alla sua coscienza individuale, alle sue interpretazioni soggettive dei fatti e
delle situazioni, alle proprie concezioni etiche, religiose e professionali
(come dimostra anche il diniego alla richiesta del sig. Welby da parte del
Dott. Giuseppe Casale che, come egli ha chiarito in udienza, è anche collegato
alle sue personali convinzioni etiche e professionali, essendo un sostenitore
della cura dei malati terminali con cure palliative e che ha affermato che nel
caso di Welby: "non c’è accanimento terapeutico perché il respiratore non
è futile. Se io stacco il respiratore il paziente muore": v. dichiarazioni
a verbale effettuate all’udienza del 12/12/2006).
In altri termini, in assenza
della previsione normativa degli elementi concreti, di natura fattuale e
scientifica, di una delimitazione giuridica di ciò che va considerato
accanimento terapeutico, va esclusa la sussistenza di una forma di tutela
tipica dell’azione da far valere nel giudizio di merito, e di conseguenza, ciò
comporta la inammissibilità dell’azione cautelare,
attesa la sua finalità strumentale e anticipatoria degli effetti del futuro
giudizio di merito.
Solo la determinazione politica e
legislativa, facendosi carico di interpretare la accresciuta
sensibilità sociale e culturale verso le problematiche relative alla cura dei
malati terminali, di dare risposte alla solitudine ed alla disperazione dei
malati di fronte alle richieste disattese, ai disagi degli operatori sanitari
ed alle istanze di fare chiarezza nel definire concetti e comportamenti, può
colmare il vuoto di disciplina, anche sulla base di solidi e condivisi
presupposti scientifici che consentano di prevenire abusi e discriminazioni
(allo stesso modo in cui intervenne il legislatore per definire la morte
cerebrale nel 1993).
Considerate la delicatezza e la
novità della questione appare equo disporre la integrale
compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Visto l’art. 669 septies C.P.C.;
Il Giudice, pronunciando sul
ricorso ex. artt. 669 ter e 700
C.P.C. proposto dal Sig. Piergiorgio Welby nei confronti
della Antea Associazione Onlus e del Dott. Giuseppe Casale, ogni altra istanza
disattesa, così provvede: dichiara la inammissibilità
del ricorso e compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Depositata in Cancelleria il 16
dicembre 2006.