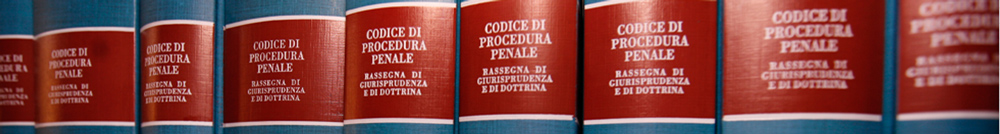Penale
La motivazione della sentenza della Cassazione che assolve definitivamente Andreotti.
La motivazione della sentenza
della Cassazione che assolve definitivamente Andreotti.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
1) Dott. Giuseppe M. Cosentino
Presidente
2) Dott. Antonio Morgigni
Consigliere
3) Dott. Francesco De Chiara
Consigliere
4) Dott. Maurizio Massera
Consigliere Rel. Est.
5) Dott. Carla Podo Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti dalla
Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo e da Andreotti Giulio,
nato a Roma il 14.1.1919, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo
in data 2.5.2003.
Visti gli atti, la sentenza
impugnata e i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la
relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Massera.
Udito il Procuratore Generale in
persona del dottor Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto
di entrambi i ricorsi.
Udito il difensore della parte
civile Comune di Palermo, avv. Salvatore Modica, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso del P.G. e il rigetto del ricorso dell’imputato, con condanna del
medesimo al risarcimento dei danni e alle spese; in subordine per
l’applicazione della prescrizione con rinvio del processo al giudice civile.
Uditi i difensori dell’imputato,
avv. Giulia Bongiorno, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G. e
l’accoglimento del ricorso dell’imputato e avv. Franco Carlo Coppi, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il
fatto non sussiste o non è preveduto dalla legge come reato, con rigetto del
ricorso del P.G..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- L’ipotesi accusatoria
Con decreto emesso il 2 marzo
1995, il Giudice per le Indagini Preliminari, su conforme richiesta del P.M.,
disponeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo nei confronti di Giulio
Andreotti perché rispondesse delle seguenti imputazioni:
a)del reato di cui all’art. 416
c.p., per avere messo a disposizione dell’associazione per delinquere
denominata Cosa Nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento
degli scopi criminali della stessa, l’influenza e il potere derivanti dalla sua
posizione di esponente di vertice di una corrente politica, nonché dalle
relazioni intessute nel corso della sua attività;
partecipando in questo modo al
mantenimento, al rafforzamento e all’espansione dell’associazione medesima;
E cosi ad esempio:
– partecipando personalmente ad
incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali
venivano discusse condotte funzionali agli interessi dell’organizzazione (in
particolare, gli incontri svoltisi in Palermo e in altre località della Sicilia
nel 1979 e nel 1980);
– intrattenendo inoltre rapporti
continuativi con l’associazione per delinquere tramite altri soggetti, alcuni
dei quali aventi posizioni di rilevante influenza politica in Sicilia (in
particolare l’on.le Salvo Lima e i cugini Antonino Salvo e Ignazio Salvo);
– rafforzando la potenzialità
criminale dell’organizzazione, in quanto, tra l’altro, determinava nei capi di
Cosa Nostra e in altri suoi aderenti la consapevolezza della disponibilità di
esso Andreotti a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati)
condotte volte ad influenzare, a vantaggio dell’associazione per delinquere,
individui operanti in istituzioni giudiziarie e in altri settori dello Stato;
Con le aggravanti di cui all’art.
416 commi 4 e 5 c.p., essendo Cosa Nostra un’associazione armata, composta da
più di dieci persone;
Reato commesso in Palermo (luogo
di costituzione e centro operativo dell’associazione per delinquere denominata
Cosa Nostra) e in altre località, da epoca imprecisata fino al 28 settembre
1982;
b) del reato di cui all’art. 416
bis c.p., per avere messo a disposizione dell’associazione mafiosa denominata
Cosa Nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi
criminali della stessa, l’influenza e il potere derivanti dalla sua posizione
di esponente di vertice di una corrente politica, nonché dalle relazioni
intessute nel corso della sua attività; partecipando in questo modo al
mantenimento, al rafforzamento e all’espansione dell’associazione medesima.
E cosi ad esempio:
– partecipando personalmente ad
incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali
venivano discusse condotte funzionali agli interessi dell’organizzazione (in
particolare, l’incontro svoltosi a Palermo con il latitante Salvatore Riina e
con Salvo Lima e Ignazio Salvo);
– intrattenendo inoltre rapporti
continuativi con l’associazione mafiosa tramite altri soggetti, alcuni dei
quali aventi posizioni di rilevante influenza politica in Sicilia (in
particolare l’on.le Salvo Lima e i cugini Antonino Salvo e Ignazio Salvo);
– rafforzando la potenzialità
criminale dell’organizzazione, in quanto, tra l’altro, determinava nei capi di
Cosa Nostra e in altri suoi aderenti la consapevolezza della disponibilità di
esso Andreotti a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati)
condotte volte ad influenzare, a vantaggio dell’associazione mafiosa, individui
operanti in istituzioni giudiziarie e in altri settori dello Stato;
– rafforzando ancora, e in
particolare, la capacità di intimidazione dell’organizzazione, fino al punto da
ingenerare uno stato di condizionamento persino in vari collaboratori di
giustizia; i quali difatti – pur dopo essersi dissociati da Cosa Nostra e
averne rivelato la struttura e le attività delittuose, ivi comprese quelle
riferibili ai componenti della "Commissione" – si astenevano tuttavia
a lungo dal riferire fatti e circostanze (relativi anche a gravi omicidi, quali
ad esempio quelli di Pecorelli, Mattarella, Dalla Chiesa) concernenti rapporti
fra Cosa Nostra ed esponenti politici, tra i quali appunto esso Andreotti, per
il timore – peraltro esplicitamente manifestato – di poter subire pericolose
conseguenze;
Con le aggravanti di cui all’art.
416 bis commi 4, 5 e 6 c.p., essendo Cosa Nostra un’associazione armata, volta
a commettere delitti, nonché ad assumere e mantenere il controllo di attività
economiche, mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa;
Reato commesso, a partire dal
29.09.1982, in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo
dell’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra) e in altre località.
2 – Il ragionamento giuridico del
Tribunale
Premesso che all’imputato erano
stati contestati i reati di partecipazione ad associazione per delinquere (per
il periodo fino al 28 settembre 1982) e di partecipazione ad associazione di
tipo mafioso (per il periodo successivo), il Tribunale, citando ampiamente l’insegnamento
di questa Corte, si è soffermato sull’individuazione degli elementi costitutivi
di tali delitti, ravvisati, per il primo, nella formazione e nella permanenza
di un vincolo associativo continuativo, tra almeno tre persone, allo scopo di
commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune
dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale, cioè di
una struttura organizzativa idonea e, soprattutto, adeguata a realizzare gli
obiettivi criminosi presi di mira e con la permanente consapevolezza di ciascun
associato di far parte dell’illecito sodalizio e di essere disponibile ad
operare per l’attuazione del comune programma criminoso e, per il secondo, nei
medesimi elementi con la caratterizzazione ulteriore dell’autonoma forza di
intimidazione promanante dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni
di assoggettamento e di omertà.
Quindi il Tribunale ha affrontato
il tema del concorso eventuale nel reato associativo, rilevando che, rispetto
all’associazione di tipo mafioso, l’applicazione della figura del concorso
eventuale assume particolare importanza con riferimento alle situazioni di
"contiguità" all’organizzazione criminale, le quali, rafforzando
l’apparato strumentale e agevolando la realizzazione del programma criminoso
dell’illecito sodalizio, possono contribuire in misura rilevante ad esporre a
pericolo i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice (l’ordine
pubblico generale, l’ordine economico, l’ordine democratico, il corretto funzionamento
della pubblica amministrazione) e presentano, pertanto, un notevole disvalore.
Dopo un excursus con cui ha preso
in esame il problema in generale, rilevando che esso si pone soprattutto con
riferimento al concorso materiale, non essendo in discussione l’aspetto del
concorso morale, il Tribunale ha poi affrontato il tema specifico
dell’associazione per delinquere di tipo mafioso, affermando che il prevalente
orientamento della giurisprudenza di legittimità ha, con persuasive
argomentazioni, ritenuto configurabile il concorso eventuale in tale
associazione, pur esprimendo vari indirizzi interpretativi sulla
identificazione dei casi e sulla definizione dei limiti di operatività di tale
ipotesi delittuosa.
In definitiva, la tesi del
Tribunale è che la fattispecie della partecipazione non è suscettibile di
ricomprendere le condotte che si esauriscono in un consapevole contributo
causale solo ad alcune attività dell’associazione; simili condotte atipiche
sono, invece, sussumibili nel concorso eventuale.
Il Tribunale è addivenuto alla
delimitazione della rispettiva area di operatività delle fattispecie della
partecipatone e del concorso esterno facendo riferimento ai criteri fissati
dalla sentenza n. 16 del 1994 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
criteri ritenuti rispondenti alla duplice esigenza di assicurare un’efficace
tutela dei beni giuridici protetti dalla norma di cui all’art. 416 bis c.p.
anche contro le offese prodotte da soggetti estranei alla struttura criminale
e, nel contempo, di garantire il rispetto del principio di necessaria
determinatezza della fattispecie penale, con riguardo, sia alla precisione
della descrizione astratta della condotta punibile, sia alla sua rispondenza a
comportamenti concreti effettivamente riscontrabili nella realtà sociale.
Il Tribunale ha esaminato anche
la qualificazione giuridica dei rapporti illeciti tra esponenti politici e
associazioni di tipo mafioso, precisando che, sulla base delle indicazioni
fornite da dottrina e giurisprudenza, possono al riguardo distinguersi quattro
diverse ipotesi.
La prima è quella dell’esponente
politico che sia formalmente affiliato all’organizzazione mafiosa e occupi una
posizione stabile e predeterminata all’interno della struttura criminale.
Pacifica è, in questo caso, l’applicabilità della fattispecie prevista
dall’art. 416 bis c.p..
La seconda ipotesi è quella
dell’esponente politico che, pur non essendo formalmente affiliato
all’organizzazione mafiosa, abbia instaurato con essa un rapporto di stabile e
sistematica collaborazione, realizzando comportamenti che abbiano arrecato
vantaggio al sodalizio illecito. Anche in questo caso è configurabile il
delitto di cui all’art. 416 bis c.p. perché l’uomo politico finisce con
perseguire anche la realizzazione degli scopi del sodalizio illecito e dimostra
di condividere, orientandola a proprio vantaggio, la logica intimidatoria
dell’associazione mafiosa.
La terza ipotesi è quella del
candidato che, per la prima volta nella sua carriera politica o comunque in
modo occasionale, contratti con esponenti dell’associazione mafiosa il
procacciamento del voto degli affiliati e la coercizione del voto altrui, in
cambio dell’offerta di sistematici favoritismi verso l’organizzazione
criminale. Naturalmente, deve ravvisarsi in concreto un nesso causale tra la
conclusione del patto e il consolidamento del sodalizio illecito. In questo
caso, ad elezione avvenuta, è configurabile una condotta partecipativa,
consistente nella seria manifestazione di volontà in favore dell’associazione
mafiosa.
La quarta ipotesi è quella di
episodiche condotte compiacenti, che si concretino, ad esempio, nella
concessione di singoli favori. Simili comportamenti, rientranti nel concetto di
contiguità mafiosa, non integrano gli estremi della partecipazione mancando
"l’affectio societatis", ma sono riconducibili alla fattispecie del
concorso esterno qualora si risolvano nella effettiva realizzazione di almeno
un apporto che abbia causalmente contribuito alla conservazione o ai
rafforzamento del sodalizio mafioso consentendogli di superare una situazione
di anormalità.
Quindi il Tribunale, premesso che
il procedimento probatorio in tema di reati associativi di tipo mafioso va
individuato nel fatto che quasi sempre la ricostruzione della vicenda
delittuosa proviene in gran parte dall’interno dell’organizzazione criminale
attraverso le confessioni di imputati ad essa già partecipi e poi dissociatisi,
ha affrontato, appunto, il tema della prova del reato associativo, facendo
particolare riferimento ai criteri di vantazione delle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia e affermando che, allo scopo di individuare i
criteri da seguire in proposito, occorre preliminarmente verificare se il
collaborante rivesta o meno una delle qualifiche indicate dal terzo e dal quarto
comma dell’articolo 192 c.p.p.. In caso positivo, occorre applicare la regola
di giudizio prevista dal terzo comma dell’art. 192 c.p.p.;
invece, in caso contrario, le
dichiarazioni del collaborante vanno considerate come testimonianze a tutti gli
effetti e sono soggette al solo limite ordinario dell’attendibilità, da
valutare secondo i normali criteri del libero e giustificato convincimento,
senza cercarne la conferma nei riscontri richiesti dal detto art. 192 comma
terzo c.p.p..
Ha concluso ricordando che, nel
caso della chiamata di correo, il prevalente orientamento giurisprudenziale
richiede una triplice verifica: controllo di attendibilità personale del
dichiarante, controllo di attendibilità intrinseca della dichiarazione e,
infine, controllo di attendibilità estrinseca attraverso i riscontri che alle
dichiarazioni possono venire da altri elementi probatori di qualsiasi tipo e
natura.
3 – La valutatone del compendio
probatorio secondo il Tribunale
E’ necessario ricorrere ad
un’ampia citazione della sentenza di primo grado per consentire una
comprensione adeguata dei fatti all’origine della vicenda processuale.
Essa ha iniziato la propria
indagine di merito dall’esame dei rapporti di Andreotti con i cugini Antonino e
Ignazio Salvo e con i politici Salvatore Lima e Vito Ciancimino.
Secondo il Tribunale,
l’affiliazione di Ignazio Salvo all’associazione criminale Cosa Nostra era
stata accertata dalla sentenza n. 91/90 emessa il 10 dicembre 1990 dalla Corte
di Assise di Appello di Palermo a conclusione del secondo grado di giudizio nel
cd. maxi processo, l’esattezza delle cui conclusioni era stata riconosciuta
dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992 e aveva
trovato conferma nelle risultanze di questo stesso processo (in virtù delle
credibili dichiarazioni degli attendibili Tommaso Buscetta, Antonino Calderone,
Salvatore Cocuzza, Vincenzo Sinacori, Francesco Marino Mannoia; Francesco Di
Carlo, Gioacchino Pennino e Gaspare Mutolo), dalle quali era risultata
l’appartenenza a Cosa Nostra anche del cugino Nino Salvo.
In esito alla disamina di tali
dichiarazioni il Tribunale è pervenuto alle seguenti conclusioni.
I cugini Salvo erano
organicamente inseriti nell’associazione mafiosa Cosa Nostra sin da epoca
anteriore al 1976 (cfr. le dichiarazioni di Buscetta, Calderone, Di Carlo);
Ignazio Salvo era "sottocapo" della "famiglia" di Salemi
(secondo quanto hanno riferito Buscetta, Calderone, Cucuzza, Sinacori,
Pennino); Antonino Salvo, per un certo periodo, aveva rivestito la carica di
"capodecina" della stessa cosca mafiosa (come si evince dalle
affermazioni di Buscetta, Calderone, Cucuzza); i cugini Salvo in un primo tempo
erano stati particolarmente vicini ad esponenti dello schieramento
"moderato" di Cosa Nostra, come Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate
(cfr. le dichiarazioni di Buscetta, Calderone, Cucuzza, Sinacori, Marino
Mannoia, Di Carlo), ma, dopo l’inizio della "guerra di mafia", erano
passati dalla parte dello schieramento "vincente", che faceva capo a
Riina (cfr. le dichiarazioni di Cucuzza, Sinacori, Marino Mannoia, Di Cario);
diversi esponenti di Cosa Nostra si erano rivolti ai Salvo per cercare di
ottenere una favorevole soluzione di vicende processuali (si evince dalle
dichiarazioni di Sinacori, Di Cario, Mutolo, nonché da quelle di altri
collaboranti); i cugini Salvo avevano manifestato ad altri esponenti mafiosi i
loro stretti rapporti con l’on. Lima (risulta dalle dichiarazioni di Buscetta,
Calderone, Di Carlo, Pennino, Mutolo); i cugini Salvo, nei loro colloqui con diversi
esponenti mafiosi, avevano evidenziato i loro rapporti con il sen. Andreotti
(si desume dalle indicazioni fornite da Buscetta, Di Carlo, Pennino), per
alcuni anni l’appartenenza dei Salvo a Cosa Nostra era stata resa nota solo ad
alcuni degli associati (emerge dalle precisazioni compiute da Marino Mannoia,
Di Carlo, Mutolo).
Dalla sentenza emessa il 16
dicembre 1987 dalla Corte di Assise di Palermo nel cd. maxiprocesso emergeva,
comunque, che da tempo erano stati avanzati sospetti sull’inserimento dei
cugini Salvo nel sodalizio criminale. Sul punto, la pronunzia in questione
aveva evidenziato quanto segue: i sospetti sull’appartenenza di Ignazio Salvo
(e del defunto cugino Nino) alla mafia risalivano ad epoca non recente.
Peraltro, in vari rapporti informativi redatti
dai Carabinieri del trapanese, l’attività economica dei Salvo e il loro
inglobamento nell’associazione mafiosa venivano per lo più considerati come
dati di fatto acquisiti dalla pubblica opinione di Salemi In alcuni rapporti si
precisava, anzi, che il padre di Ignazio sarebbe stato considerato, in alcuni
periodi, come il capomafia del paese. Sui problemi relativi alle esattorie e ai
cugini Salvo si era concentrata, nel 1982, l’attenzione del Prefetto di Palermo
gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, il quale – resosi conto dell’importanza della
questione – aveva avvertito l’esigenza di accennarvi in occasione di un suo
incontro con il Ministro dell’Interno on. Virginio Rognoni, svoltosi a Ficuzza
nell’agosto dello stesso anno.
Quindi il Tribunale ha esaminato
l’influenza politica dei cugini Salvo e i loro rapporti con la corrente
andreottiana.
Secondo il primo giudice i
predetti, organicamente inseriti nell’organizzazione mafiosa, avevano
esercitato per un lungo periodo una fortissima influenza sulla vita politica
siciliana. Il loro controllo del sistema esattoriale in Sicilia, sottoposto ad
una particolare regolamentazione che prevedeva un aggio ampiamente superiore a
quello praticato nel restante territorio nazionale e una "tolleranza"
sui tempi di versamento di parte delle somme riscosse, aveva loro assicurato la
disponibilità di enormi importi di denaro, reinvestibili in altre attività. I
Salvo, conseguentemente, erano riusciti ad incidere profondamente sull’esito
delle competizioni elettorali e sulle decisioni assunte in varie sedi
istituzionali, come dimostravano le dichiarazioni dell’on. Giuseppe D’Angelo,
dell’on. Giacomo Mancini. dell’on. Mario Fasino, dell’on. Sergio Mattarella,
dell’on. Giuseppe Campione, di Francesco Maniglia, di Calogero Adamo, dell’on.
Attilio Ruffini, di Gioacchino Pennino, di Giuseppe Cambria, di Francesco Di
Carlo, di Nicolo Mario Graffagnini.
Il Tribunale ha affermato che,
dagli evidenziati elementi di convincimento, si desumeva che tra i Salvo e
l’on. Lima si era sviluppato un solido e duraturo legame di natura personale e
politica.
Inoltre ha ritenuto che l’enorme
influenza esercitata sull’economia e sulla politica siciliana dal centro di
potere facente capo ai cugini Salvo (i quali erano stati in grado anche di
impedire la rielezione all’Assemblea Regionale Siciliana di un ex Presidente
della Regione – l’on. D’Angelo – entrato in contrasto con loro) aveva
consentito loro di sostenere elettoralmente esponenti di diverse correnti della
Democrazia Cristiana, senza per questo incrinare il rapporto privilegiato con
l’on. Lima.
Sul punto è pervenuto alla
conclusione che l’esame del complessivo quadro probatorio acquisito nel corso
dell’istruzione dibattimentale induceva ad affermare che i cugini Salvo avevano
offerto un sostegno aperto, efficace e costante (seppure non esclusivo) a
diversi esponenti della corrente andreottiana, sulla base dello stretto
rapporto di collaborazione e di amicizia personale instaurato da lungo tempo
con l’on. Lima.
Particolare rilievo è stato
attribuito ad alcuni episodi che il Tribunale ha ritenuto provati.
In primo luogo al regalo – un
vassoio d’argento – fatto da Andreotti in occasione delle nozze con Gaetano
Sangiorgi della figlia di Antonino Salvo, Angela, celebrate il 6 settembre 1976,
alla presenza di Salvo Lima e Mario D’Acquisto, circostanza risultante da una
serie di apporti probatori, originati dalle confidenze dello stesso Sangiorgi.
Il Tribunale ha commentato che
1’offerta del regalo presupponeva necessariamente la preventiva instaurazione
di intensi rapporti, anche sul piano personale, quanto meno con Antonino Salvo;
non era risultato, infatti, che – al di fuori dello stretto legame che lo univa
ad Antonino Salvo (e di riflesso ai suoi congiunti) sul piano politico e personale
– l’imputato avesse avuto occasione di intrattenere ulteriori relazioni
amichevoli con gli sposi, ovvero con la famiglia di origine del Sangiorgi.
Ha rilevato, infine, che nessuna
indicazione in tal senso era stata fornita da Andreotti, che, nelle spontanee
dichiarazioni rese all’udienza del 15 dicembre 1995, si era limitato a
sostenere (nel quadro di una completa negazione dei rapporti con i Salvo) di
non avere ricevuto alcun invito o partecipazione per il suddetto matrimonio e
di non avere inviato regali né telegrammi.
In secondo luogo all’incontro
conviviale tra Andreotti e Antonino Salvo presso l’Hotel Zagarella, in
territorio di Santa Flavia, in data 7 giugno 1979, dopo che il primo aveva
tenuto, presso il cinema Nazionale di Palermo, un discorso elettorale di
sostegno della candidatura di Salvo Lima alle elezioni europee alla presenza
del secondo e di Vito Ciancimino. A parere del Tribunale, dagli elementi
raccolti (foto che ritraevano l’imputato insieme al Salvo; numerose
dichiarazioni testimoniali), era emerso che Antonino Salvo, nel caso concreto,
aveva posto in essere, oltre a comportamenti riconducibili alla sua qualità di
soggetto interessato alla società proprietaria dell’Hotel Zagarella, anche
ulteriori condotte inequivocabilmente inquadrabili in un’attività di deciso e
aperto sostegno alla candidatura dell’on. Lima per le imminenti elezioni
europee del giugno 1979. Il primo giudice ha ritenuto particolarmente
sintomatico, al riguardo, il fatto che era stato lo stesso Antonino Salvo ad
ordinare il banchetto e a sostenerne successivamente il costo, evidenziando
che, se se si fosse trattata di una normale prestazione alberghiera espletata
nei confronti di un partito politico, senza alcun ulteriore interesse di
Antonino Salvo, l’ordinativo e la corresponsione del compenso sarebbero stati
effettuati da un esponente o da un funzionario del partito.
Secondo il Tribunale, il contegno
effettivamente serbato da Antonino Salvo denotava, invece, la reale natura del
suo intervento, palesemente finalizzato all’organizzazione e al finanziamento
di un incontro conviviale assai costoso e strettamente connesso al comizio
conclusivo della campagna elettorale dell’on. Lima.
Il convincimento del primo
giudice è stato rafforzato dalla considerazione che la ricostruzione
dell’accaduto prospettata dall’imputato era stata contraddetta dagli ulteriori
elementi probatori, che avevano dimostrato che egli, già nel 1976, conosceva
Antonino Salvo cosi bene da avvertire l’esigenza di inviare un dono nuziale in
occasione del matrimonio della figlia con Sangiorgi.
Era, quindi, perfettamente
conforme alla realtà la sensazione manifestata dai testi De Martino e Conte, i
quali, sulla scorta delle modalità dell’incontro, avevano ritenuto che Antonino
Salvo e il sen. Andreotti già si conoscessero. Le argomentazioni sviluppate
inducevano, quindi, il Tribunale a ritenere che l’imputato aveva
deliberatamente travisato il reale svolgimento dell’episodio, al fine di negare
la sussistenza di ogni rapporto personale e politico con Antonino Salvo.
In terzo luogo alla telefonata
effettuata nel settembre 1983, per conto di Andreotti, da persona qualificatasi
come appartenente alla sua segreteria allo scopo di informarsi
delle condizioni di salute di Giuseppe Cambria, socio dei cugini Salvo e ad
essi fortemente legato, e sotto il profilo dell’esercizio delle comuni attività
imprenditoriali, e sotto il profilo dell’incisiva influenza esplicata sul piano
politico-istituzionale, persona che, al pari di loro, manteneva intensi
rapporti sia con autorevoli esponenti siciliani della corrente andreottiana,
sia con soggetti organicamente inseriti in cosche mafiose facenti capo allo
schieramento dei "corleonesi".
Per quanto riguarda le ragioni
dell’interessamento esplicato da Andreotti, sia pure per il tramite di un
componente della sua segreteria personale, nei confronti di costui, il
Tribunale ha rilevato che le stesse non apparivano riconducibili a rapporti
diversi rispetto a quelli che legavano l’imputato (sotto il profilo personale e
sotto il profilo politico) all’importante centro di potere economico – politico
facente capo ai cugini Salvo e ai soggetti loro vicini.
In quarto luogo all’annotazione
del numero telefonico di Andreotti in un’agenda sequestrata ad Ignazio Salvo in
occasione dell’arresto del medesimo, insieme al cugino Antonino Salvo, avvenuto
il 12 novembre 1984, agenda che poi non era stata rinvenuta e, dunque, non era
stata acquisita agli atti, per cui il Tribunale ha ritenuto provata la
circostanza sulla scorta delle dichiarazioni, ampiamente richiamate, con cui
Laura Iacovoni (vedova del commissario Antonino Cassala, assassinato in un
agguato mafioso nel 1985), Francesco Accordino, già collega di lavoro di
Cassare, e Francesco Forleo, dirigente della Polizia di Stato, avevano riferito
su quanto, in merito, appreso da quest’ultimo. La conclusione era stata che gli
elementi probatori raccolti (incluse alcune dichiarazioni dei cugini Salvo)
dimostravano la disponibilità, da parte di Ignazio Salvo, del numero telefonico
diretto del sen. Andreotti. Il primo giudice ha attribuito alla circostanza
specifico e univoco rilievo indiziante circa l’esistenza di rapporti personali
tali da consentire allo stesso Ignazio Salvo di rivolgersi direttamente
all’imputato contattandolo per mezzo del telefono e non ha ritenuto attendibile
la versione dei fatti esposta dall’imputato, il quale, nelle spontanee
dichiarazioni rese all’udienza del 29 ottobre 1998, aveva negato la circostanza
e anzi aveva posto in dubbio anche l’esistenza della rubrica telefonica.
Tuttavia, per il Tribunale,
l’annotazione del numero della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella
rubrica sequestrata al Salvo non valeva a dimostrare l’esistenza di rapporti
diretti tra quest’ultimo e il sen. Andreotti: era, infatti, ben possibile che
il possesso di tale numero telefonico si ricollegasse all’attività di lobbying
svolta a vasto raggio da Antonino Salvo in funzione dei propri interessi
economico-imprenditoriali.
Invece le ulteriori
argomentazioni difensive sviluppate dall’imputato erano infondate
perché inequivocabilmente contraddette dalle risultanze processuali, oltre che
dagli ulteriori elementi di convincimento che avevano dimostrato l’esistenza di
un diretto rapporto personale tra Andreotti e Antonino Salvo.
In quinto luogo all’utilizzazione,
in occasione di vari viaggi in Sicilia, da parte di Andreotti, come pure di
Salvo Lima, di autovetture blindate intestate alla Satris S.p.A. (società
esattoriale che apparteneva alle famiglie Salvo, Cambria, Iuculano e Corleo),
risultante da alcune parziali ammissioni degli stessi cugini Salvo e dalle
dichiarazioni dell’autista Francesco Filippazzo.
Il Tribunale ha ritenuto non
verosimile, per una serie di considerazioni, l’affermazione dell’imputato di
avere ignorato a chi appartenessero le autovetture da lui utilizzate in tali
occasioni.
Esaurita questa disamina, il
Tribunale è passato all’esame sintetico dei rapporti dei cugini Salvo con
Claudio Vitalone, che li aveva incontrati ripetutamente, e poi alla valutazione
delle difformi deposizioni dei loro familiari, alle quali ha negato particolare
credibilità. In esito all’analisi sopra sintetizzata, è pervenuto alle seguenti
conclusioni:
a) i cugini Salvo, profondamente
inseriti in Cosa Nostra, erano stati più volte interpellati da persone associate
all’illecito sodalizio per cercare di ottenere una favorevole soluzione di
vicende processuali, avevano manifestato a diversi "uomini d’onore" i
loro stretti rapporti con l’on. Lima, e, nei colloqui con una pluralità di
esponenti mafiosi, avevano evidenziato i loro rapporti con il sen. Andreotti;
b) i cugini Salvo, sul piano
politico, avevano offerto un sostegno aperto ed efficace (seppure non
esclusivo) a diversi esponenti della corrente andreottiana, sulla base dello
stretto rapporto di collaborazione e di amicizia personale che essi avevano
instaurato da lungo tempo con l’on. Lima;
c) tra il sen. Andreotti e i
cugini Salvo si erano sviluppati anche diretti rapporti personali, evidenziati
dagli episodi sopra riferiti;
d) il sen. Andreotti, per i
propri spostamenti in Sicilia, aveva utilizzato in più occasioni, e anche per
periodi di diversi giorni, un’autovettura blindata intestata alla Satris
S.p.A., prestata all’on. Lima da Antonino Salvo.
Ma le considerazioni fondamentali
sono state che, sebbene l’affermazione dell’imputato di non avere intrattenuto
alcun rapporto con i cugini Salvo fosse stata inequivocabilmente contraddetta
dalle risultanze probatorie, restava pur sempre da verificare quale valenza
probatoria potessero assumere, rispetto alle contestazioni mosse all’imputato,
i suoi accertati rapporti diretti con i cugini Salvo e che gli elementi di
convincimento raccolti non fossero tali da dimostrare che l’imputato avesse
manifestato ai cugini Salvo una permanente disponibilità ad attivarsi per il
conseguimento degli obiettivi propri dell’associazione mafiosa, o, comunque,
avesse effettivamente compiuto, su loro richiesta, specifici interventi idonei
a rafforzare l’illecito sodalizio.
A questo punto il Tribunale ha
indagato i rapporti tra il sen. Andreotti e l’on. Salvatore Lima, muovendo
dalla carriera politica di quest’ultimo e dalla sua adesione alla corrente
andreottiana.
Ha evidenziato che, come
risultava da numerose testimonianze, l’ingresso nella corrente andreottiana
dell’on. Lima, in precedenza appartenente a quella fanfaniana, che era avvenuto
verosimilmente nel 1969, a seguito diretto della frattura con l’on. Giovanni
Gioia, era stato l’effetto dell’opera di mediazione e di impulso svolta
dall’on. Evangelisti e aveva comportato un notevole rafforzamento della
"presenza andreottiana" in Sicilia. Poi il Tribunale ha trattato i
rapporti di Salvatore Lima con esponenti mafiosi, risultanti dalle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Buscetta, Di Carlo, Siino, Pennino,
Mutolo, Annaloro, Vitale, Marsala, Marino Mannoia, Calderone, Cannella,
Giovanni Brusca e Messina, rapporti che ha ritenuto esistenti e tali da
configurare una stabile collaborazione (il padre di Lima era "uomo
d’onore" della "famiglia" di Palermo Centro) già in epoca
precedente alla sua adesione alla corrente andreottiana. E’ stato, in
particolare, posto in evidenza che egli aveva attuato, tanto prima, quanto dopo
tale adesione, una stabile collaborazione con Cosa Nostra e che aveva esternato
all’on. Evangelisti (uomo politico particolarmente vicino al sen. Andreotti) la
propria amicizia con un esponente mafioso di spicco come Tommaso Buscetta,
esprimendo altresì una chiara consapevolezza dell’influenza di quest’ultimo
soggetto.
La disamina è proseguita con la
verifica della posizione, al riguardo, dell’imputato, dando rilievo alta
considerazione che il problema dei rapporti esistenti tra la corrente
andreottiana siciliana e l’organizzazione mafiosa era stato portato
all’attenzione del sen. Andreotti dal gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa già
nell’aprile 1982. Ma, alla fine, il Tribunale ha constatato che non era rimasto
provato che il sen. Andreotti avesse tenuto specifici comportamenti
suscettibili di assumere rilevanza penale.
Ha, però, sottolineato che il
generale aveva espresso delle considerazioni in merito alla situazione della
Democrazia Cristiana siciliana e alla contiguità con ambienti mafiosi di
esponenti della stessa; che aveva individuato nella corrente andreottiana il
gruppo politico che, in Sicilia, presentava le più gravi collusioni con la
mafia; che, inizialmente, aveva creduto alla buona fede del sen. Andreotti,
ritenendolo responsabile di semplici errori di valutazione e, quindi, gli aveva
offerto con piena lealtà istituzionale il proprio contributo conoscitivo in
merito agli aderenti alla sua corrente in Sicilia; che poi era giunto, nel
corso della sua permanenza nella carica di Prefetto di Palermo, a ipotizzare
che il medesimo esponente politico facesse "il doppio gioco". Ma ha
rilevato che la circostanza che l’imputato fosse il capo della corrente in cui
era inserito l’on. Lima, nel periodo in cui l’attività politica di quest’ultimo
si era proiettata sul piano nazionale, non era sufficiente ai fini
dell’affermazione della sua responsabilità penale per il reato di
partecipazione all’associazione mafiosa ovvero per quello di concorso esterno
nella stessa, in mancanza di ulteriori elementi idonei a dimostrare
inequivocabilmente che, nell’ambito di questo intenso legame di tipo politico,
egli fosse attivamente intervenuto per consentire all’associazione delittuosa
di raggiungere le sue illecite finalità, secondo i principi giuridici
precedentemente esposti. Il Tribunale ha concluso con il rilievo che non solo
si doveva riconoscere che il quadro probatorio acquisito non era sufficiente a
dimostrare che l’imputato avesse personalmente contribuito, in modo concreto ed
effettivo, a indirizzare la sua influenza politica verso specifici obiettivi
immediatamente funzionali all’esistenza e al rafforzamento dell’organizzazione
mafiosa, ma che anzi, con il D.L. 12 settembre 1989, n, 317, la cui
approvazione era stata energicamente contrastata dalle forze politiche
dell’opposizione e da una parte della stessa maggioranza, tanto da renderne
necessaria la reiterazione, e con la legislazione successiva egli, pur avendo
la possibilità di agire diversamente, si era attivamente impegnato per
conseguire un risultato oggettivamente sfavorevole all’organizzazione mafiosa.
Questo quadro di carattere
generale è stato completato con la disamina dei rapporti tra l’imputato e Vito
Ciancimino.
Al riguardo il Tribunale ha
richiamato, in particolare, gli apporti fomiti dall’on. Alberto Alessi,
dall’on. Mario D’Acquisto, dall’on. Sergio Mattarella, da Gioacchino Pennino,
dall’on. Attilio Ruffini, da Antonio Calabrò, da Francesco Di Carlo, da
Giovanni Brusca, dall’on. Giuseppe Campione, da Gaetano Caltagirone e dall’on.
Giacomo Mancini, nonché alcune dichiarazioni rese dall’imputato dinanzi
all’Autorità Giudiziaria di Perugia.
Ciancimino era un esponente della
Democrazia Cristiana di Palermo che aveva instaurato da lungo tempo un rapporto
di stabile collaborazione con lo schieramento "corleonese" di Cosa
Nostra (circostanza che il Tribunale ha ritenuto sicuramente provata indicando
le ragioni del proprio convincimento).
Pur mantenendo la propria
autonomia, il gruppo facente capo a Ciancimino aveva instaurato nel 1976 un
rapporto di collaborazione con la corrente andreottiana, ricevendo l’anno
successivo un sostanzioso finanziamento da parte di Gaetano Caltagirone per il
pagamento delle quote relative al "pacchetto tessere". L’inserimento
formale nella corrente era avvenuto nel 1980; in seguito se ne era distaccato
avendo avuto forti contrasti con l’on. Lima, anche se costui, in occasione del
Congresso Regionale di Agrigento della Democrazia Cristiana, aveva appoggiato,
con l’assenso di Andreotti, la proposta – poi respinta per l’opposizione
dell’on. Sergio Mattarella – di formare una lista unitaria, nella quale
sarebbero state incluse tutte le correnti, compreso il gruppo di Ciancimino,
che cosi avrebbe potuto essere rappresentato nel Comitato Regionale. Andreotti
lo aveva incontrato a Roma tre volte, rispettivamente intorno al 1976 (a
palazzo Chigi), il 20 settembre 1978 e nel 1983.
Ma la conclusione del Tribunale è
stata che le risultanze dell’istruttoria dibattimentale non dimostravano che il
sen. Andreotti, nell’ambito dei predetti rapporti politici con Ciancimino,
avesse espresso una stabile disponibilità ad attivarsi per il perseguimento dei
fini propri dell’organizzazione mafiosa, ovvero avesse compiuto concreti
interventi funzionali al rafforzamento di Cosa Nostra.
Delineato questo quadro politico,
la sentenza di primo grado ha esaminato una serie di episodi posti dall’Accusa
a sostegno della propria tesi.
1) Il presunto incontro che
sarebbe avvenuto nel settembre – ottobre 1970 tra Andreotti e Frank Coppola,
riferito dal collaborante Federico Corniglia, che aveva affermato di avervi
assistito, le cui dichiarazioni sono state ritenute illogiche, generiche,
contraddittorie e sostanzialmente prive di riscontri. Il Tribunale è pervenuto
a questa conclusione dopo aver richiamato anche gli apporti forniti dall’oli.
Alberto Alessi, dall’on. Mario D’Acquisto, dall’on. Sergio Mattarella, da Gioacchino
Pennino, dall’on. Attilio Ruffini, da Antonio Calabrò, da Francesco Di Carlo,
da Giovanni Brusca, dall’on. Giuseppe Campione, da Gaetano Caltagirone e
dall’on. Giacomo Mancini, nonché alcune dichiarazioni rese dall’imputato
dinanzi alla Autorità Giudiziaria di Perugia, e averne rilevato l’inadeguatezza
a confermare la tesi accusatoria.
2) I rapporti di Andreotti con
Michele Sindona. Anche in questo caso la disamina è iniziata dai legami di
quest’ultimo con Cosa Nostra, ponendo in rilievo che le dichiarazioni di una
pluralità di collaboratori di giustizia (Francesco Marino Mannoia, Francesco Di
Carlo, Gaspare Mutalo, Angelo Siino) convergevano nell’affermare che costui
aveva svolto attività di riciclaggio nell’interesse dei massimi esponenti dello
schieramento "moderato" di Cosa Nostra, facente capo a Stefano
Bontate e a Salvatore Inzerillo.
Il Tribunale ha ritenuto che,
nell’ambito del suo finto sequestro, da lui stesso inscenato, Sindona avesse
tentato di ricattare Andreotti in correlazione con la necessità di assicurare
il recupero di ingenti capitali agli esponenti dello schieramento
"moderato" di Cosa Nostra, che in precedenza si erano avvalsi
dell’opera dello stesso Sindona per il riciclaggio dei proventi del
narcotraffico.
Ha poi sviluppato il tema dei
rapporti tra il sen. Andreotti e Michele Sindona ed ha affermato che, dalle
risultanze dell’istruttoria dibattimentale, si desumeva che il primo aveva
rappresentato, per il secondo, un costante punto di riferimento anche durante
il periodo della sua latitanza e che il raccordo tra i due soggetti era noto a
settori di Cosa Nostra i quali, contestualmente, avevano operato in modo
illecito a favore del finanziere siciliano.
Ha sottolineato che l’imputato si
era astenuto dall’attuare iniziative favorevoli al finanziere siciliano con
riferimento ad un’operazione per costui di particolare importanza: il
progettato aumento dei capitale della società Finambro (a lui riconducibile),
operazione necessaria a Sindona per procurarsi liquidità sul mercato, ma ha
anche rilevato che, successivamente, il sen. Andreotti, in diverse altre
occasioni, aveva assunto iniziative favorevoli a Sindona, aveva mantenuto, per
anni, frequenti contatti con i soggetti operanti per conto del finanziere
siciliano e aveva manifestato un reiterato e intenso interessamento per i suoi
più rilevanti problemi, sia di ordine economico, sia di ordine giudiziario.
Il Tribunale ha analizzato a
fondo il tema riferendo anche di un incontro tra i due avvenuto negli Stati
Uniti durante la latitanza di Sindona.
Poi ha concluso che era rimasto
non sufficientemente provato che il sen. Andreotti, al momento in cui aveva
realizzato i comportamenti suscettibili di agevolare il Sindona, fosse
consapevole della natura dei legami che univano il finanziere siciliano ad
alcuni autorevoli esponenti dell’associazione mafiosa e, quindi, che non era
configurabile la partecipazione dell’imputato al reato associativo, pur
rimanendo il fatto che egli, anche nei periodi in cui rivestiva le cariche di
Ministro e di Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana,
si era adoperato in favore di Sindona, nei cui confronti l’Autorità Giudiziaria
italiana aveva emesso, sin dal 24 ottobre 1974, un ordine di cattura per il
reato di bancarotta fraudolenta.
3) II presunto intervento
dell’imputato a favore dell’imprenditore petrolifero laziale Bruno Nardini,
vittima verso la fine degli anni ’70 di richieste estorsive da parte della
’ndrangheta calabrese, episodio che, secondo l’accusa, proverebbe l’esistenza
di un patto di scambio tra Cosa Nostra e Andreotti.
Detto intervento si sarebbe
estrinsecato nell’efficace utilizzazione, quale tramite, del capomafia Stefano
Bontate perché si adoperasse presso la ’ndrangheta calabrese affinchè
cessassero le azioni estorsive poste in essere, in quel territorio, ai danni
del suddetto imprenditore, grande elettore dell’imputato nel Lazio.
Ma la vicenda era stata riferita
solo da Antonino Mammoliti, persona rivelatasi non particolarmente attendibile,
non aveva trovato alcuna conferma nelle dichiarazioni dei numerosi
collaboratori di giustizia escussi nel dibattimento e, anzi, era stata
radicalmente smentita dalla deposizione degli altri protagonisti e, in
particolare, dai diretti interessati.
4) Il regalo di un quadro a Giulio
Andreotti da parte dei capimafia palermitani Stefano Bontate e Giuseppe Calò,
vicenda risultante dalle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia e che, nella
prospettazione dell’accusa, dimostrerebbe l’esistenza, alla fine degli anni
’70, di rapporti tra Giulio Andreotti ed esponenti di Cosa Nostra.
Nella trattazione dell’argomento
è stato fatto richiamo, quali possibili elementi di riscontro, alle
dichiarazioni dell’avv. Antonino Filastò, della gallerista Angela Sassu, del
dr. Domenico Farinacci e del defunto on, Franco Evangelisti, di alcune delle
quali, secondo il consueto metodo espositivo, sono stati testualmente riportati
nella sentenza ampi brani. La sentenza di primo grado ha definito il quadro
probatorio acquisito sul tema incompleto e viziato da incongruenze insanabili,
che ha puntualmente evidenziato nel corso della motivazione.
5) Il presunto incontro che
sarebbe avvenuto a Roma tra l’imputato, Gaetano Badalamenti, uno dei cugini
Salvo e Filippo Rimi allo scopo di "aggiustare" il processo a carico
di quest’ultimo, celebratosi, nei vari gradi di giudizio, a Perugia e a Roma
tra il 1968 ed il 1979.
La vicenda era stata riferita da
Tommaso Buscetta, le cui dichiarazioni sono state, però, ritenute viziate da
estrema contraddittorietà e manifesta genericità. Inoltre il Tribunale,
disattendendo la tesi del P.M., ha ritenuto che la disamina critica delle
dichiarazioni sul punto di Francesco Marino Mannoia, di Vincenzo Sinacori, di
Salvatore Cucuzza, di Giovanni Brusca, di Francesco Di Carlo e di Salvatore
Cancemi (tutte puntualmente riferite anche in modo testuale) conduceva
all’unica conclusione che la tesi di Buscetta, piuttosto che trovarvi sicuro
riscontro, avesse ricevuto palesi e molteplici smentite.
Significativamente, il Tribunale
ha rilevato che divergenze e contraddizioni nelle deposizioni esaminate avevano
cominciato ad emergere persino riguardo alla fase processuale nella quale
l’intervento sarebbe stato svolto.
6) Le dichiarazioni di Tommaso
Buscetta sul caso Moro e sull’omicidio del giornalista Carmime Pecorelli,
fatti, secondo il dichiarante, intrecciati tra loro.
Tale disamina è stata effettuata
ai limitati fini della verifica di eventuali riflessi sul reato associativo,
essendo competente, per la cognizione dell’omicidio del giornalista, l’Autorità
Giudiziaria di Perugia. Pertanto è stata accantonata ogni approfondita analisi
sulle vicende relative all’interessamento di Cosa Nostra per la liberazione
dell’ori. Moro, sequestrato dalle Brigate Rosse, avendo, peraltro, lo stesso
Buscetta affermato esplicitamente, già nel corso delle sue dichiarazioni al
P.M. del 6 aprile 1993, che il coinvolgimento dei cugini Salvo e, quindi,
dell’imputato in tali iniziative, da attuarsi con il tramite di Cosa Nostra,
era frutto di una sua deduzione, nulla risultandogli di specifico.
Nella trattazione sono stati
richiamati ampi stralci del cd. memoriale Moro, passi di articoli di stampa
apparsi sulla rivista "OP" e le dichiarazioni di Buscetta, del m.llo
Angelo Incandela, di Fernando Dalla Chiesa, di Franca Mangiavacca, dell’on.
Egidio Carenini, di Santo Sciarrone, del col. Angelo Tadeo, dell’on. Francesco
Evangelisti, del gen. Nicolo Bozzo, dell’on. Virginio Rognoni, di Paolo Patrizi
e di Maria Antonietta Setti-Carraro. All’esito, il Tribunale ha concluso che,
in ordine alla prospettata causale legata ai pretesi fastidi che il
giornalista, con i suoi articoli e con quant’altro avrebbe potuto rendere
pubblico, avrebbe arrecato al Sen. Andreotti, le risultanze processuali avevano
evidenziato l’insussistenza di elementi certi e univoci comprovanti l’ipotesi
accusatoria.
7) Gli incontri che sarebbero
avvenuti tra l’imputato e l’esponente di Cosa Nostra Michele Greco a Roma nella
saletta riservata dell’Hotel Nazionale, ove Andreotti si recava spesso per
assistere a proiezioni cinematografiche. Essi erano risultati dalle
dichiarazioni dell’imprenditore palermitano Benedetto D’Agostino e ulteriore
materiale probatorio era stato tratto dalle dichiarazioni del com. Domenico
Farinacci, di Massimo Gemini e di Giovanni Brusca, nonché dalle indicazioni
tratte dalle agende dell’imputato. Anche in proposito la sentenza di primo
grado è pervenuta alla conclusione che, non essendo stata adeguatamente
riscontrata, la dichiarazione "de relato" di Benedetto D’Agostino era
insufficiente per affermare l’esistenza di rapporti diretti e personali tra
Giulio Andreotti e Michele Greco.
8) L’incontro che sarebbe
avvenuto nella primavera – estate del 1979 in un albergo di Catania tra
l’imputato e l’esponente di Cosa Nostra Benedetto Santapaola, con la
partecipazione dell’on. Salvo Lima, incontro risultante dalle dichiarazioni di
Vito Di Maggio.
Esse sono state ritenute incerte,
non riscontrate, ma anzi incompatibili con altri elementi acquisiti al
processo, per cui il Tribunale ha concluso che l’incontro non era avvenuto.
9) L’omicidio del Presidente
della Regione Sicilia Piersanti Mattarella. In tale quadro sono stati esaminati
gli incontri dell’imputato con Stefano Bontate e altri esponenti di Cosa Nostra
a Catania e a Palermo. Infatti, secondo la tesi del P.M., fondata soprattutto
sulle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, sussisterebbe una stretta
relazione tra questo omicidio, avvenuto a Palermo il 6 gennaio 1980, e due
incontri del sen. Andreotti con esponenti di primo piano di Cosa Nostra.
Il Tribunale ha rilevato che la
deposizione di Marino Mannoia andava valutata alla stregua dei criteri dettati
dall’art. 192, comma 3, c.p.p. e che la verifica doveva essere particolarmente
rigorosa anche perché le indicazioni del collaboratore erano assolutamente
isolate, non essendo state confermate da altre fonti. Occorreva, dunque,
verificare quali fossero i riscontri acquisiti a conferma dell’attendibilità
del dichiarante e, in proposito, veniva sottolineato che, tanto più generica era
risultata la propalazione, tanto più solidi e inequivoci avrebbero dovuto
essere i riscontri.
Alla luce di queste premesse, ha
ritenuto che le dichiarazioni accusatone, non esenti da genericità e
contraddittorietà, non fossero confortate da adeguati riscontri e che, anzi, la
presenza di Andreotti in Sicilia, nei giorni in cui si sarebbe potuto
verificare il primo incontro, fosse incompatibile con gli impegni altrove dello
stesso documentalmente provati e che la data del secondo incontro fosse rimasta
assolutamente indeterminata e non ricostruibile, stante la vastità del
possibile arco temporale.
10) L’intervento che sarebbe
stato compiuto dall’on. Lima e dal sen. Andreotti per ottenere il trasferimento
di alcuni detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara,
intervento riferito al collaboratore di giustizia Gaetano Costa da Leoluca
Bagarella.
In sintesi, il Costa aveva
riferito che, nel corso o in prossimità delle festività natalizie del 1983,
presso il carcere di Pianosa alcuni detenuti, che stavano organizzando una
rivolta per far cessare i soprusi cui erano sottoposti, avevano invitato il
dichiarante ad aderirvi. Egli ne aveva parlato con Bagarella, il quale gli
aveva consigliato di restare inerte in quanto i detenuti siciliani presto
sarebbero stati trasferiti in un altro istituto penitenziario. Lo stesso
Bagarella, allo scopo di superare le perplessità del dichiarante, aveva
precisato che si stavano interessando per il trasferimento persone come Pon.
Lima, dietro il quale c’era il sen. Andreotti (indicato con l’espressione
dispregiativa "il gobbo") e aveva aggiunto: "quindi siamo
coperti ". Il collaboratore aveva, conseguentemente, persuaso gli altri
detenuti ad attuare soltanto una forma di protesta blanda, consistente in uno
"sciopero della fame". Dopo uno o due mesi, dieci o quindici detenuti
siciliani erano stati trasferiti al carcere di Novara: tra di loro vi erano,
oltre a Bagarella e a Costa, Santo Mazzei, Rosario Condorelli, Antonio
Anastasi, Giuseppe Alticozzi, Nino Marano, Adolfo Scuderi, Gaetano Quartararo e
un individuo di nome Rosario.
In epoca successiva al
trasferimento, Bagarella aveva invitato Costa a comunicare all’esterno
dell’ambiente carcerario che a Messina occorreva indirizzare il consenso
elettorale verso la Democrazia Cristiana e, in particolare, verso la corrente
andreottiana, cosicché il dichiarante, sentendosi obbligato, si era premurato
di fare pervenire tale messaggio ad uno dei responsabili della sua
"famiglia".
Il collaboratore aveva, altresì,
dichiarato di avere conosciuto nel carcere di Livorno, intorno al 1989-90,
Francesco Paolo Anzelmo, il quale gli aveva confidato di essere stato
impegnato, insieme al proprio suocero, nella realizzazione di lavori di
rilevantissima entità a Messina per la costruzione di un complesso edilizio
denominato Casa Nostra, nel quale avevano investito fondi Mariano Agate,
Salvatore Riina, Leoluca Bagarella e i Ganci. Il Tribunale ha ritenuto le
dichiarazioni del collaboratore dotate di un grado elevato di attendibilità
intrinseca e corroborate da numerosi riscontri estrinseci, che avevano
confermato univocamente le modalità oggettive dell’episodio; ha rilevato che
Bagarella non aveva interesse a riferire a Costa cose non vere; ha anche
evidenziato l’assoluta anomalia del provvedimento con cui era stato disposto il
trasferimento dei detenuti, senza alcuna indicazione di ragioni giustificative
e in carenza di qualsiasi atto presupposto. Tuttavia ha concluso che non erano
stati acquisiti riscontri estrinseci dotati di carattere individualizzante, da
cui poter trarre il sicuro convincimento dell’esattezza della riferibilità del
fatto alla persona dell’imputato e che, pertanto, in assenza di riscontri
concernenti in modo specifico la posizione del medesimo, non potesse ritenersi
sufficientemente provato il suo personale coinvolgimento nell’episodio in
esame.
11) Il colloquio riservato tra
l’imputato e Andrea Manciaracina, figlio di Vito Manciaracina, all’epoca agli
arresti domiciliari, svoltosi all’Hotel Hopps di Mazara del Vallo il 19 agosto
1985, riferito dal Sovrintendente Capo di P.S. Francesco Stramandino, che vi
espletava servizio di ordine pubblico.
Il Tribunale ha ritenuto certo
l’incontro che aveva avuto un carattere di particolare riservatezza, tanto che
il Sindaco di Mazara del Vallo, accompagnatore di Manciaracina, non vi aveva
preso parte ed era rimasto davanti alla porta della saletta; ha anche affermato
che al giovane (all’epoca aveva appena 23 anni) interlocutore, che proprio in
quel periodo era stato formalmente affiliato a Cosa Nostra e che era legato da
uno stretto rapporto di fiducia con Salvatore Riina, era stato riservato un
trattamento di assoluto riguardo, consentendogli di incontrare il Ministro
degli Esteri in carica; ha spiegato che la consapevolezza di trovarsi di fronte
ad una persona che godeva dell’appoggio del capo di Cosa Nostra aveva
costituito certamente un fattore idoneo ad ingenerare nel Sindaco di Mazara del
Vallo un forte timore reverenziale, inducendolo ad aderire prontamente alla sua
richiesta di presentargli il sen. Andreotti, a consentirgli un colloquio
riservato con quest’ultimo e ad attendere pazientemente fuori della porta della
saletta in cui si era svolto l’incontro, per evitare che altri potessero farvi
ingresso; ha riconosciuto che l’imputato aveva esposto una versione
dell’episodio non veridica nell’intento di sminuire la valenza indiziaria di un
incontro svoltosi con modalità del tutto diverse rispetto a quelle che
caratterizzano i normali contatti degli esponenti politici con le persone
interessate a rivolgere loro le proprie istanze e da essi occasionalmente
conosciute; ha concluso che, tuttavia, la mera circostanza che il sen.
Andreotti si fosse incontrato con una "persona di fiducia" del capo
di Cosa Nostra non valeva a dimostrare la sua partecipazione ovvero il suo
concorso nell’associazione mafiosa, in mancanza di ulteriori elementi che
consentissero di ricostruire il contenuto del colloquio, nulla essendo emerso
in merito alle richieste formulate da Andrea Manciaracina e alle risposte date
dal sen. Andreotti, né ravvisandosi, nel successivo comportamento tenuto dal
medesimo, specifici elementi sintomatici di una sua adesione alle istanze
prospettate da costui.
12) L’incontro che si sarebbe
svolto tra Giulio Andreotti e Salvatore Riina a Palermo nel 1987.
Riguardo ad esso il Tribunale ha
esaminato le dichiarazioni di Baldassare Di Maggio, che aveva assunto di avere
accompagnato Riina all’incontro e di esserne stato testimone diretto. Ha
esaminato i vari aspetti delle dichiarazioni del collaborante (i suoi rapporti
e incontri con i cugini Salvo, la sua conoscenza con l’on. Lima, la
collocazione temporale dell’incontro tra Andreotti e Salvatore Riina a casa di
Ignazio Salvo, l’oggetto della conversazione tra Andreotti e Riina, la durata e
le modalità dell’incontro) ed ha rilevato che esse erano caratterizzate da una
tale reiterata contraddittorietà (perfino l’anno in cui l’episodio si sarebbe
verificato era stato oggetto di innumerevoli contestazioni, richieste di
chiarimenti e rettifiche), da renderle in più punti del tutto inaffidabili,
difettando del requisito essenziale dell’attendibilità intrinseca.
Pertanto ha concluso che il Di
Maggio non sapeva nulla del contenuto del presunto colloquio e che ogni
indicazione da lui fornita al riguardo era frutto di deduzioni o di mere
ipotesi, come del resto il medesimo aveva finito con l’ammettere.
La ricostruzione di questa
vicenda è proseguita con la disamina degli impegni di Giulio Andreotti a
Palermo il 20 settembre 1987, nell’ambito delle celebrazioni della Festa
dell’Amicizia.
L’accusa ha sostenuto che,
nell’occasione, l’imputato aveva avuto la possibilità di lasciare l’albergo
senza essere visto dagli uomini della sua scorta e dunque di recarsi a casa di
Ignazio Salvo per incontrarvi Salvatore Riina.
Ma, secondo il Tribunale,
l’intrinseca inattendibilità del racconto di Di Maggio e altre emergenze
processuali, come in particolare la deposizione del giornalista Alberto
Sensini, che aveva intervistato Andreotti, escludevano la veridicità
dell’episodio.
In questo ambito sono state
esaminate anche le dichiarazioni di Enzo Salvatore Brusca e di Emanuele Brusca
e quelle di Gioacchino La Barbera, Antonio Calvaruso e Tullio Cannella.
Il Tribunale ha ritenuto le prime
due contraddittorie, in più punti intrinsecamente inattendibili e
insanabilmente incompatibili tra loro e con quelle di Di Maggio e le altre tre
di carattere indiretto e incoerente, quindi inidonee a rafforzare la tesi
accusatoria.
13) I presunti tentativi di
aggiustamento in Cassazione del maxi – processo e i rapporti tra Giulio
Andreotti e Corrado Carnevale, all’epoca Presidente della Prima Sezione Penale.
Numerosi collaboratori escussi
nel corso del dibattimento (tra cui Gaspare Mutolo, Leonardo Messina, Salvatore
Cancemi, Francesco Marino Mannoia e Gaetano Costa) avevano riferito in merito
alle aspettative, diffuse in seno a Cosa Nostra, di un sicuro
"aggiustamento" del maxiprocesso che sarebbe intervenuto grazie alla
riferita e ritenuta disponibilità da parte di quel magistrato, cui sarebbe
spettata, in base agli ordinari criteri di ripartizione degli affari, la
trattazione del processo nella fase di legittimità. In particolare era stato
affermato che: a Roma Carnevale avrebbe "buttato a terra" il
processo, perché Lima aveva parlato ad Andreotti che aveva un’amicizia
particolare con il magistrato (Mutolo); il processo sarebbe stato una
"fesseria" in Cassazione perché alla Prima Sezione Penale c’era
Carnevale "uomo di Andreotti" (Messina); vi era un impegno di Salvo
Lima e di Andreotti per aggiustare il maxiprocesso e tutto sarebbe finito
"a farsa" e in "una bolla di sapone" (Messina); Lima e
Andreotti dovevano intervenire e fare annullare il maxiprocesso (Cancemi);
Riina aveva comunicato di avere preso accordi con Lima, che quest’ultimo aveva,
a sua volta, preso accordi con Andreotti e che Carnevale era una persona che
"sentiva la redinata" ed era in rapporti diretti con l’imputato cui
era molto legato (Cancemi); Andreotti e Carnevale facevano tanto per i mafiosi
(Cancemi); Riina più volte aveva riferito che per questo processo si stavano
interessando i cugini Salvo "e quindi Lima e Andreotti" (Cancemi);
Lima si era effettivamente "mosso" presso Andreotti (Cancemi); alcuni
imputati del processo scarcerati erano stati dissuasi dal darsi alla latitanza
alla vigilia del giudizio di Cassazione da Riina che voleva evitare che si
creasse un "clima negativo" e che li aveva assicurati che "il
Senatore Andreotti e il Senatore Lima stavano provvedendo ad aggiustare il
processo in Cassazione" (Cancemi); tramite Carnevale sarebbe stato trovato
"un vizio, un difetto processuale, dibattimentale" (Marino Mannoia);
Carnevale era in ottimi rapporti con (il capomafia) Ciccio Madonia (da
Vallelunga) e con il figlio di costui, (il capomafia) Giuseppe Madonia (Marino
Mannoia); in Cosa Nostra si vociferava che c’era questo legame tra Andreotti e
Carnevale e che il primo "aveva in mano" l’alto magistrato (Costa);
Andreotti era "molto amico e intimo con Carnevale" e "se
occorreva si poteva utilizzare questa fonte" (Costa); alcuni "uomini
d’onore" scarcerati per decorrenza termini nel 1991 avevano avuto
assicurazioni da Riina che "il Senatore Andreotti e il Senatore Lima
stavano provvedendo ad aggiustare il processo in Cassazione" (Costa). Ma a
fronte di tali indicazioni ne esistevano numerose altre rese da membri
altrettanto influenti del sodalizio mafioso, alcuni dei quali (Sinacori,
Giovanni Brusca, Cucuzza) avevano per anni svolto funzioni di vertice nella
organizzazione, che divergevano, anche su punti essenziali, da quella che
apparentemente sembrava una prospettazione unanime. Da queste ultime era emerso
che: il sen. Andreotti, ben prima della sentenza della Cassazione (30 gennaio
1992), era divenuto un obiettivo per Cosa Nostra, soprattutto dopo l’emanazione
del decreto legge che aveva ricondotto in carcere numerosi capimafia,
scarcerati nel febbraio del 1991 per decorrenza dei termini di custodia
cautelare in forza di una decisione della Prima Sezione Penale della Cassazione
presieduta da Corrado Carnevale (Sinacori); Riina già verso la fine del 1991
diceva che Andreotti, Falcone e Martelli avevano "fatto il
maxiprocesso", avevano "indirizzato il Presidente", avevano
"fatto una Corte in Cassazione dura" (Sinacori); non risultava
affatto che Carnevale fosse stato contattato da Cosa Nostra per il tramite di
Andreotti, né che questi avesse contattato magistrati della Suprema Corte
(Marino Mannoia); Salvo Lima "era la persona che aveva il tramite con
Andreotti" e, sebbene incaricato di interessarsi per il maxiprocesso, non
lo aveva fatto adeguatamente atteso che il giudizio era finito male (Sinacori);
nel corso del processo di primo grado si attendeva fiduciosamente una sentenza
favorevole, al punto che si riteneva che il processo non sarebbe neppure giunto
in Cassazione (Cucuzza); "quello che … facevano sapere da fuori"
era appunto di stare calmi "perché … c’era più speranza nel primo grado
che nell’appello" (Cucuzza); in Cosa Nostra si era "già abbastanza
soddisfatti di com’erano andate le cose dopo il primo grado" anche se
qualcosa "non aveva funzionato al cento per cento" (Cucuzza); i
vertici di Cosa Nostra non avevano mai fatto pervenire agli imputati detenuti
del maxiprocesso l’ordine di "stare tranquilli" (come affermato dal
Mutolo) perché "il processo sarebbe finito molto male, ma poi le cose si
sarebbero raddrizzate in seguito" (Cucuzza); nessuno dall’esterno aveva
fatto sapere "guardate che avete le bastonate e poi vediamo in
Cassazione" (Cucuzza); Giovanni Brusca, su esplicito incarico di Riina, si
era recato ripetutamente, durante tutte le fasi e i gradi del maxiprocesso, da
Ignazio Salvo per sollecitarlo ad un intervento tramite Lima e Andreotti
(Giovanni Brusca); le risposte di Ignazio Salvo erano state sempre
sostanzialmente evasive, se non del tutto negative (Giovanni Brusca); Salvo,
quindi, aveva fatto apparire che "si doveva dare da fare, faceva finta che
diceva vediamo quello che posso fare, però realmente poi faceva e non faceva
non lo so" (Giovanni Brusca); ciò aveva indotto Riina a decretare la morte
di Ignazio Salvo creando disagio in Brusca che andava a trovarlo pur sapendo
che ormai era condannato (Giovanni Brusca); i Salvo dicevano che Andreotti non
si voleva impegnare ma era anche possibile che essi non gli avessero neppure
parlato e quindi l’uomo politico non ne sapesse nulla (Giovanni Brusca:
"può darsi pure che non glielo vanno a dire e quello non sappia
niente"); Riina era convinto che Ignazio Salvo non si sarebbe adoperato
per il maxiprocesso (Giovanni Brusca); la "goccia che aveva fatto
traboccare il vaso" era stata la firma di Andreotti sul decreto che aveva
fatto tornare in carcere gli imputati del maxiprocesso scarcerati per
decorrenza dei termini e quelli agli arresti domiciliari (Giovanni Brusca); mai
Riina aveva fatto riferimento, direttamente e personalmente con Giovanni
Brusca, ad impegni di intervento per il processo assunti da Andreotti (Giovanni
Brusca); le notizie provenienti da Ignazio Salvo e da Emanuele Brusca erano
coincidenti in ordine al fatto che il maxiprocesso in Cassazione stava andando
male (Giovanni Brusca); dall’inizio del maxiprocesso ("fine ’85 inizio
’86") non vi erano più notizie positive per Cosa Nostra da parte di
Ignazio Salvo "e quindi dall’onorevole Lima, quindi dall’onorevole Andreotti"
(Giovanni Brusca); sin da prima delle elezioni del 1987 vi era stata una serie
di segnali dai quali si coglieva il disinteresse di Lima per le sorti del
maxi-processo (Emanuele Brusca).
In presenza di un quadro
complessivo cosi confuso e contraddittorio, il Tribunale ha esaminato
analiticamente le emergenze dibattimentali, con particolare riferimento a due
aspetti della vicenda: la natura dell’intervento e delle specifiche attività
svolte dal presidente Carnevale in relazione al maxiprocesso; l’esistenza di
elementi probatori che attestassero o meno l’effettività di un intervento da
parte dell’on. Andreotti sull’alto magistrato al fine di ottenere
l’"aggiustamento" del maxiprocesso, per verificare l’effettiva
sussistenza di manovre finalizzate ad "aggiustare" il maxiprocesso
nella fase del giudizio di Cassazione e l’eventuale coinvolgimento in esse
dell’imputato. La considerazione conclusiva è stata che, dall’articolata
disamina delle emergenze processuali, non risultava la prova concreta di un
coinvolgimento dell’imputato nel tentativo di "pilotare" il
maxiprocesso verso un esito gradito a Cosa Nostra, essendosi per contro
accertato che il sen. Andreotti era stato, se non esclusivo promotore,
certamente artefice con altri e in più occasioni dell’adozione di rilevanti provvedimenti
legislativi che avevano inciso sull’iter del suddetto processo scongiurando le
scarcerazioni di quegli esponenti mafiosi che sarebbero stati infine
condannati.
14) L’intervento che Licio Gelli
(intenzionato a candidarsi in Calabria) avrebbe richiesto al sen. Andreotti per
la revisione della condanna dei fratelli Gianfranco
e Riccardo Modeo.
Tale intervento risulterebbe dall
’ intercettazione di una pluralità di conversazioni intercorse tra vari
soggetti, tra cui Marino Pulito (imputato di reato connesso), Alfonso
Pichierri, Anna Quero (convivente di Riccardo Modeo), Vincenzo Serraino, Lucia
Santoro (moglie di Gianfranco Quero) e altri
individui.
Anche in questo caso, la sentenza
di primo grado è pervenuta alla conclusione che gli elementi di convincimento
acquisiti non valevano a dimostrare che ti sen. Andreotti avesse ricevuto da
Gelli una richiesta di intervenire per assicurare l’esito positivo del processo
di revisione della condanna riportata dai fratelli Riccardo e Gianfranco
Modeo, né, tanto meno, che Andreotti avesse effettivamente compiuto azioni
volte a conseguire tale risultato.
4 – Le conclusioni del Tribunale
All’esito dell’esame critico
delle emergenze processuali e del complesso probatorio acquisito al
dibattimento, il Tribunale ha concluso che la prova della responsabilità penale
dell’imputato, con specifico riferimento alle varie condotte criminose
contestate, era risultata insufficiente, contraddittoria e in alcuni casi anche
del tutto mancante, imponendo pertanto una pronuncia assolutoria ai sensi
dell’art. S30 comma 2 c.p.p..
Quindi ha ripercorso
sinteticamente le singole vicende rilevando, a conforto della decisione
assunta:
1) L’asserzione dell’imputato di
non avere intrattenuto alcun rapporto con i cugini Salvo era risultata
inequivocabilmente contraddetta dalle risultanze probatorie che avevano
dimostrato l’esistenza di molteplici rapporti di carattere politico,
giudiziario e personale, tuttavia esse non erano tali da dimostrare che
l’imputato avesse manifestato ai cugini Salvo una permanente disponibilità ad
attivarsi per il conseguimento degli obiettivi propri dell’associazione
mafiosa, o, comunque, avesse effettivamente compiuto, su loro richiesta,
specifici interventi idonei a rafforzare l’illecito sodalizio.
2) 1 rapporti con l’on. Salvo
Lima erano stati forti e intensi; l’on. Lima aveva assunto il ruolo di capo
della corrente Andreottiana in Sicilia e raggiunto una posizione di rilevante
forza politica rispetto agli altri esponenti del partito e ai rappresentanti
delle istituzioni, sia in sede locale sia a livello nazionale; il medesimo
aveva attuato, tanto prima quanto dopo la sua adesione alla corrente
andreottiana, una stabile collaborazione con Cosa Nostra ed esternato all’on.
Evangelisti la propria amicizia con Tommaso Buscetta, esprimendo altresì una
chiara consapevolezza dell’influenza di quest’ultimo.
Ma non era stato dimostrato che
il sen. Andreotti avesse tenuto specifici comportamenti suscettibili di
assumere rilevanza penale, in quanto non era rimasto sufficientemente provato
che l’imputato, nell’ambito dei rapporti politici con l’on. Lima, avesse posto
in essere una condotta di inserimento organico nella struttura
dell’associazione di tipo mafioso, ovvero avesse effettivamente realizzato
specifici interventi idonei ad assicurare l’esistenza o il rafforzamento di
Cosa Nostra in una fase patologica della sua vita.
3) Vito Ciancimino aveva
instaurato rapporti di collaborazione con la corrente andreottiana, sfociati
poi in un formale inserimento in tale gruppo politico e tali rapporti avevano
ricevuto, su richiesta dello stesso Ciancimino, l’assenso del sen. Andreotti
nel corso di un incontro appositamente organizzato a questo scopo.
Vi avevano fatto seguito
ulteriori manifestazioni di cointeressenza, sia sotto il profilo dei
finanziamenti finalizzati al pagamento delle quote relative al "pacchetto
di tessere" gestito da Ciancimino, sia sotto il profilo dell’appoggio dato
dai delegati vicini a Ciancimino alla corrente andreottiana in occasione dei
congressi nazionali del partito svoltisi nel 1980 e nel 1983. Tuttavia, anche
in questo caso, le risultanze dell’istruttoria dibattimentale non avevano
dimostrato che il sen. Andreotti, nell’ambito dei rapporti politici
sviluppatisi con Ciancimino, avesse espresso una stabile disponibilità ad
attivarsi per il perseguimento dei fini propri dell’organizzazione
mafiosa,ovvero avesse compiuto concreti interventi funzionali al rafforzamento
di Cosa Nostra.
4) L’incontro con Frank Coppola
non era stato dimostrato perché il quadro di riferimento di tutta la vicenda,
narrata dall’imputato di reato connesso Federico Coniglia, era rimasto
estremamente generico e privo di riscontri validi.
5) Erano certi i rapporti tra il
sen. Andreotti e Michele Sindona, che lo considerava un importantissimo punto
di riferimento politico, cui potevano essere rivolte le proprie istanze
attinenti alla sistemazione della Banca Privata Italiana e ai procedimenti
penali che il finanziere siciliano doveva affrontare in Italia e negli U.S.A..
A questo atteggiamento di Sindona aveva fatto riscontro un continuativo
interessamento del sen. Andreotti, proprio in un periodo in cui egli ricopriva
importantissime cariche governative, dimostrato anche da alcuni specifici
comportamenti che apparivano concretamente idonei – ex ante – ad avvantaggiare
Sindona nel suo disegno di sottrarsi alle conseguenze delle proprie condotte e
inequivocabilmente rivolti a questo fine, quali il sostegno alla nomina del
dott. Mario Barone a terzo amministratore delegato del Banco di Roma e il
conferimento al sen. Stammati e all’on. Evangelisti dell’incarico di esaminare
il secondo progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana.
Ma non era stato sufficientemente
provato che il sen. Andreotti, al momento in cui aveva realizzato i
comportamenti suscettibili di agevolare Sindona, fosse consapevole della natura
dei legami che univano costui ad alcuni autorevoli esponenti dell’associazione
mafiosa e, anzi, non era stata neppure acquisita la prova certa che, al momento
in cui aveva tenuto i predetti comportamenti, l’imputato fosse in possesso di informazioni
tali da ingenerare in lui la consapevolezza che gli effetti del suo operato
avrebbero potuto assumere una notevole importanza per gli esponenti mafiosi per
conto dei quali Sindona svolgeva attività di riciclaggio.
6) Non era stato adeguatamente
provato neppure il presunto intervento del sen. Andreotti a favore
dell’imprenditore petrolifero laziale Bruno Nardini.
Infatti non aveva trovato
conferme l’isolata dichiarazione di Mammoliti, le cui motivazioni a deporre
avevano suscitato legittime riserve.
7) Il presunto regalo di un
quadro a Giulio Andreotti da parte di Stefano Bontate e Giuseppe Calò non
poteva ritenersi provato a causa dell’assoluta genericità del ricordo del dichiarante
Francesco Marino Mannoia proprio sugli aspetti essenziali della vicenda.
8) Il presunto incontro a Roma
tra Gaetano Badalamenti, uno dei cugini Salvo, Filippo Rimi e Andreotti in
relazione al preteso "aggiustamento" del processo a carico di Vincenzo
e Filippo Rimi costituiva uno degli episodi posti dall’accusa a fondamento
della tesi dell’esistenza di un patto di scambio tra Cosa Nostra e Giulio
Andreotti. Ma le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, principale fonte di accusa,
sin dall’origine erano risultate viziate da estrema contraddittorietà e da
manifesta genericità.
9) Il coinvolgimento
dell’imputato nelle iniziative dirette alla liberazione, tramite Cosa Nostra,
dell’on. Moro, sequestrato dalle Brigare Rosse, era, per esplicita affermazione
dello stesso Buscetta, soltanto frutto di una sua deduzione, nulla
risultandogli di specifico al riguardo.
10) Indimostrati erano rimasti
anche i presunti incontri tra Giulio Andreotti e l’esponente di Cosa Nostra
Michele Greco nella saletta riservata dell’Hotel
——————————————————————————–
Nazionale a Roma, perché le
dichiarazioni di Benedetto D’Agostino non erano state sufficientemente
riscontrate.
11) Anche in ordine al presunto
incontro a Catania, nella primavera – estate del 1979, tra Giulio Andreotti e
Benedetto Santapaola, cui avrebbe partecipato anche l’on. Salvo Lima, era stato
accertato che il teste Vito Di Maggio, indotto inconsapevolmente dalla volontà
di rendersi comunque utile alle forze di polizia e alla magistratura, aveva,
con numerose imprecisioni, rappresentato e riferito come certezze quelle che si
erano rivelate invece soltanto vaghe ed errate impressioni, riferendo fatti
talora in maniera non del tutto corrispondente alla realtà.
I due presunti incontri del sen.
Andreotti con Stefano Bontate e altri esponenti di Cosa Nostra a Catania e a
Palermo, strettamente collegati alla causale dell’omicidio del Presidente della
Regione Siciliana on. Piersanti Mattarella, avvenuto a Palermo il 6 gennaio
1980, non erano stati provati dall’Accusa, perché i riferimenti temporali
fomiti da Francesco Marino Mannoia in ordine all’epoca del primo incontro erano
risultati caratterizzati da estrema genericità e approssimazione e, comunque,
non si era riusciti a dimostrare a quale titolo e con quali strumenti
l’imputato avrebbe dovuto e potuto fare ciò che gli veniva richiesto, cioè
influire su Piersanti Mattarella allo scopo di fargli mutare la linea di
condotta politica e amministrativa che configgeva con gli interessi di Cosa
Nostra.
13) L’intervento, che sarebbe
stato compiuto dall’on. Lima e dal sen. Andreotti, per ottenere il
trasferimento di alcuni detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di
Novara nell’anno 1984, era risultato dalle dichiarazioni del collaborante
Gaetano Costa, le quali avevano trovato, negli elementi probatori acquisiti,
puntuale riscontro in ordine al contesto in cui avevano avuto origine e
sviluppo i suoi rapporti con Bagarella, alle manifestazioni di protesta
organizzate presso la Casa di Reclusione di Pianosa, all’identità dei
destinatari del provvedimento di trasferimento, alla collocazione cronologica
dei fatti. Era emersa anche l’assoluta anomalia del provvedimento con cui era
stato disposto il trasferimento dei detenuti, senza alcuna indicazione di
ragioni giustificative e in carenza di qualsiasi atto presupposto. Ma non erano
stati acquisiti riscontri estrinseci dotati di carattere individualizzante, da
cui poter trarre il sicuro convincimento dell’esattezza del riferimento del
fatto delittuoso alla persona dell’imputato.
14) Il colloquio riservato tra il
sen. Andreotti e Andrea Manciaracina, svoltosi all’Hotel Hopps di Mazara del
Vallo il 19 agosto 1985, era sicuramente provato grazie alla testimonianza resa
dal Sovrintendente Capo di P.S. Francesco Stramandino, ma mancava qualsiasi
elemento che consentisse di ricostruirne il contenuto e nel successivo
comportamento tenuto dal sen. Andreotti non erano ravvisabili specifici
elementi sintomatici di una sua adesione alle istanze prospettate dal
Manciaracina.
15) Il presunto incontro,
verificatosi a Palermo nel 1987, tra l’imputato e Salvatore Riina non valeva a
dimostrare l’esistenza, anche alla fine degli anni ’80, di intensi rapporti tra
Giulio Andreotti e Cosa Nostra, perché le dichiarazioni di Baldassare Di
Maggio, che a quell’incontro assumeva di avere accompagnato Salvatore Riina e
di essere stato quindi testimone diretto, erano risultate in più parti
contraddittorie e prive di adeguati riscontri.
16) Le aspettative, diffuse in
seno a Cosa Nostra, di un "aggiustamento" del maxiprocesso, che
sarebbe intervenuto grazie alla disponibilità da parte del dott. Corrado
Carnevale, Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, a
seguito di un patto illecito esistente tra il medesimo e l’on. Andreotti,
aggiustamento che avrebbe dovuto condurre all’annullamento della condanna
pronunciata a carico di numerosi esponenti del sodalizio mafioso nei due
giudizi di merito, non avevano dato risultati negativi per l’imputato perché il
quadro complessivo delineatosi era estremamente confuso e contraddicono e,
quindi, era risultata carente anche la prova di eventuali manovre poste in
essere per l’aggiustamento del maxiprocesso nella fase del giudizio di
Cassazione e della attribuibilità di tali eventuali manovre ad Andreotti.
17) Era possibile ipotizzare che
Andreotti avesse intrattenuto rapporti con Livio Gelli, ma non che essi si
fossero protratti sino al 1991. In ogni caso non era emerso alcun diretto
collegamento tra il sen. Andreotti e la Lega Meridionale, cui Gelli intendeva
dare vita. Né si comprendeva quale interesse potesse avere l’imputato al
conseguimento di un sostegno elettorale per un movimento politico diverso dal
partito in cui egli militava.
5 – L’appello del P.M.
La sentenza è stata impugnata dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dal Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Palermo, che ne hanno chiesto la riforma con
affermazione della responsabilità dell’imputato.
Secondo i P.M. il Tribunale ha
violato i principi giurisprudenziali concernenti sia gli elementi costitutivi
dei reati contestati, principi che – ove correttamente applicati – avrebbero
determinato l’affermazione della responsabilità dell’imputato già sulla scorta
dei soli fatti ritenuti pienamente provati nella stessa motivazione della
sentenza, sia l’apprezzamento delle prove con specifico riferimento ai criteri
di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in generale
e, in particolare, delle dichiarazioni "de relato", oltre che alla
valutazione sintomatica delle menzogne dell’imputato.
Inoltre, anziché procedere ad una
analisi unitaria degli elementi di prova, come pure si era riproposto di fare
nella premessa generale della motivazione, il primo giudice ha proceduto non
già semplicemente all’analisi atomistica degli stessi elementi, ma addirittura
alla destrutturazione del compendio probatorio, che si era articolata:
nell’analisi isolata di ciascun elemento di prova (atomizzazione); nell’asserzione
aberrante della necessità, per ciascun elemento isolatamente considerato, di
riscontri che, in realtà, sarebbero state prove autonome e dirette del fatto
contestato; nella sistematica e inspiegabile omissione della considerazione,
per ciascuno degli elementi esaminati, dei riscontri che erano, in realtà,
emersi nel dibattimento e che erano costituiti da fatti ritenuti pienamente
provati in altre parti della motivazione (destrutturazione).
I P.M. hanno, dunque, lamentato
che il Tribunale ha destoricizzato, decontestualizzato e destrutturato il
compendio probatorio. Quindi hanno esaminato, anche a titolo esemplificativo,
alcuni dei rapporti e degli episodi considerati dal primo giudice (i rapporti
dell’imputato con l’on. Salvatore Lima, con Vito Ciancimino, con Michele
Sindona, l’episodio concernente il trasferimento di Leoluca Bagarella e di
altri detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara nell’anno
1984, l’incontro con il mafioso Andrea Manciaracina, la vicenda Nardini), assumendone
la pregnante efficacia probatoria.
A titolo esemplificativo del
metodo adottato dagli appellanti, basta citare i loro riferimenti al prestigio
politico acquisito da Lima e all’asserito rafforzamento della corrente
andreottiana nella ritenuta piena consapevolezza del rapporto di stabile
collaborazione instaurato con Cosa Nostra, di cui hanno sostenuto essere stata
accresciuta la potenziale capacità operativa (ad esempio attraverso il
controllo di attività economicamente rilevanti) in cambio del sostegno
elettorale.
Sempre a titolo esemplificativo,
gli appellanti hanno sostenuto doversi considerare del tutto irrilevanti le
argomentazioni del Tribunale circa la (presunta) difficoltà di provare la cd.
"affectio societatis" (configurata come dolo specifico) e hanno
aggiunto che era stato del tutto omesso di rilevare che i fatti ritenuti
provati con certezza dimostravano (quanto meno) l’esistenza del dolo generico
del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, considerato anche che il
Tribunale aveva omesso di rilevare il carattere infungibile del contributo
offerto da Andreotti, essendo evidente, che – senza di esso – non sarebbero
stati raggiungibili, mediante il ricorso alla normale opera degli associati,
gli obiettivi, pure strettamente collegati alla conservazione e al
consolidamento della organizzazione mafiosa, della forza politica, economica e
di potere che Cosa Nostra aveva acquisito utilizzando, come struttura di
servizio, la corrente andreottiana.
In definitiva – a loro giudizio –
Andreotti, pur non essendo formalmente affiliato all’organizzazione mafiosa,
aveva instaurato con essa un rapporto di stabile e sistematica collaborazione,
realizzando comportamenti che avevano arrecato vantaggio all’illecito
sodalizio; era divenuto il referente politico abituale di Cosa Nostra e aveva
goduto del suo sostegno elettorale, ciò risolvendosi in un continuativo
contributo, rilevante sul piano causale, all’esistenza e al rafforzamento
dell’illecito sodalizio. Quanto alla valutazione del compendio probatorio, essi
hanno ribadito che la disposizione dettata dall’art 192, commi 3 e 4 c.p.p. ha
condotto la giurisprudenza di legittimità a riconoscere che le dichiarazioni
dei soggetti indicati dalla medesima hanno natura di prova, e non di mero
indizio, sicché il riscontro probatorio estrinseco non deve avere la
consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo esso formare
oggetto di giudizio complessivo assieme alla chiamata e può essere di varia
natura, anche di carattere logico, cosi come tra i riscontri esterni, idonei a
confermare la attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti indicati dall’art.
192, commi 3 e 4 c.p.p., debbono essere valutati "il comportamento del
chiamato in correità, ancorché successivo al fatto-reato" e "l’alibi
falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo
dell’imputato di sottrarsi all’accertamento della verità" nonché "la
rete di rapporti interpersonali, i contatti, le cointeressenze" e "i
rapporti di frequentazione fra il chiamato in correità, indagato per il reato
di associazione per delinquere, e altre persone indagate per il medesimo
reato".
La lamentata destoricizzazione è
stata basata sull’assunto che il Tribunale ha affrontato l’esame di vicende
cruciali e unitarie, snodatesi nell’arco di vari anni, durante i quali si erano
verificate continue evoluzioni delle vicende medesime (situazioni di crisi,
superamenti della crisi, mutamenti di strategie da parte di Cosa Nostra ecc),
appiattendole temporalmente, come se si fossero svolte in unica unità
temporale.
Esempi, particolarmente
significativi al riguardo, sono stati ravvisati dai P.M. nella vicenda del
maxiprocesso e nell’indebita equiparazione delle dichiarazioni dei
collaboratori.
La decontestualizzazione è
consistita – sempre secondo i P.M. -nell’inserimento delle dichiarazioni dei
collaboratori relative a fatti cruciali, come alcuni degli incontri personali
tra l’imputato e i vertici di Cosa Nostra, in uno scenario completamente
"desertificato", perché privato di tutte le risultanze processuali,
che costituivano il presupposto, i riscontri, la chiave di lettura delle stesse
dichiarazioni.
Esemplari, al riguardo, sono
state definite la vicenda di cui il collaboratore Francesco Marino Mannoia era
stato testimone oculare (l’incontro tra Andreotti, l’on. Lima, i cugini Salvo,
Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo e altri "uomini d’onore" in una
villa nella disponibilità di Inzerillo, avvenuto a Palermo nella primavera del
1980, dopo l’omicidio di Piersanti Mattarella), la valutatone delle
dichiarazioni del collaboratore Francesco Di Carlo circa i rapporti tra i
cugini Salvo e il sen. Andreotti e la vicenda Sindona, laddove il Tribunale ha
concluso non essere certo che Andreotti fosse consapevole dei legami mafiosi di
Sindona con Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, i quali avevano affidato al
finanziere i loro capitali da riciclare, dimenticando i fatti già ritenuti
dimostrati nell’ambito di altri capitoli, comprovanti che lo stesso Bontate
aveva affermato di avere a disposizione Andreotti e che Bagarella e gli altri
corleonesi odiavano il Bontate proprio perché costui li teneva fuori dal suo
rapporto privilegiato con l’imputato.
Gli appellanti hanno anche
sostenuto che il Tribunale ha ripetutamente travisato il dato processuale. Ciò
si sarebbe verificato a proposito delle affermazioni di diversi collaboratori
di giustizia e alla valenza probatoria di alcuni episodi.
Come esempi di destrutturazione
sono stati citati, oltre alla mancata visione unitaria del complesso
probatorio, la giustificazione delle asserite menzogne dell’imputato e la
ripetuta omessa considerazione di fatti ritenuti provati in altre parti della
stessa sentenza.
Di seguito i P.M. hanno esaminato
il ruolo che avrebbe svolto Andreotti in relazione a richieste di interessamento
riguardanti vicende giudiziarie, che gli sarebbero state rivolte da soggetti
appartenenti, ovvero collegati, a Cosa Nostra.
A tale proposito hanno imputato
al Tribunale di aver fornito della vicenda una ricostruzione probatoria
inficiata da vari vizi di legittimità, costituiti da: insufficienza di
motivazione, essendo state pressoché pedissequamente ripetute le considerazioni
esposte nella memoria della difesa senza alcuna disamina detta maggior parte
degli argomenti addotti dal P.M., intrinseca contraddittorietà della
motivazione, in contrasto con i principi giuridici ai quali lo stesso Tribunale
– nella parte preliminare della sentenza – aveva affermato di volersi attenere
nel valutare le prove; contraddittorietà o mancanza di motivazione per
l’assoluta omessa indicazione degli elementi di riscontro della specifica
vicenda risultanti da fatti oggetti vi riconosciuti come pienamente provati in
altre parti della sentenza.
Gli appellanti, in esito a tale
disamina, hanno affermato che, dalle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia, sono scaturite tre inequivoche e specifiche circostanze: 1)
l’esistenza di un rapporto di conoscenza tra l’imputato e Gaetano Badalamenti,
inizialmente instaurato – secondo le conoscenze di Buscetta, Brusca e Sinacori
– grazie ai cugini Antonino e Ignazio Salvo; 2) un incontro personale tra
Andreotti e Badalamenti, avente ad oggetto l’interessamento svolto per il
processo Rimi; 3) il fatto che Badalamenti fosse in grado – per la natura e
l’evoluzione del suo rapporto con l’imputato – di avere con lui un tale
colloquio, senza che l’esponente politico lo respingesse.
Essi non hanno trascurato la
vicenda Pecorelli, incentrata sulle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, il quale
era stato il primo a riferire dell’esistenza di un oscuro "intreccio"
tra i segreti del sequestro Moro, il gruppo politico -affaristico facente
riferimento ad Andreotti e i delitti Pecorelli e Dalla Chiesa.
Anche a tale proposito hanno
menzionato una serie di elementi di prova ritenuti confermativi della
fondatezza delle dichiarazioni di Buscetta, rilevando che le omissioni,
sottovalutazioni e travisamenti delle risultanze processuali operate dal
Tribunale avevano impedito di accertare la sussistenza dei reati associativi
contestati all’imputato.
Quindi si sono occupati degli
ipotizzati tentativi di aggiustamento del maxiprocesso e dei rapporti tra il
sen. Andreotti e il presidente Corrado Carnevale, ripercorrendo l’intera
vicenda sulla scorta delle risultanze processuali – in parte asseritamene trascurate
dal Tribunale – per giungere alla conclusione che Riina aveva avuto precise
assicurazioni da Andreotti che l’esito in Cassazione sarebbe stato favorevole;
che sussistevano i rapporti – negati dal Tribunale – tra l’imputato e il
presidente Carnevale (vedi l’interessamento del primo a favore del secondo per
la presidenza della Corte di Appello di Roma e in occasione di un procedimento
disciplinare); che l’opera del dr. Carnevale era stata ostacolata
dall’intervento del primo presidente della Corte Suprema, dr. Brancaccio.
A loro dire, l’esito del
maxiprocesso avrebbe costituito una sconfitta personale per Riina e sarebbe
stato all’origine dell’assassinio dell’on. Lima e, forse, anche di quello di
Ignazio Salvo.
Parte non trascurabile
dell’appello è stata dedicata ad alcuni dei supposti incontri di Andreotti con
i vertici di Cosa Nostra e, in particolare, agli incontri che, secondo
l’accusa, sarebbero avvenuti in Sicilia nel 1979 e nel 1980 con Stefano Bontate
e altri "uomini d’onore".
In questo contesto i P.M. si sono
soffermati sullo scontro tra i "corleonesi" e l’ala moderata di Cosa
Nostra, sullo scenario che aveva generato l’attacco a Piersanti Mattarella,
definito una delle prime vittime del nuovo corso di Cosa Nostra e del contestuale
e corrispondente riassetto di poteri all’interno del partito della Democrazia
Cristiana in Sicilia, sul ruolo dell’on. Rosario Nicoletti (di cui poi hanno
tracciato il profilo riferendo anche dei suoi rapporti con esponenti di Cosa
Nostra), segretario regionale della D.C. suicidatosi il 17 novembre 1984,
cinque giorni dopo 1’arresto dei cugini Salvo, il quale improvvisamente e
inopinatamente aveva preso le distanze dall’on. Mattarella, e, all’esito, hanno
rilevato che le indagini svolte in merito avevano fornito ulteriori e precisi
riscontri circa la partecipazione dello stesso Nicoletti all’incontro riferito
da Marino Mannoia e circa l’atteggiamento assunto dal medesimo nei confronti di
Mattarella.
Secondo gli appellanti,
l’eliminazione di Piersanti Mattarella aveva spianato la strada
all’andreottiano Mario D’Acquisto – i cui rapporti con Cosa Nostra erano stati
riferiti da una pluralità di collaboratori di giustizia – coronando cosi
l’ambizione della corrente di avere un suo uomo al vertice della Regione.
Essi hanno ricomposto le
risultanze processuali configurando il quadro seguente: Bontate aveva tentato
di "affievolire" il discorso su Mattarella e cercato di evitare il
ricorso alla via dell’eliminazione fisica, sottoponendo il problema ad
Andreotti – con il quale il suo schieramento aveva all’epoca un rapporto
privilegiato se non esclusivo – facendogli carico di trovare una soluzione
alternativa. Ma essa non era arrivata e la Commissione aveva deciso
l’esecuzione dell’omicidio, anche con il consenso di Bontate, che in quel
momento non aveva più la forza per far passare dinanzi alla maggioranza
"corleonese" una linea ulteriormente attendista. Quando Andreotti era
tornato a Palermo, nella primavera del 1980, per chiedere spiegazioni
sull’omicidio, Bontate si era rivoltato contro quello che era sempre stato il
suo referente politico.
Infine hanno analizzato gli
incontri del sen. Andreotti con i vertici di Cosa Nostra nel 1979 e nel 1980,
esaminando in successione i seguenti tre aspetti: 1) l’attendibilità personale di
Marino Mannoia, su cui lo stesso Tribunale aveva espresso un giudizio
pienamente positivo; 2) l’attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni,
contestandone il giudizio di genericità, contraddittorietà e incomprensibilità;
3) i riscontri esterni, ritenuti pienamente confermativi di tutti i punti delle
predette dichiarazioni. Dalla disamina gli appellanti hanno ricavato il loro
convincimento circa le modalità del viaggio in Sicilia di Andreotti e
dell’incontro, considerato prova della responsabilità penale dell’imputato.
Nella complessa vicenda, secondo
fa loro prospettazione, andava poi inserito anche l’incontro nel 1987 tra
Andreotti e Riina, di cui hanno ripercorso le fasi probatorie essenziali
criticando la motivazione della sentenza e rivalutando l’attendibilità
personale del collaboratore Enzo Brusca e di Emanuele Brusca per ritenere
dimostrati i fatti da essi riferiti.
Altrettanta credibilità i P.M.
hanno attribuito alle dichiarazioni di Antonio Calvaruso e Tullio Cannella,
confermative dell’incontro in esame, di cui essi hanno affermato essere al
corrente anche un altro autorevole esponente di Cosa Nostra, Leoluca Bagarella.
Sempre con riferimento al tema
dell’incontro tra Andreotti e Riina, i P.M. hanno esaminato le dichiarazioni di
Baldassare Di Maggio, allo scopo di dimostrare come esse fossero adeguatamente
riscontrate e si inserissero in un contesto probatorio doviziosamente
articolato.
Da ultimo, i P.M. hanno
depositato motivi aggiunti con cui hanno affrontato due ulteriori temi in
precedenza trascurati: 1) l’incontro fra Andreotti e Benedetto Santapaola,
avvenuto a Catania nel 1979; 2) le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia
concernenti il regalo di un quadro al sen. Andreotti da parte di Stefano
Bontate e Giuseppe Calò.
Quanto al primo episodio, hanno
sostenuto che il Tribunale aveva travisato le dichiarazioni di Vito Di Maggio
(dotate di adeguati riscontri) e aveva errato nel collocarlo temporalmente
(secondo gli appellanti è sicuramente avvenuto dopo il 15 giugno 1979).
Quanto al secondo episodio, hanno
stigmatizzato la statuizione del Tribunale circa incompletezza e insufficienza
della prova del fatto specifico, tra l’altro contestando che le dichiarazioni
di Marino Mannoia fossero incrinate sotto i profili della genericità e della
inattendibilità intrinseca e lamentando la svalutazione delle dichiarazioni
della teste Sassu.
La difesa ha depositato una
memoria per contrastare le avverse argomentazioni ed esporre le proprie tesi in
fatto e in diritto.
6 – Il ragionamento della Corte
di Appello
La sentenza impugnata premette
un’enunciazione di carattere programmatico: il solo valido metodo che il
giudice deve utilizzare nel vagliare gli elementi che vengono sottoposti alla
sua attenzione è quello di orientarsi secondo una ragionevole valutatone degli
stessi in stretta relazione al caso concreto, dando, quindi, conto dei motivi
del suo libero convincimento, che deve maturare nel rispetto inderogabile non
tanto di astratti principi interpretativi di elaborazione giurisprudenziale,
quanto di alcuni essenziali precetti legali, che, nei casi come quello di
specie, in cui la gran parte delle indicazioni di prova provengono da imputati
in procedimenti connessi, vanno individuati, innanzitutto, in quelli dettati
dall’art. 192 c.p.p.. La Corte territoriale ha ritenuto, fornendone analitici
esempi, che vi fosse stata una certa propensione di taluni collaboratori di
giustizia (Federico Corniglia per il presunto incontro con Frank Coppola,
Marino Pulito per il supposto intervento dell’imputato nel tentativo di
condizionare l’esito di un procedimento di revisione che interessava i fratelli
Gianfranco e Riccardo Modeo, Antonino
Mammoliti per la vicenda dell’intervento dei mafiosi palermitani in favore
dell’industriale Bruno Nardini, i fratelli Emanuele ed Enzo Salvatore Brusca
per t collegamenti con Salvatore Riina, Benedetto D’Agostino per gli incontri a
Roma, all’interno dell’Hotel Nazionale, di Andreotti con il capomafia Michele
Greco, Michelangelo Camarda a proposito dell’incontro con Riina) ad offrire
indicazioni a carico del sen. Andreotti.
Poi ha rilevato che le conoscenze
diffuse, all’interno di Cosa Nostra, fra gli "uomini d’onore" su
fatti di interesse generale, suscettibili in astratto di coinvolgere una
personalità come quella del sen. Andreotti, potevano scaturire solo da informazioni
mediate, provenienti dai vertici del sodalizio mafioso (un qualsiasi affiliato
non avrebbe potuto accedere direttamente ad eventuali rapporti con l’imputato),
vertici che, dopo l’avvento dei "corleonesi" in esito alla feroce
faida dei primi anni ’80, si identificavano, in sostanza, nella persona del
boss Salvatore Riina: ne derivava che, nel valutare le indicazioni collegate
alle voci che si erano propagate fra gli "uomini d’onore", si doveva prudentemente
considerare anche l’origine delle stesse e la possibile incidenza sulla
veridicità del loro contenuto e sulla messa in circolo di erronee valutazioni,
quando non di precisi interessi e scopi verticistici, strettamente inerenti
alle esigenze di governo della organizzazione criminale.
Analogamente – sempre secondo il
giudice di appello – non era trascurabile la possibile incidenza di
inclinazioni alla mitomania e/o al protagonismo giudiziario e perfino
l’influenza di antipatie politiche anche su quegli atteggiamenti spontaneamente
collaborativi dai quali erano scaturite alcune, più o meno tardive,
testimonianze; antipatie che avevano, comunque, condizionato il tenore delle
stesse (come esempi vengono citate le dichiarazioni di Rosalba Lo Jacono circa
il regalo fatto dal sen, Andreotti in occasione delle nozze della figlia
maggiore di Antonino Salvo; di Antonino Filaste a proposito del quadro del
pittore Gino Rossi che alcuni boss mafiosi avrebbero donato ad Andreotti; di
Vito Di Maggio a proposito di un incontro avvenuto nel 1979 fra Andreotti e il
capomafia Benedetto Santapaola).
In questo contesto, una
particolare disamina è stata riservata alla deposizione del dott. Mario
Almerighi relativa all’intervento che Andreotti avrebbe effettuato per bloccare
un procedimento disciplinare a carico del dott. Corrado Carnevale, disamina che
la Corte ha concluso condividendo le valutazoni di segno negativo del
Tribunale, che ha ritenuto essere state ingiustamente attaccate dai P.M.
appellanti.
Da questa vicenda la Corte
territoriale ha tratto spunto per esaminare anche quella relativa
all’interessamento telefonico per le condizioni di salute di Giuseppe Cambria,
episodio che ha inquadrato nel tema dei rapporti dell’imputato con i cugini
Salvo.
La conclusione è stata di
evidenziare che i due testi (Cesare Scardulla e Michele Vullo),
"politicamente" motivati nella lotta contro la mafia e il malaffare,
avevano inizialmente impresso alle loro deposizioni un senso spiccatamente
accusatorio, indirizzandole verso una decisa conferma dei rapporti fra
l’imputato e i Salvo e attenuando, in qualche modo, la valenza delle loro
indicazioni soltanto dopo le contestazioni della difesa.
Da ciò la Corte territoriale ha
ricavato la sottolineatura della particolare esposizione di tutta l’inchiesta,
largamente pubblicizzata dai mass media, alla interferenza, potenzialmente
inquinante, derivante dalla pregressa conoscenza, da parte di vari dichiaranti,
dei temi di prova e del contenuto di altre, precedenti propalazioni o
acquisizioni.
Per questo, ad esempio, secondo
la sentenza impugnata, ben altra efficienza dimostrativa si sarebbe potuta
riconoscere alle dichiarazioni dei fratelli Brusca in merito all’incontro fra
l’imputato e Riina se le stesse fossero state rese quando i dichiaranti erano
ignari delle precedenti propalazioni di Di Maggio.
Poi la Corte ha affermato di non
considerare verosimile che la peculiare posizione dell’imputato potesse, in
astratto, indurlo a nascondere relazioni non particolarmente edificanti. La sua
lunghissima carriera politica lo aveva tal ora messo a contatto, qualche volta
anche molto intimo, con personaggi assai chiacchierati (ad esempio Licio Gelli,
Michele Sindona, Vito Ciancimino, lo stesso Salvo Lima) senza che avesse dato
mai segno della preoccupazione di nascondere o di allontanare tali
frequentazioni, su alcune delle quali aveva insistito, con una certa
spregiudicatezza, malgrado il levarsi di voci pesantemente critiche.
Pertanto, secondo la Corte, la
questione dell’interpretazione dei suoi atteggiamenti eventualmente menzogneri
doveva, piuttosto, tenere conto della peculiarità dell’accertamento giudiziale
da operare, pur restando impregiudicata la possibilità di trarre un, per quanto
generico, utile elemento di valutatone dalla reiterata ed eventualmente
verificata inclinazione a nascondere specifici fatti o relazioni di qualche
pregnanza. La Corte ha concluso le proprie enunciazioni programmatiche
affermando che se occorreva, in termini generici, respingere il metodo
valutativo improntato alla frammentazione del quadro probatorio, doveva anche
affermarsi la tendenziale necessità di una inevitabile, rigorosa valutazione di
ciascun fatto, senza che ciò implicasse una imprescindibile, precisa conferma
esterna di ogni singolo episodio.
Sotto il profilo giuridico, la
Corte ha sottolineato di non ritenere essenziale, ai fini della responsabilità
in ordine al reato associativo, l’individuazione di concreti contributi
arrecati dal singolo associato alle specifiche attività di Cosa Nostra, essendo
sufficiente a fondare la stessa responsabilità la semplice adesione al
sodalizio, apprezzabile, di per se, come un importante apporto.
Del resto, la norma
incriminatrice punisce la semplice partecipazione alla associazione
delinquenziale e non richiede affatto la prova di un concreto impegno del
singolo "uomo d’onore" in specifiche incombenze. Le emergenze
processuali hanno indotto il giudice di appello ad escludere la riconducibilità
della figura dell’imputato a quella di "uomo d’onore", ritualmente e
organicamente affiliato a Cosa Nostra e che il predetto fosse considerato dai
mafiosi alla stregua di uno di loro.
Ma detto giudice ha anche
precisato che la commissione del delitto associativo può ravvisarsi in altri
meno intimi legami, che, quantunque non riconosciuti come legittimanti dagli
stessi affiliati alla organizzazione criminale, indichino all’interprete una
partecipazione alla stessa: l’individuazione di tali legami, dunque, acquisisce
significato essenziale. A questo punto la Corte territoriale ha individuato due
possibili ipotesi di concorso nel reato associativo prescindenti
dall’inserimento formale nella organizzazione mafiosa.
1) Il primo caso riguarda
un’attività di cooperazione continuativa con il sodalizio criminale,
equiparabile, sul piano sostanziale, ad una vera e propria adesione allo
stesso, pure in assenza di formale affiliazione, cui deve corrispondere la
consapevolezza degli affiliati di poter fare affidamento sull’apporto
dell’agente.
In qualche modo assimilabile allo
schema profilato è l’ipotesi in cui, pur in assenza di una formale affiliazione
e in presenza di un legame meno intimo di quello appena prospettato, l’agente
abbia deliberatamente e consapevolmente prestato al sodalizio mafioso, inteso
nel suo complesso, un contributo non episodico ma di apprezzabile continuità e
stabilità, tale da rivelare, in buona sostanza, la coscienza e la volontà di
aderire all’associazione criminale.
2) Il secondo caso concerne non
già un comportamento continuativo di adesione e cooperazione alle finalità del
sodalizio, che l’agente fa proprie, ma si estrinseca in singoli e concreti
contributi all’associazione mafiosa, le cui caratteristiche, però, devono
essere tali da arrecare un apporto essenziale alla vita dell’organizzazione in
vista del superamento di momenti di particolare difficoltà della stessa: in
questa seconda ipotesi non è necessario che l’agente faccia proprie le finalità
dell’organizzazione, potendo egli perseguire scopi propri, purché nella
consapevolezza dell’essenziale aiuto prestato all’intero sodalizio.
Sempre secondo la Corte
d’Appello, la distinzione fra "uomo d’onore", organicamente e a pieno
titolo (cioè con la pienezza del relativo "status" e delle connesse
"prerogative") inserito nel sodalizio criminale, e semplice partecipe
all’associazione nel senso delineato, é densa di pregnanti ricadute sul piano
ontologico e, di conseguenza, su quello della prova del reato. Infatti, in
entrambe le profilate ipotesi di partecipazione non formale, ciò che radica la
condotta associativa è il contributo arrecato dall’agente alla organizzazione,
a differenza di quanto avviene per il soggetto formalmente affiliato alla
organizzazione ("uomo d’onore"), non può, infatti, ritenersi
sufficiente a costituire prova della stabile partecipazione al sodalizio
mafioso l’affermata sussistenza di un semplice status dell’agente, che non sia
corredata da adeguate indicazioni concernenti l’apporto conferito dal medesimo
all’associazione criminale.
A differenza della partecipazione
anche formale, le profilate, meno intime, forme di partecipazione consentono
un’adesione circoscritta nel tempo e comportano una limitata conoscenza della
compagine criminale.
Con riferimento al caso concreto,
il giudice di secondo grado si è poi chiesto se la stabile partecipazione
"non formale" potesse essere radicata dalla prova di una semplice,
continuativa disponibilità, anche in assenza della dimostrazione piena e
concreta di singoli, specifici apporti.
La conclusione è stata che la
semplice consapevolezza, da parte dei membri dell’organizzazione mafiosa,
dell’amichevole disponibilità di un importantissimo personaggio politico
nazionale rafforzi il sodalizio, giustificando negli affiliati il convincimento
di essere protetti al più alto livello, con la conseguenza che la stessa, perdurante
disponibilità può costituire, di per se, un notevole e continuativo contributo
all’associazione criminale.
Poi la Corte territoriale è
passata ad esaminare le nuove prove acquisite nel giudizio di appello, muovendo
da considerazioni circa la attendibilità intrinseca dei dichiaranti Antonino
Giuffré e Giuseppe (Pino) Lipari.
Quanto al primo, ha spiegato di
non disporre di esaustivi elementi di valutazione quali quelli forniti, in
particolare, dalla sperimentata verifica giudiziale della fondatezza delle
indicazioni accusatone, ma di ritenere possibile, pur con adeguate
precisazioni, esprimere un giudizio cautamente non negativo e riconoscere a
Giuffré un apprezzabile grado di intrinseca attendibilità; ma ha concluso che
trattasi di dichiarazioni caratterizzate dalla estrema e, del resto, ammessa,
genericità della maggior parte dei riferimenti, quasi sempre ancorati a notizie
trasmesse da terzi in termini quanto mai vaghi e non corredati dall’indicazione
di fatti o situazioni dotati di specificità.
Quanto al secondo, ha ritenuto di
potergli estendere le già formulate notazioni in termini di genericità, con
l’ulteriore connotazione che egli non aveva riscosso particolare successo
presso i magistrati inquirenti, tanto che nei suoi confronti risultava essere
stata revocata la procedura di ammissione al regime previsto dalla legge per i
collaboratori di giustizia. D’altra parte Lipari aveva, in sostanza, negato
l’esistenza di qualsivoglia interazione dell’imputato con la mafia
"corleonese". In definitiva, la Corte ha tratto l’impressione, dalle
sue dichiarazioni, che costui avesse fatto sapiente uso di cognizioni personali
attinte dalle sue incisive frequentazioni mafiose, accomunandole, talora
confusamente, a informazioni derivate da
notizie di stampa e da propalazioni, a lui note anche per ragioni processuali,
di alcuni collaboratori di giustizia.
Quindi la sentenza ha valutato i
fatti relativi all’epoca antecedente all’avvento dei "Corleonesi"
(inizio 1981), esaminando, in primo luogo, gli episodi connessi all’assassinio
del Presidente della Regione, on. Piersanti Mattarella.
Il punto di partenza è stato
l’incontro – considerato essenziale – tra l’imputato e Stefano Bontate
(Palermo, primavera del 1980).
La Corte di Appello, ritenuta la
piena attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Francesco Marino
Mannoia, in virtù di analitiche considerazioni e facendo leva sull’evidente e
assoluta peculiarità dei fatti narrati sul conto dell’imputato, peculiarità che
la induceva ad escludere che gli stessi fossero frutto di maliziosa invenzione,
ha affermato che questo episodio, da un lato, costituiva elemento atto a
comprovare l’esistenza di relazioni dell’imputato con Cosa Nostra (in
particolare con il gruppo che faceva riferimento a Bontate), dall’altro,
proprio alla stregua della sua peculiarità, rappresentava un momento di crisi
di tale rapporto e ne segnava l’inevitabile declino. Oltre tutto di li a poco
sarebbero stati eliminati da ogni influenza nel sodalizio criminoso i suoi
referenti tradizionali, infatti il gruppo che faceva capo a Badalamenti,
peraltro già estromesso dalla organizzazione, e a Bontate, assassinato
nell’aprile del 1981, sarebbe stato pressoché sterminato a seguito della
cosiddetta guerra di mafia.
Poi ha verificato se gli elementi
processuali acquisiti supportassero adeguatamente le indicazioni – ritenute in
se particolarmente attendibili – di Marino Mannoia.
Un riscontro, anche se da
valutare con cautela per una serie di ragioni, è stato individuato nel
neocollaboratore Antonino Giuffrè, il quale aveva riferito alla Corte di aver
appreso da Michele Greco di incontri che sarebbero avvenuti tra l’imputato e il
capomafia Stefano Bontate, nonché di contrasti che sarebbero intervenuti fra i
due, nel contesto dei quali il secondo avrebbe ammonito il primo ricordandogli
che in Sicilia "comandava la mafia".
Non priva di efficacia probatoria
è stata ritenuta la circostanza che dichiarazioni convergenti erano state rese
anche da Giuseppe Lipari, teste assistito indotto dalla difesa e certamente non
sospettabile, la cui fonte cognitiva era stata Bernardo Provenzano.
Ulteriore conforto la Corte ha
rinvenuto in un argomento logico, considerato utile a riscontrare le
convergenti dichiarazioni di Giuffré e Lipari: il diretto rapporto fra Bontate
e uno dei più eminenti uomini politici nazionali costituiva un fatto idoneo a
solleticare la vanità di un capomafia e ad indurlo ad accrescere il suo
prestigio pariandone ai consociati di vertice e vantandosi di non aver avuto
remore a puntualizzare all’illustre interlocutore chi comandasse in Sicilia.
Con la conseguenza – secondo la Corte territoriale -che dovrebbe ritenersi
strano che dell’episodio non fossero a conoscenza almeno gli esponenti mafiosi
di spicco, sia pure appartenenti a fazioni diverse da quella, sterminata dalla
successiva guerra di mafia dei primi anni ’80, che faceva capo a Bontate e a
Badalamenti, quali erano Greco e Provenzano, rispettivamente fonti di Giuffrè e
di Lipari.
Quindi la Corte ha affermato che
il racconto di Marino Mannoia era stato confermato in ordine, sia
all’atterraggio, nell’occasione, dell’imputato nell’aeroporto trapanese di
Birgi, sia all’effettiva esistenza di rapporti fra l’imputato ed esponenti
mafiosi di primo piano (al riguardo sono state, in particolare, vagliate
criticamente le dichiarazioni di Tommaso Buscetta), sia all’effettiva esistenza
di legami fra i cugini Salvo e l’imputato (oltre a quelle di Buscetta sono
state considerate le dichiarazioni di Giovanni Brusca, anche esse oggetto di
analisi e ritenute attendibili sul punto).
Vi è un ulteriore episodio che la
Corte territoriale, valutandolo in modo difforme dal Tribunale, ha apprezzato
come conferma dell’esistenza delle relazioni de quibus e tale da suggerirne una
plausibile caratteristica fondamentale: l’intervento che il capomafia Stefano
Bontate avrebbe attuato, su richiesta dell’imputato, in favore dell’industriale
Bruno Nardini, raggiunto da pretese estorsive provenienti da esponenti della
’ndrangheta calabrese (in proposito sono state ritenute credibili le
dichiarazioni di Mammoliti, confermate direttamente da quelle di Vincenzo Riso
e indirettamente dalla asserita inverosimiglianza di quelle dello stesso
Nardini).
A quanto sopra la Corte ha
aggiunto la considerazione finale che, ai di fuori del quadro delineato,
rimarrebbe inspiegabile come il sen. Andreotti fosse costantemente rimasto del
tutto estraneo ai pacifici, più o meno intensi, rapporti intrattenuti con i
cugini Salvo da Salvo Lima, Claudio Vitalone e Franco Evangelisti, tutte persone
a lui legate da intime relazioni. Il secondo episodio esaminato, con
riferimento all’epoca antecedente all’avvento dei "corleonesi", è
stato l’incontro – peraltro ritenuto non fondamentale ma utile a suggerire un
pregresso contatto personale avente ad oggetto la vicenda Mattarella – tra il
sen. Andreotti e Stefano Bontate, avvenuto nella primavera – estate del 1979
presso la tenuta dei Costanzo "La Scia", ubicata nei pressi di
Catania.
La Corte, asserita la neutralità
di alcune circostanze quali la mancata prova dell’effettuazione del viaggio, ha
affermato che l’unico elemento suscettibile, in astratto, di ostacolare il
pieno riconoscimento dell’attendibilità della affermazione di Marino Mannoia
era dato dalla eventuale incompatibilità con altre risultanze della
collocazione nel tempo dell’incontro presso "La Scia", collocazione
circoscritta non in forza delle approssimative dichiarazioni del predetto, ma
degli elementi fomiti dal collaboratore Angelo Siino. La stessa ha ritenuto
costui complessivamente attendibile, ma ha spiegato, a proposito della data
dell’episodio, come le sue indicazioni temporali non fossero affatto dotate di
certezza, in quanto inficiate da notevole, comprensibile approssimazione,
frutto non di un immediato e limpido ricordo, ma di una ricostruzione a
posteriori. Quindi ha affermato che l’esattezza dell’individuazione del periodo
in cui avvenne l’incontro operata dal Tribunale (20 giugno / 8 luglio 1979)
rimaneva possibile ma non certa, con la conseguenza che la ragionata esclusione
dell’eventualità che, in quell’arco temporale, l’imputato avesse effettuato un
breve e riservato viaggio a Catania non esauriva la gamma delle possibilità,
non sussistendo elementi certi, suscettibili di escludere che lo stesso viaggio
fosse, in realtà, avvenuto in altro, non lontano ma successivo momento e, in
proposito, sulla scorta di un libro scritto dall’imputato e della sua agenda,
ha definito degna di attenzione la data del 26 luglio 1979, pur ritenendo
possibili date diverse (ad esempio, non ha considerato persuasiva l’analisi
operata dal Tribunale sulla giornata di domenica 8 luglio 1979, caratterizzata
dalla sola annotazione, sulla citata agenda, del nome "Solari" alle
ore 10,00, annotazione astrattamente compatibile con un rapido viaggio in
Sicilia).
I successivi episodi esaminati,
sempre in riferimento all’epoca precedente all’avvento dei
"corleonesi", sono stati l’incontro con il capomafia Benedetto
Santapaola, riferito dal teste Vito Di Maggio e il regalo del dipinto riferito
dal collaboratore Francesco Marino Mannoia, questioni che la Corte ha ritenuto
di poter affrontare, pur se sollevate solo con i motivi nuovi, atteso che
oggetto dell’impugnazione era stato il verdetto assolutorio nella sua
interezza.
Quanto al primo episodio, la
Corte ha spiegato le ragioni che l’inducevano a condividere il giudizio del
Tribunale in ordine alla non attendibilità di Vito Di Maggio, ma ha anche
osservato che l’eventuale diversa valutazione non avrebbe aggiunto nulla di
decisivo alla prova già acquisita, in quanto, per il periodo in esame (1979),
gli amichevoli rapporti e gli incontri dell’imputato con alcuni esponenti
mafiosi dovevano ritenersi, in ogni caso, dimostrati.
Quanto al secondo episodio,
rilevatane l’oggettiva incertezza, la Corte ha conclusivamente ritenuto
attendibili le testimonianze che lo avevano riferito, ma ne ha affermato la non
essenziale rilevanza atteso che, successivamente, non si erano registrati
ulteriori fatti che potessero autorizzare nemmeno il sospetto di un’attività di
Andreotti a favore dei suoi tradizionali interlocutori mafiosi (Bontate e
Badalamenti) e che potessero, dunque, convalidare la persistente disponibilità
del medesimo ad interagire con essi o, comunque, ad agevolarli, o da cui
desumere che l’imputato avesse, a sua volta, richiesto ai mafiosi di attivarsi
per lui o per suoi amici.
Ancora, con riferimento all’epoca
in esame, la Corte territoriale ha poi indagato sugli apporti che il sen.
Andreotti avrebbe conferito a Cosa Nostra e, in particolare, agli esponenti di
quella frangia del sodalizio criminale con i quali intratteneva amichevoli
rapporti, soffermandosi sulla vicenda Sindona. Secondo la sentenza impugnata,
le emergenze processuali avevano dimostrato inequivocabilmente che l’imputato,
fino all’epoca dell’ultimo episodio considerato (primavera 1980), aveva
effettivamente coltivato relazioni amichevoli con i cugini Salvo e con i
vertici della fazione "moderata" di Cosa Nostra (Bontate e
Badalamenti), presumibilmente occasionati dai legami di costoro con l’on. Lima,
il più importante referente di Andreotti in Sicilia.
Ne ha inferito che l’imputato
fosse, in tal modo, divenuto un riferimento per i predetti mafiosi, che
contavano sulla sua amicizia e da essa traevano prestigio all’interno della
organizzazione e fra gli "uomini d’onore", provocando, come riferito
da più fonti, anche le invidie e il risentimento dei membri del sodalizio
esclusi da tale rapporto, senza che, però, ciò implicasse necessariamente che
l’amichevole disponibilità di Andreotti avesse dato luogo automaticamente al
coinvolgimento del medesimo in qualsivoglia, anche importante, affare la cui
soluzione premesse agli ossequiosi e deferenti mafiosi, a loro volta pronti a
soddisfarne le esigenze.
In questo quadro, la vicenda di
maggior rilievo è risultata il salvataggio della Banca Privata Italiana di
Michele Sindona.
La Corte ha concluso in proposito
che, se non si poteva negare che Andreotti avesse palesato interessamento (non
sempre vivo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale) per le sorti di
Sindona, si doveva, però, riconoscere che il medesimo, allorché si era giunti
al momento cruciale e si era trattato di adoperarsi per il
"salvataggio" del finanziere siciliano, non si era spinto più in là
di una benevola attenzione, manifestata particolarmente verso il secondo
progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana (denominato
"giroconto Capisec"), dal momento che, a parte l’incarico di
esaminare tale progetto conferito al sen. Gaetano Stammati (all’epoca Ministro
dei Lavori Pubblici, ma noto banchiere esperto di questioni finanziarie) e
anche all’on. Franco Evangelisti (incarichi peraltro espletati in modi non
graditi a Sindona), non era risultato alcun effettivo intervento dell’imputato
e meno che meno era emerso che egli avesse esercitato indebite pressioni
dirette o anche solo indirette.
Ha ritenuto concreta la
possibilità di un tentativo di ricatto, ordito nei confronti di Andreotti da
Sindona, i cui collegamenti con Gelli erano certi (come erano presumibili
quelli tra costui e Andreotti), tentativo fondato sulla conoscenza di
possibili, pregresse e discutibili vicende, potenzialmente idonee a mettere in
imbarazzo l’esponente politico, e messo concretamente in moto allorché il
finanziere siciliano si era reso conto che l’imputato non si sarebbe
adeguatamente impegnato per risolvere la situazione.
Ha anche ritenuto non
sufficientemente provato che Andreotti avesse interagito, in relazione alla
vicenda Sindona, con i mafiosi palermitani in dipendenza di sollecitazioni a
lui fatte pervenire da costoro. In definitiva, la Corte ha ritenuto che,
malgrado le ripetute menzogne dell’imputato circa i suoi rapporti con Sindona,
tutta la vicenda apparisse, ai fini della verifica della responsabilità
dell’imputato in relazione alla partecipazione alla associazione Cosa Nostra,
sostanzialmente irrilevante e, piuttosto, possibile indizio del fatto che la
sua amichevole disponibilità verso gli esponenti mafiosi non si traduceva
automaticamente in richieste a lui rivolte in vista della soluzione di problemi
piuttosto importanti per la organizzazione criminale.
Secondo la Corte territoriale, il
solo pregnante episodio agevolatilo, di cui il processo aveva offerto concreta
traccia, era legato al condizionamento dell’esito del processo Rimi. Ma ha
anche affermato che la rigorosa valutatone degli elementi acquisiti non
consentiva di spingersi oltre una manifestata disponibilità dell’imputato,
rimanendo irrimediabilmente incerto se il medesimo si fosse concretamente
attivato.
A definitivo suggello della precedente
disamina, la Corte di Appello è pervenuta alla conclusione che, se non si
poteva escludere che Andreotti si fosse, in qualche occasione, pur rimanendo
inerte, assunto "meriti" che, in realtà, non aveva, si doveva
ritenere certo che egli aveva manifestato ai mafiosi con cui era in contatto la
sua amichevole disponibilità e la sua benevolenza e che, con il suo
atteggiamento, aveva, comunque, indotto in essi il convincimento che egli
fosse, in alcuni casi, intervenuto per agevolarli, cosi procurandosi e
conservando L’amicizia e i favori dei medesimi, peraltro già intimamente legati
ai suoi sodali, Lima e Salvo, e comunque inclini ad ossequiare e blandire
l’illustre uomo politico.
Quindi si è chiesta quali
benefici Andreotti avesse tratto dai descritti rapporti amichevoli.
In primo luogo, ha considerato i
benefici elettorali dipendenti dall’appoggio concesso dai mafiosi agli
esponenti siciliani della sua corrente.
L’analisi delle risultanze
processuali ha indotto la Corte a definire arduo individuare un atteggiamento
unitario di tutta l’organizzazione mafiosa in occasione delle consultazioni
elettorali, essendo invece apparsa preponderante l’incidenza delle relazioni
intrattenute con l’elettorato dai personaggi politici locali.
Però ha anche spiegato che,
almeno fino alle elezioni politiche del giugno 1987, l’appoggio elettorale
degli ambienti mafiosi era, a torto o a ragione, comunemente avvertito come
niente affatto trascurabile, cosicché era del tutto plausibile che un uomo
politico potesse ritenere utile, a tale fine, coltivare amichevoli relazioni
con i mafiosi, anche se, nell’ambito del suo stesso partito, tale appoggio agli
appartenenti alla sua corrente non era stato affatto esclusivo (come dimostrato
dal successo della corrente dorotea).
In secondo luogo, la Corte ha
valutato l’eventualità che la propensione dell’imputato ad avere personali,
amichevoli relazioni con esponenti di vertice di Cosa Nostra, relazioni
certamente propiziate dagli intimi rapporti già intrattenuti da Lima, fosse
stata determinata dalla possibilità di utilizzare la struttura mafiosa per
interventi che potrebbero definirsi extra ordinem, ovvero per arrivare, in
taluni cast peculiari, a soluzioni difficilmente raggiungibili seguendo canali
ortodossi (in questo quadro è stata considerata ben inserita la vicenda
Nardini).
Quindi ha esaminato la crisi dei
rapporti tra il sen. Andreotti e la frangia di Cosa Nostra con cui aveva
intrattenuto relazioni amichevoli. Secondo la Corte, Andreotti aveva
oggettivamente sottovalutato la pericolosità dei suoi interlocutori, ma le sue
certezze nei loro confronti si erano infrante tra la seconda parte del 1979 e
l’inizio del 1980, allorché, chiamato ad interessarsi della questione
Mattarella, aveva indicato nella mediazione politica la possibile soluzione
(fonte: Francesco Marino Mannoia), che, tuttavia, dopo alcuni mesi, era stata
del tutto disattesa dai mafiosi, i quali avevano assassinato il Presidente
della Regione, scelta che aveva sgomentato Andreotti, il cui realismo politico
non si spingeva fino a contemplare l’omicidio del possibile avversario.
Sempre secondo la Corte, la
drammatica disillusione, l’emozione suscitata dall’estrema gravita del tragico
assassinio del Presidente Mattarella, soppresso alla presenza dei familiari, e
lo smacco provato nell’aver visto la sua indicazione disattesa spiegherebbero
la sua decisione di "scendere" a Palermo e di incontrare nuovamente
gli interlocutori mafiosi per chiedere chiarimenti e non certo per felicitarsi
di una soluzione che pure era stata, in definitiva, foriera di rimarchevoli
vantaggi per il suo gruppo politico locale e per i suoi amici Salvo. I reclami
e le critiche di Andreotti sarebbero stati, nell’occasione, tanto fermi e
insistiti da suscitare l’irritazione e l’ira di Bontate, il quale, abbandonato
l’atteggiamento solitamente calmo e compassato, avrebbe reagito alzando la voce
e spingendosi perfino a minacciare l’illustre interlocutore di gravissime
conseguenze se fossero state adottate iniziative normative contro la mafia.
La Corte ha ritenuto che, in tal
modo, Andreotti si fosse reso conto che era stato un grave errore immaginare di
poter agevolmente disporre dei mafiosi e di guidarne le scelte imponendo, con
la propria autorevolezza e il proprio prestigio, soluzioni incruente e "politiche"
ai problemi insorti; del resto – sempre secondo il giudice di appello – il suo
convincimento era già stato scalfito da alcuni, recenti e gravissimi fatti di
sangue (gli omicidi del commissario Boris Giuliano, del giudice Cesare
Terranova, e forse anche del capitano Emanuele Basile) circa il rispetto
assoluto dei mafiosi verso gli esponenti delle istituzioni pubbliche. Ciò lo
aveva spinto a rivedere radicalmente i propri rapporti con gli "uomini
d’onore" e ad allontanarsene. Esaurita questa disamina, la Corte di
Appello ha analizzato i fatti relativi all’epoca successiva all’avvento dei
"corleonesi" (dal 1981 – 1982 in poi), premettendo subito che, in
proposito, non era stata acquisita, a differenza di quanto accaduto per il
periodo precedente, alcuna indicazione, anche vaga e sfornita di idonea
efficienza dimostrativa, concernente favori concessi o richiesti dall’imputato
e che non era destinata ad approdare ad esiti positivi la indagine sul
comportamento del medesimo, nel cui atteggiamento non erano ravvisabili neppure
quelle manifestazioni di disponibilità che, con riferimento all’epoca
precedente, aveva considerato provate.
Infatti la situazione oggettiva e
il subentrare dell’egemonia dei "corleonesi", fino ad allora
estromessi da ogni rapporto con Andreotti, tanto da irritarsene, non
consentivano, se non a prezzo di un inammissibile salto logico, di ipotizzare
una continuità delle relazioni fra l’imputato e Cosa Nostra.
La sentenza impugnata ha ritenuto
che Andreotti avesse mantenuto il legame con Lima pur nella consapevolezza dei
rapporti intrattenuti da costui con Bontate e altri mafiosi; tuttavia Bontate
era stato ben presto eliminato dai "corleonesi" e non era dimostrato
(non essendo a tal fine significative le dichiarazioni dei collaboratori) che
Lima avesse allacciato con costoro e con Riina gli stessi rapporti stretti; in
ogni caso, l’imputato si era astenuto da qualsiasi disponibilità personale nei
confronti dei mafiosi, pur mantenendo il suo legame politico con Lima.
Quanto ai rapporti tra Andreotti
e i cugini Salvo, la Corte ha ritenuto che la negazione delta conoscenza, da
parte dell’imputato, inducesse a ritenere la concreta possibilità che costui
fosse, quantomeno, consapevole che i detti rapporti erano risalenti e che erano
da tempo cessati, cosicché la carenza di contatti relativamente recenti aveva
reso più difficile contrastare l’azzardata affermazione difensiva.
La possibilità che le relazioni
fra Andreotti e i Salvo si fossero diradate aveva trovato – secondo la Corte –
un certo qual riscontro in una serie di elementi, quali la scarsa forza
probante dei fatti successivi alla primavera del 1980 addotti dai P.M. (la
telefonata in ospedale, l’uso di autovetture riconducibili ai Salvo, l’assenza
di indicazioni circa le relazioni fra l’imputato e i Salvo provenienti da
eminenti andreottiani della seconda ora, la stessa circostanza che, in
relazione all’omicidio Cappiello, Ignazio Salvo si fosse proposto come semplice
intermediario tra il boss Rosario Riccobono e Lima, che a sua volta avrebbe
dovuto rivolgersi ad Andreotti, anziché interloquire direttamente con lui, la
mancanza di qualsiasi iniziativa dei Salvo per ottenere che l’imputato si
attivasse per il trasferimento di Leoluca Bagarella dal carcere di Pianosa a
quello di Novara), elementi che avevano dato corpo all’indicazione di Francesco
Marino Mannoia, secondo cui i nuovi capi di Cosa Nostra non avevano ottenuto la
disponibilità di Andreotti.
Passando all’esame analitico, la
Corte territoriale ha considerato l’indicazione di Giovanni Brusca circa un
messaggio (gli amici si dessero una calmata altrimenti egli sarebbe stato
costretto a prendere provvedimenti in Sicilia) che Andreotti avrebbe fatto
pervenire ai presunti sodali tramite Antonino Salvo nel corso della cosiddetta
guerra di mafia ed ha ritenuto possibile che egli avesse effettivamente
commentato nei termini sintetizzati la situazione in atto a Palermo, formulando
la fin troppo ovvia osservazione che il protrarsi della stessa avrebbe
costretto all’adozione di misure eccezionali, ma non implicava che siffatta
osservazione fosse effettivamente un avvertimento da comunicare ai mafiosi,
anziché una mera constatazione che lo stesso Salvo, animato dal plausibile
intento di mitigare le violenze, si era premurato di girare al Brusca
ammantandola di accenti ammonitori.
Quindi ha analizzato i rapporti
di Andreotti con Vito Ciancimino, con particolare riguardo all’accordo tattico
concluso in occasione del congresso regionale della Democrazia Cristiana
svoltosi nel 1983 ad Agrigento, condividendo il giudizio finale del Tribunale
circa la loro scarsa incidenza sulla valutatone dell’imputazione contestata,
essendosi Andreotti e Ciancimino incontrati appena quattro volte e non
potendosi assegnare agli interventi dell’imputato un ruolo propulsivo della
collaborazione della sua corrente siciliana con Ciancimino. Per contro, a parte
le rivelazioni generiche e incerte di Antonino Giuffré, non era risultato in
alcun modo che costui, legato ai "corleonesi", avesse fatto da
tramite e spianato la strada a relazioni fra costoro e l’imputato (non a caso,
proprio alla fine del 1981 Ciancimino aveva concluso la sua temporanea e
travagliata adesione alla corrente andreottiana).
Poi la Corte territoriale ha
indagato sui pretesi interventi dell’on. Lima e del sen. Andreotti per ottenere
il trasferimento di alcuni detenuti siciliani (tra cui Leoluca Bagarella) dal
carcere di Pianosa a quello di Novara nell’anno 1984 (nello stesso periodo –
tra la fine del 1983 e il 1984 – il Ministro degli Esteri Andreotti aveva
profuso grande impegno per conseguire l’estradizione di Tommaso Buscetta, la
cui collaborazione è stata di importanza essenziale nella lotta alla mafia),
rilevando che l’unica fonte probatoria, il collaboratore Gaetano Costa, non era
di per se inattendibile, ma che erano mancati i necessari riscontri esterni,
soprattutto quelli individualizzanti.
Infatti la corretta lettura delle
dichiarazioni di Salvatore Cirignotta, direttore dell’Ufficio Centrale detenuti
del Ministero di Grazia e Giustizia, induceva a ritenere che il provvedimento,
raro e non già anomalo, era stato adottato in una situazione di fermento dei
detenuti e che il trasferimento era avvenuto da un carcere di massima sicurezza
ad un altro carcere di massima sicurezza; per di più esso aveva riguardato
anche detenuti estranei a Cosa Nostra.
Inoltre il preteso interessamento
di Andreotti era stato attestato esclusivamente dalla propalazione di un
collaboratore di giustizia che, in buona sostanza, aveva riferito di una
rivelazione, quanto mai vaga nei confronti dell’imputato (Lima si stava
interessando per ottenere il trasferimento e dietro di lui c’era Andreotti),
fattagli da un terzo (Bagarella) sulla scorta di quanto quest’ultimo, a sua
volta, aveva appreso da fonte che non era stato in grado di precisare.
In definitiva, il giudice di
secondo grado ha ritenuto possibile l’eventualità che il trasferimento fosse
stato sollecitato dal solo Lima, considerato anche che costui, avendo ricoperto
la carica di sottosegretario, avrebbe potuto usufruire di legami nel mondo
politico romano e ha concluso che, in ogni caso, l’intervento di Andreotti, ove
fosse stato effettivamente provato, sarebbe avvenuto in un periodo in cui
l’imputato aveva mostrato un consistente impegno istituzionale antimafia e, quindi,
non sarebbe stato idoneo ad integrare una ipotesi di concorso nel delitto di
associazione mafiosa.
La successiva disamina ha
riguardato il colloquio riservato tra l’imputato e Andrea Manciaracina,
svoltosi nell’hotel Hopps di Mazara del Vallo nel tardo pomeriggio del 19
agosto 1985.
Certa la ricostruzione del fatto,
la Corte si è soffermata sulla sua interpretazione, ritenendo che l’incontro
non fosse stato concordato preventivamente e che nell’occasione l’imputato,
ignaro, avesse subito l’iniziativa, piuttosto estemporanea, di Manciaracina,
appoggiata e agevolata dal Sindaco di Mazara del Vallo, e quindi avesse
accordato il colloquio senza che nessuno si fosse preoccupato di segnalargli la
personalità e l’estrazione familiare dell’interlocutore.
Sulle ragioni del colloquio, ha
dapprima stigmatizzato il Tribunale rimproverandolo di essersi abbandonato a
supposizioni invece di procedere al possibile approfondimento investigativo e
poi ha ritenuto ragionevole pensare che esso avesse avuto ad oggetto una o più
sollecitazioni o raccomandazioni rivolte da Manciaracina all’uomo politico, non
essendo immaginabile nessun altro argomento su cui il predetto avrebbe potuto
intrattenersi riservatamente con l’imputato, convenendo, però, che lo
svolgimento riservato del colloquio aveva suggerito che dette sollecitazioni o
raccomandazioni riguardassero favori cui erano interessati esponenti mafiosi.
Ma la Corte palermitana ha
attribuito a ciò scarso rilievo, ai fini del processo, ritenendo che l’accaduto
non bastasse per riconoscere alla relativa condotta pregnante significato ai
fini dell’attribuzione all’imputato di una continuativa disponibilità verso il
sodalizio criminale, ovvero – al di fuori e in alternativa a tale ottica – ai
fini dell’addebito al medesimo di un singolo comportamento agevolativo dello
stesso sodalizio dotato di connotati sufficienti a radicare una ipotesi di
concorso nel delitto di associazione mafiosa, non essendovi alcuna traccia di
una sua successiva attivazione in tal senso.
Poi ha esaminato il presunto
incontro che Giulio Andreotti avrebbe avuto a Palermo con Salvatore Riina, il
quale, alla vigilia delle elezioni politiche del 1987, aveva deciso di
orientare i voti mafiosi verso il P.S.I. per dare uno schiaffo alla D.C. (fatto
che Francesco Marino Mannoia ha collegato al venir meno della disponibilità di
Andreotti), rilevando che la flessione di quel partito era stata tale da non
suscitare particolare preoccupazione nei suoi esponenti, per cui appariva una
forzatura ritenere che Andreotti avesse deciso di correre ai ripari incontrando
Riina.
Quindi ha indicato una serie di
ragioni logiche ostative alla effettività dell’incontro inferendone che, per
ritenerlo provato, sarebbero occorsi specifici apporti, idonei ad offrirne
adeguata e rigorosa dimostrazione. Invece l’attendibilità personale di Vito Di
Maggio non era immune da consistenti rilievi, considerate le innegabili
contraddizioni in cui era incorso, la tardività delle dichiarazioni,
l’inclinazione a raccontare fatti inesistenti, nonché la sua stessa personalità
(si era determinato a collaborare solo per sfuggire alla sua paventata
soppressione decretata dai mafiosi, tanto che, successivamente, aveva ripreso a
delinquere commettendo ulteriori, gravissimi reati).
D’altra parte gli elementi di
riscontro, in particolare le contraddittorie e variate nel tempo dichiarazioni
dei fratelli Enzo Salvatore ed Emanuele Brusca, erano parimenti deficitari
sotto il profilo dell’attendibilità e svalutati dalle considerazioni che non
avevano saputo nulla dell’incontro personaggi di primissimo piano quali
Vincenzo Sinacori e Salvatore Cangemi e che non appariva provato che Riina
avesse parlato dell’episodio con il cognato Leoluca Bagarella.
Queste considerazioni hanno
indotto la Corte palermitana a ritenere sostanzialmente irrilevante la pur
lunga indagine, peraltro approdata a risultati non conclusivi, in ordine alla
mera compatibilità dello svolgimento dell’incontro Andreotti-Riina con i
movimenti dell’imputato nel primo pomeriggio del 20 settembre 1987, che i PM
avevano individuato come quello in cui l’incontro medesimo sarebbe avvenuto
(tra l’altro la Corte ha rilevato che nessun propalante, nemmeno Di Maggio,
aveva mai indicato specificamente al riguardo il mese di settembre 1987 e che
destava forti perplessità l’indicazione della durata approssimativa del
tragitto percorso in macchina da Di Maggio insieme a Riina per trasferirsi dal
luogo di partenza all’abitazione di Ignazio Salvo).
Ma la Corte ha voluto – come una
sorta di avvocato del diavolo – prospettare anche un’ipotetica accettazione
della versione accusatoria per giungere alla conclusione che, in ogni caso,
essa non sarebbe servita per affermare la responsabilità penale dell’imputato,
in quanto varie considerazioni, legate alla interpretazione e valutatone delle
risultanze processuali, avrebbero indotto, comunque, ad escludere che la sua
azione si fosse inserita in un contesto di diuturna disponibilità verso la
tutela degli interessi di Cosa Nostra e che fosse stata sorretta dalla volontà di
cooperare con il sodalizio criminale, mentre più di una riserva si sarebbe
dovuta nutrire sull’eventualità che egli avesse effettivamente inteso
adoperarsi per procurare all’organizzazione mafiosa un contributo essenziale
per la sua sopravvivenza.
Del resto, il suo atteggiamento
psicologico al riguardo era stato confermato dai successivi comportamenti
dell’imputato, quali l’attività svolta per ottenere l’estradizione di Buscetta
e l’impegno profuso per la difficoltosa approvazione del provvedimento che avrebbe
prolungato i termini di custodia cautelare, impedendo la scarcerazione, nel
corso del giudizio di appello, di numerosi imputati del maxiprocesso
(particolarmente rilevante al riguardo la deposizione dell’on. Giuliano
Vassalli, all’epoca Ministro della Giustizia, ulteriormente confortata da
quella del sen. Francesco Cossiga, all’epoca Presidente della Repubblica),
comportamenti interpretati dalla Corte come manifestazioni di particolare
fervore antimafia.
Naturalmente è stato considerato
anche il presunto tentativo dell’imputato di aggiustare il maxiprocesso
attivandosi presso il presidente della prima sezione penale di questo Supremo
Collegio, dr. Corrado Carnevale, fatto riferito da svariati collaboratori di
giustizia (la Corte palermitana ha sottolineato la significativa mancanza, tra
di essi, dell’attendibile Francesco Marino Mannoia, che pure era a conoscenza
delle voci che circolavano nell’ambito di Cosa Nostra a proposito della
"disponibilità" di Carnevale).
Ma, in ogni caso, secondo il
giudice di Appello, anche a voler seguire la ricostruzione dei P.M., malgrado
la disinvoltura della loro prospettazione, finalizzata a conferire alla
collocazione temporale degli avvenimenti un assetto compatibile con la tesi
sostenuta, resterebbe t’intrinseca debolezza di una ipotesi accusatoria che ha
fondato la sua dimostrazione, più che su fatti concreti e accertati,
essenzialmente sulla diffusione fra gli "uomini d’onore" di vaghe
voci e generiche informazioni, peraltro
provenienti da un’unica fonte da identificare in Salvatore Riina.
Secondo la Corte, all’epoca
costui aveva maturato alcune consapevolezze sulla scorta dell’analisi degli
avvenimenti: Andreotti, che un tempo non aveva negato la sua amicizia ad
(altri) esponenti mafiosi, non gli aveva mai dimostrato alcuna disponibilità e
si era, in concreto, rivelato, nel corso degli anni, un nemico sempre più
agguerrito di Cosa Nostra, Lima, anch’egli un tempo amico dei mafiosi avversati
di Riina, era, ormai, inaffidabile per Cosa Nostra e su di lui da tempo non si
poteva più contare, cosicché poteva essere soppresso; del pari poteva essere
soppresso Ignazio Salvo, la cui sorte già da tempo era segnata, come riferito
da Giovanni Brusca.
Tutto ciò spiegava il forte
risentimento di Riina nei confronti dell’imputato senza necessità di ricorrere
alla promessa tradita di adoperarsi per aggiustare il maxiprocesso e, nel
contempo, induceva a negare la disponibilità illimitata di Andreotti ad
intervenire a favore di Cosa Nostra e dei suoi capi.
Del resto, superato eventualmente
questo primo ostacolo, sarebbe rimasto il secondo: la mancata prova della
possibilità di intervenire sul presidente Carnevale e dell’esistenza di un
grado di rapporti tra costui e Andreotti cosi intimo da consentire all’uno di
intraprendere un’azione efficace presso l’altro.
Gli ultimi episodi esaminati
dalla Corte territoriale hanno riguardato le elezioni regionali del giugno 1991
e i casi di Raffaele Bevilacqua e Giuseppe Giammarinaro che, nella
prospettazione accusatone, costituirebbero la riprova della persistente
disponibilità di Andreotti nei confronti di Cosa Nostra.
La candidatura del primo,
sicuramente inserito in Cosa Nostra, era stata sollecitata dall’ori. Lima, che
lo aveva aiutato anche sul piano economico, mentre per sostenere quella del
secondo, persona vicina ai Salvo, si erano attivati diversi esponenti mafiosi.
Ma, sulla base del materiale
probatorio acquisito, la Corte territoriale ha concluso che l’appoggio
elettorale degli "uomini d’onore", peraltro non particolarmente incisivo
sui risultati complessivi (ad esempio Bevilacqua non era stato eletto malgrado
il pieno sostegno di tutta la mafia dell’ennese), era legato più ai rapporti
intrattenuti, a livello locale, con il singolo candidato che ad orientamenti e
considerazioni di carattere generale riguardanti l’azione politica riferibile
al leader nazionale della corrente andreottiana, azione a quell’epoca tanto
palesemente contraria a Cosa Nostra da provocare una comprensibile irritazione
fra gli affiliati (era recente l’emanazione del discusso D.L.n. 60/1991).
Cosi inquadrata la vicenda, il
giudice di appello ha individuato nell’on. Lima il soggetto, nell’ambito della
corrente andreottiana, al quale attribuire la impostazione della campagna
elettorale regionale, le alleanze funzionali alla stessa, i rapporti con i vari
candidati, la loro scelta e la difesa della stessa nell’ambito degli organismi
del partito preposti alla deliberazione delle liste, con esclusione di
qualsiasi coinvolgimento diretto e consapevole dell’imputato, di cui il quadro
probatorio ragionevolmente aveva escluso un consapevole coinvolgimento in
azioni volte ad agevolare l’appoggio elettorale, tollerato dai vertici di Cosa
Nostra e prestato da singoli gruppi mafiosi, a singoli candidati appartenenti
alla corrente del medesimo, meno che meno detta tolleranza e detto appoggio
potevano essere stati propiziati da favori elargiti da Andreotti a Cosa Nostra
o da promesse da lui fatte, potendosi, semmai, ipotizzare un tentativo dei
vertici di Cosa Nostra di ingraziarsi il potente uomo politico dopo il
disorientamento creato dal fallimento della strategia del 1987 e dalla
constatazione di possedere una forza di condizionamento elettorale di
imbarazzante modestia. D’altra parte – sempre secondo la Corte territoriale – la
certezza che l’imputato fosse al corrente dell’appoggio dato dagli esponenti
della sua corrente alla candidatura del mafioso avv. Bevilacqua e delle
resistenze palesate da altri componenti della Direzione Nazionale della D.C.
era frutto di una semplice congettura degli appellanti P.M..
Invece era stata provata e
persino ammessa la conoscenza dell’imputato con Giammarinaro, che però non era
risultato organicamente inserito in Cosa Nostra, per cui, da una parte,
l’appoggio elettorale accordatogli da alcuni mafiosi era fondato su un sistema
di relazioni personali che non scaturivano dalla comune appartenenza al
sodalizio criminale e, dall’altra, ancora meno significativo diventava il
rapporto fra il predetto e l’imputato, il quale si era limitato a partecipare
alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale, ma non era risultato
coinvolto nella scelta del Giammarinaro quale candidato e tanto meno nelle
manovre da costui poste in essere, unitamente all’on. Lima,per assicurarsi
l’appoggio di gruppi mafiosi.
7 – Le conclusioni della Corte
d’Appello
A questo punto la Corte di
Appello ha tratto le proprie conclusioni definitive, affermando che
un’autentica, stabile e amichevole disponibilità dell’imputato verso i mafiosi
non si era protratta oltre la primavera del 1980, dal momento che eventuali e
non compiutamente dimostrate manifestazioni di disponibilità personale
successive a tale periodo erano state semplicemente strumentali e fittizie,
comunque non assistite dalla effettiva volontà di interagire con i mafiosi
anche a tutela degli interessi delta organizzazione criminale; anzi, in termini
oggettivi, era emerso un sempre più incisivo impegno antimafia, condotto
dall’imputato nella sede sua propria dell’attività politica, per cui, in
relazione al periodo in questione, ad onta degli elementi sopra evidenziati,
l’impugnata statuizione assolutoria, che aveva negato un’adeguata prova della
contestata condotta associativa, doveva essere confermata.
La Corte territoriale è, invece,
pervenuta a conclusioni difformi con riferimento al periodo precedente, avendo
ritenuto la sussistenza: 1) di amichevoli e anche dirette relazioni del sen.
Andreotti con gli esponenti di spicco della ed. ala moderala di Cosa Nostra,
Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, propiziate dal suo legame con l’on.
Salvo Lima ma anche con i cugini Antonino e Ignazio Salvo, essi pure, peraltro,
organicamente inseriti in Cosa Nostra; 2) di rapporti di scambio, atteso che
dette amichevoli relazioni avevano determinato il generico appoggio elettorale
alla corrente andreottiana, anche se non esclusivo e non esattamente
riconducibile ad una esplicitata negoziazione e non riferibile precisamente
alta persona dell’imputato; 3) del solerte attivarsi dei mafiosi per
soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze
– di per se non sempre di contenuto illecito – dell’imputato o di amici del
medesimo, 4) della palesata disponibilità e del manifestato buon apprezzamento
del ruolo dei mafiosi da parte dell’imputato, frutto non solo di un autentico
interesse personale a mantenere buone relazioni con essi, ma anche di una
effettiva sottovalutazione del fenomeno mafioso, dipendente da una inadeguata
comprensione – solo tardivamente intervenuta – della pericolosità di esso per le
stesse istituzioni pubbliche e i loro rappresentanti; 5) della travagliata, ma
sintomatica, interazione dell’imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella,
risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del suo disegno di mettere sotto
controllo l’azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di
costoro, di tentare di recuperarlo, promuovendo un definitivo, duro
chiarimento, rimasto infruttuoso per l’atteggiamento arrogante assunto da
Bontate.
La Corte ha, quindi, valutato
giuridicamente i comportamenti dell’imputato al fine di verificare se gli
stessi integrassero, o meno, la contestata partecipatone all’associazione
criminale.
Ha dichiarato estinto il delitto
di associazione per delinquere (capo a della rubrica), essendo decorso, dalla
primavera del 1980, un lasso di tempo ampiamente superiore al termine
prescrizionale di legge; del resto esso si sarebbe prescritto anche
considerandolo commesso, come addebitato, fino alla vigilia della introduzione
del delitto di associazione maliosa (23 settembre 1982), posto che si sarebbe
dovuta escludere l’aggravante di cui al comma 4 della disposizione ineri
minatrice non essendo stata la stessa, in punto di fatto, ritualmente
contestata, poiché non è sufficiente, all’uopo, ascrivere, come era stato
fatto, all’imputato l’appartenenza ad un’associazione per delinquere
genericamente armata, atteso che "in tema di associazione a delinquere
aggravata ai sensi del 4 comma dell’art. 416 c.p., perché sussista la
circostanza aggravante della "scorreria in armi" è necessario che la
condotta si connoti per un aumentato pericolo dell’ordine pubblico e per un
particolare allarme sociale; tali caratteristiche sussistono allorché gli
associati "scorrono" in armi le campagne e le pubbliche vie col
proposito di realizzare le condotte criminose che si riveleranno possibili, con
correlate azioni di depredazione, grassazione e soverchierie, mentre non è
sufficiente che essi possiedano stabilmente delle armi, debitamente occultate,
e che per la commissione dei singoli reati fine effettuino con esse spostamenti
da luogo a luogo" (Cass. sez. V, 3.5.2001 n. 32439, Madonna; in senso
analogo cfr. Cass. sez. VI, 23.1.1998 n. 265, Trisciuoglio). In ogni caso la
prescrizione si sarebbe verificata per effetto della applicazione delle
circostanze attenuanti genetiche, che non potevano essere negate. La Corte ha
osservato che anche il Tribunale non aveva ritenuto del tutto destituito di
fondamento l’assunto accusatorio, ma aveva semplicemente ritenuto non
completamente provata la commissione dei reati contestati, significativamente
menzionando, nel dispositivo, il comma 2 dell’art 530 c.p.p,: la situazione
delineata non era, dunque, quella di un convincimento ampiamente liberatorio
impugnato dal P.M., che avrebbe reso ragionevolmente ingiustificata una
pronuncia di estinzione del reato non preceduta da un’approfondita valutatone
circa l’effettivo fondamento del gravame. Poteva, allora, dirsi che, in
presenza del sopravvenuto maturare della prescrizione del reato, lo stesso
pronunciamento impugnato giustificasse, di per se, l’applicazione del criterio
secondo cui, in presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento
nel merito, ai sensi dell’art. 129, 2 comma, c.p.p. si impone solo se sussista
l’evidenza della prova di innocenza dell’imputato alla quale è equiparata la
mancanza totale della prova di responsabilità, mentre non trova applicazione
l’ulteriore equiparazione in concreto tra mancanza totale e insufficienza o
contraddittorietà della motivazione di cui all’art. 530, 2 comma, c.p.p. quando
sussista un concorso processuale di cause di proscioglimento, poiché altrimenti
verrebbe a vanificarsi il criterio della "evidenza" posto dal
legislatore per risolvere il predetto concorso (cfr, fra altre analoghe, Cass.
sez. DI, 24.4.2002 n. 20807, Artico).
D’altra parte, secondo la Corte
territoriale, la profonda revisione della ricostruzione dei fatti da essa
operata rispetto a quella preferita dai primi giudici aveva modificato
radicalmente, e in senso nettamente sfavorevole all’imputato, il quadro
probatorio che aveva dato luogo al (dubitativo) verdetto assolutorio, sicché la
stessa revisione doveva ritenersi, di per se, sufficiente a giustificare una
rinnovata, integrale valutazione degli elementi acquisiti, alla quale non poteva
rimanere estranea la previa verifica dell’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. e,
dunque, dell’eventuale ricorrenza di una causa estintiva del reato.
E, in effetti, siccome emerge
dalia narrazione che precede, la Corte palermitana ha ritenuto provato che il
sen. Andreotti avesse avuto piena consapevolezza che i suoi sodali siciliani
intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi; che avesse, quindi,
a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss; che avesse
loro palesato una disponibilità, non meramente fittizia, ancorché non
necessariamente seguita da concreti, consistenti interventi agevolativi; che
avesse loro chiesto favori; che li avesse incontrati; che avesse interagito con
essi; che avesse loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla
delicatissima questione Mattarella, sia pure senza riuscire, in definitiva, ad
ottenere che le sue indicazioni venissero seguite; che li avesse indotti a
fidarsi di lui e a parlargli anche di fatti gravissimi (come appunto l’assassinio
del Presidente Mattarella), nella sicura consapevolezza di non correre il
rischio di essere denunciati; che avesse omesso di denunciare le loro
responsabilità, in particolare in relazione all’omicidio del presidente
Mattarella, malgrado potesse, al riguardo, offrire utilissimi elementi di
conoscenza.
La stessa ha interpretato detti
fatti non come semplice manifestazione di un comportamento solo moralmente
scorretto e di una vicinanza penalmente irrilevante, ritenendoli invece
indicativi di vera e propria partecipazione all’associazione mafiosa,
apprezzabilmente protrattasi nei tempo.
Ha anche evidenziato che, nel
periodo antecedente al 1980, erano ancora agli albori l’attacco violento ai
rappresentanti delle istituzioni e il ricorso ai metodi sanguinati che, in
seguito, avrebbero allontanato l’imputato dai mafiosi con i quali aveva fino ad
allora coltivato amichevoli relazioni, non ostacolate da tale insuperabile
pregiudiziale ideologica; che non era ancora emersa in termini chiari la
fallacità del comune convincimento circa la determinante forza elettorale di
Cosa Nostra, che aveva indotto Bontate ad ammonire il suo illustre
interlocutore circa la necessità di conservare il favore. della mafia e che
poteva astrattamente indurre a coltivare buone relazioni con i mafiosi; che non
vi era traccia, nell’attività politico-istituzionale di Andreotti, di un
impegno antimafia che potesse giustificare il convincimento che l’amicizia
palesata ai mafiosi fosse soltanto simulata (era emblematica la vicenda Mattarella
in cui l’imputato non si era mosso secondo logiche istituzionali, ma aveva
cercato di assumere il controllo della situazione dialogando con i mafiosi).
Quindi ha rimarcato che la
manifestazione di amichevole disponibilità verso i mafiosi, proveniente da una
personalità politica cosi eminente e cosi influente, non poteva, di per se, non
implicare la consapevole adduzione all’associazione di un rilevante contributo
rafforzativo.
Lo dimostravano, la
"prosopopea", fastidiosa per i suoi avversali, mostrata da Bontate
nel parlare delle sue amichevoli relazioni con l’imputato, segno inequivoco del
fatto che il capomafia riteneva di trarne forza e prestigio; l’opinione, non
importa se giustificata o meno, che inevitabilmente si era diffusa fra gli
"uomini d’onore", secondo cui l’amicizia di Andreotti assicurava al
sodalizio una protezione al massimo livello politico, tradotta in una
sostanziale "impunità"; il sentimento della forza della
organizzazione indotto in Giovanni Brusca dalla notizia dell’intervento
dell’imputato nel processo Rimi; il valore sintomatico della vicenda
Mattarella, essendo condivisibile il rilievo che i mafiosi si erano determinati
ad alzare il tiro su un cosi eminente esponente del partito di maggioranza
relativa anche perché supponevano di non incorrere in conseguenze
pregiudizievoli in quanto contavano sull’appoggio di ancora più importanti
personaggi politici.
In definitiva, la Corte di
Appello ha ritenuto ravvisabile ti reato di partecipazione all’associazione per
delinquere nella condotta di Andreotti, trattandosi di un eminentissimo
personaggio politico nazionale, di spiccatissima influenza nella politica
generale del Paese ed estraneo all’ambiente siciliano, il quale, nell’arco di
un congruo lasso di tempo, anche al di fuori di una esplicitata negoziazione di
appoggi elettorali in cambio di propri interventi in favore di
un’organizzazione mafiosa di rilevantissimo radicamento territoriale
nell’Isola; a) aveva chiesto e ottenuto, per conto di suoi sodali, ad esponenti
di spicco della associazione interventi para-legali, ancorché per finalità non
riprovevoli; b) aveva incontrato ripetutamele esponenti di vertice della stessa
associazione; c) aveva intrattenuto con essi relazioni amichevoli,
rafforzandone l’influenza anche rispetto ad altre componenti dello stesso
sodalizio tagliate fuori da tali rapporti; d) aveva palesato autentico
interessamento in relazione a vicende particolarmente delicate per la vita del
sodalizio mafioso; e) aveva indicato ai mafiosi, in relazione a tali vicende,
le strade da seguire e discusso con i medesimi anche di fatti criminali
gravissimi da loro perpetrati in connessione con le medesime vicende, senza
destare in essi la preoccupazione di venire denunciati; f) aveva omesso di
denunciare elementi utili a far luce su fatti di particolarissima gravita, di
cui era venuto a conoscenza in dipendenza di diretti contatti con i mafiosi; g)
aveva dato, in buona sostanza, a detti esponenti mafiosi segni autentici – e
non meramente fittizi – di amichevole disponibilità, idonei, anche al di fuori
della messa in atto di specifici ed effettivi interventi agevolativi, a
contribuire al rafforzamento della organizzazione criminale, inducendo negli
affiliati, anche per la sua autorevolezza politica, il sentimento di essere protetti
al più alto livello del potere legale.
8 – Il ricorso della Procura
Generale
Riepilogata brevemente la
sentenza impugnata e ricordato che essa aveva ritenuto il reato di associazione
per delinquere commesso sino alla primavera del 1980 ma estinto per
prescrizione, mentre aveva confermato per il periodo successivo la statuizione
assolutoria del Tribunale, la Procura Generale presso la Corte di Appello di
Palermo l’ha stigmatizzata sotto il duplice profilo dell’erronea applicazione
della legge penale sostanziale e processuale (con particolare riferimento agli
artt 416, 416 bis, 157 c.p. e art. 192, comma 2 c.p.p.) e del vizio di
motivazione.
La Procura Generale ricorrente ha
rilevato che era stato riconosciuto valore sintomatico, ai fini dell’accertamento
del reato associativo, a taluni episodi e rapporti risultanti fino alla
primavera del 1980, mentre i fatti successivi erano stati ritenuti non
congruamente dimostrati o privi di valenza significativa. Sennonché la sentenza
impugnata non si era limitata ad apprezzare tali fatti per verificare la
sussistenza di ulteriori manifestazioni indicative di partecipazione al
sodalizio, ma aveva utilizzato il dato probatorio negativo per inferirne la
cessazione della permanenza del reato associativo, cioè la prova del recesso
volontario da sodalizio, senza considerare che esso deve risultare non
dall’assenza di ulteriori comportamenti adesivi al sodalizio, ma da coerenti e
inequivocabili segni di ravvedimento incompatibili con la volontà di perpetuare
il legame con l’organismo criminale.
In particolare, l’unico elemento
in tal senso individuato dalla Corte di Appello sembrava essere l’impegno
antimafia iniziato con i provvedimenti riferibili al Gabinetto presieduto da
Giulio Andreotti, culminati con l’incisiva normativa repressiva del 1991.
Ma, relativamente al periodo
compreso tra il secondo incontro con Bontate e gli ultimi anni ’80, la Corte
territoriale non aveva accertato l’esistenza di segnali di recesso di segno
contrario rispetto all’adesione, ma si era limitata a considerare i fatti
successivi potenzialmente rivelatori di "affectio" per concludere che
essi non erano sufficientemente dimostrativi e traendone irrazionalmente il
convincimento della cessazione della permanenza.
La Procura Generale ha criticato
anche l’interpretazione data dalla sentenza impugnata agli artt. 416 e 416 bis
c.p,. In particolare ha contestato la contrapposizione dell’ipotesi di
acquisizione dello status di "uomo d’onore" attraverso la formale
affiliazione a quelle di realizzazione della condotta tipica, impropriamente
indicate come di "concorso nel reato associativo", che prescindono
dall’inserimento formale, ma in realtà sono riferite alla condotta del
partecipe (consapevole cooperazione continuativa) e a quella del concorrente
esterno (singoli contributi concreti tali da arrecare un apporto essenziale
alla vita dell’organizzazione per il superamento di suoi momenti di particolare
difficoltà).
Secondo la ricorrente, da questa
erronea accomunatone dell’ipotesi del partecipe non ritualmente affiliato e del
concorrente esterno la Corte di Appello aveva fatto discendere conseguenze
rilevanti e non condivisibili, avendo ritenuto che l’affiliazione formale
determini la tendenziale perpetuità del vincolo associativo e che invece nelle
altre due ipotesi considerate la condotta associativa sia ravvisarle solo fino
a quando gli apporti vengano arrecati o fino a quando persista la
disponibilità.
Ma poi, nel valutare la condotta
dell’imputato, la Corte, dovendo tenere realisticamente conto della sua
particolare posizione nell’ambito del potere legale, aveva ritenuto sufficiente
la semplice consapevolezza, da parte dei membri della organizzazione mafiosa,
della sua disponibilità, idonea a rafforzare il sodalizio, giustificando negli
affiliati il convincimento di essere protetti al più alto livello, con la
conseguenza, sul piano giuridico, che la stessa perdurante disponibilità può
costituire, di per se, un notevole e continuativo contributo all’associazione
criminale.
Cosi la Corte territoriale,
nell’affermare la sussistenza del reato associativo, aveva valutato non
determinante il deficit probatorio in ordine a specifici e concreti interventi
agevolativi degli interessi dell’associazione mafiosa da parte dell’imputato,
essendo sufficiente la consapevole instaurazione, non senza personale
tornaconto, di una relazione stabile con il sodalizio e l’apprestamento di un
contributo rafforzativo attraverso la manifestazione di disponibilità verso i
mafiosi (in definitiva, nel delineare le due ipotesi di "partecipazione
non formale", ha considerato elemento caratterizzante di entrambe la
prestazione di un apporto concreto il cui reiterarsi vale a condizionare la
permanenza del reato).
Ma poi aveva finito per
distinguere, sul piano ontologico e probatorio, le due ipotesi di
partecipazione non formale attribuendo rilievo alla disponibilità, considerata
di per se contributo rafforzativo e quindi aveva escluso che potesse avere
valore determinante la mancata dimostrazione di specifici e concreti interventi
agevolativi a favore del sodalizio.
La ricorrente ha ritenuto
quest’ultima scelta sicuramente condivisibile, ma non altrettanto
l’assimilazione delle due figure del "partecipe non formalmente
aggregato" e la contrapposizione di entrambe a quella del soggetto
affiliato quanto alla durata del vincolo e alla prova della permanenza,
rilevando che, ritenere che in questi due casi la condotta tipica sia definita
dai singoli apporti concreti e che la permanenza del reato possa dirsi cessata
in mancanza di prova di ulteriori apporti o manifestazioni di disponibilità,
contrasta con l’affermazione della stessa Corte secondo cui tra le ipotesi
riconducibili alla partecipazione del non affiliato nella forma della
cooperazione continuativa rientrano i casi assimilabili alla partecipazione
dell’affiliato.
Secondo la ricorrente, la
categoria della "partecipazione non formale" si attaglia non solo
alle ipotesi di concorso esterno, ma anche a tutti i casi di soggetti il cui
inserimento a pieno titolo nell’organizzazione risulti dallo stabile impiego in
attività delittuose caratterizzate dal metodo mafioso o comunque funzionali al
mantenimento e al rafforzamento del sodalizio criminale. Altrimenti si
perverrebbe alla conseguenza aberrante di dover provare la perdurante adesione
con la dimostrazione dei singoli apporti.
Inoltre la ricorrente ha assunto
che tale criterio non è coerente neppure con l’affermazione, secondo cui nello
schema del partecipe non affiliato, rientrano anche i legami in cui l’agente
abbia deliberatamente e consapevolmente prestato al sodalizio mafioso un
contributo non episodico, ma di apprezzabile continuità e stabilità, tale da
rivelare la coscienza e volontà di aderire alla associamone criminale, dal
momento che la stessa Corte d’Appello aveva finito con accedere alla tesi
secondo cui, in questi casi, ai fini della partecipatone è sufficiente la
manifestazione di disponibilità.
La ricorrente ha concluso, sul
punto, che se partecipazione vi era stata – come ritenuto dalla Corte
territoriale fino al 1980 – la sua scelta interpretativa era in contrasto con
l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tale ipotesi, il vincolo
associativo si instaura nella prospettiva di una permanenza a tempo
indeterminato nell’associazione criminale e si protrae fin quando non si
verifichi, attraverso elementi indiziari certi, una condotta esplicita, univoca
e coerente che esprima la volontà di recedere dal sodalizio. La Procura
Generale ricorrente ha ritenuto il convincimento della Corte territoriale
viziato anche sotto il profilo motivazionale riguardo al radicale ripensamento
dei rapporti, fino allora mantenuti, che sarebbe intervenuto nell’imputato a
seguito degli avvenimenti culminati con l’incontro a Palermo con Stefano
Bontate nella primavera del 1980.
In proposito ha rilevato che la
sentenza, pur avendo riconosciuto che l’episodio confermava il legame stabile
instaurato dal sen Andreotti attraverso l’on. Lima e i cugini Salvo con l’ala
moderata di Cosa Nostra, al tempo stesso aveva sostenuto che tale episodio ne
segnava anche la crisi e costituiva l’elemento rivelatore del declino delle
relazioni dell’imputato con il sodalizio.
La sentenza impugnata aveva
ritenuto che Andreotti si fosse determinato all’incontro per ottenere
chiarimenti sull’omicidio Mattarella, seguito al fallimento del suo tentativo
di composizione attraverso la mediazione politica e che l’esito sconfortante
dell’incontro avesse fatto maturare la definitiva consapevolezza della
pericolosità (ma la stessa Corte aveva poi fatto riferimento ai gravissimi
fatti di sangue del 1979, pienamente dimostrativi al riguardo), fino a quel
momento sottovalutata, dell’organizzazione. Un tale ragionamento è, secondo la
ricorrente, meramente congetturale (lo aveva riconosciuto la stessa Corte),
svincolato dalle risultanze processuali, puramente assertivo e tal ora
illogico, fondato su un’unica fonte probatoria, Marino Mannoia, il quale invece
si era limitato a riferire sull’iniziativa dell’imputato perché si svolgesse
l’incontro senza nulla dire in ordine all’asserito cambiamento di rotta.
L’altro elemento considerato
dalla Corte di Appello come dimostrativo del definitivo logoramento dei
rapporti dell’imputato con Cosa Nostra (il mutato assetto degli equilibri in
seno all’organizzazione passata sotto il controllo dei "corieonesi"
di Riina) si era risolto in un inammissibile salto logico laddove, a fronte di
un quadro di riferimento sostanzialmente immutato (le perduranti relazioni con
Lima e i Salvo e il ruolo di referenti politici della mafia che costoro avevano
continuato a svolgere), era stato attribuito peso determinante al mutato
assetto di potere interno all’organizzazione, senza considerare che la prova
del recesso non poteva prescindere dalla dimostrazione della interruzione, o
almeno diversificazione, di quei legami.
La ricorrente ha osservato che la
sentenza impugnata aveva ritenuto cessata la perdurante disponibilità mediata
dai referenti politici siciliani come presupposto dimostrato, mentre invece era
il fatto da dimostrare. Cosi quando aveva sostenuto che l’imputato potesse non
avere avuto consapevolezza delle relazioni di Lima con i nuovi padroni di Cosa
Nostra o aveva ipotizzato che i cugini Salvo (il solo Ignazio dopo la morte di
Nino) avessero potuto fornire all’ala emergente del sodalizio criminoso
generiche assicurazioni che non avevano trovato rispondenza in un effettivo
atteggiamento di disponibilità dell’imputato (ipotesi dirette, nella
prospettazione della Corte, ad annullare la portata dimostrativa degli
accertati rapporti di Andreotti con costoro e la perdurante disponibilità nei
confronti di Cosa Nostra), la sentenza impugnata aveva accolto mere congetture
con un ragionamento erroneo in diritto e contraddittorio sul piano logico in
presenza di apporti che la stessa Corte aveva ritenuto dimostrativi del
perdurare di tali legami oltre la primavera del 1980 e di risultanze che
avevano disegnato un quadro di rapporti immutato anche dopo l’avvento dei
"corleonesi".
Pertanto la Corte territoriale
aveva valorizzato un asserito vuoto probatorio trasformandolo in prova positiva
del recesso e inoltre aveva omesso la valutatone complessiva delle risultanze
processuali, vantazione doverosa in materia di prova indiziaria.
In tale quadro, è stata criticata
anche l’esclusione della valenza probatoria di fatti pur considerati dalla
stessa Corte, che però ne aveva ritenuto carente la prova certa della
riconducibilità all’imputato o della consapevolezza del medesimo
dell’estrazione mafiosa dei soggetti con i quali aveva interagito.
I riferimenti concreti attengono
agli episodi riferiti da Giovanni Brusca e Antonino Giuffré, i quali avevano
indicato ancora negli anni 1981 e 1982 -1983 Nino Salvo come il tramite tra
l’imputato e Cosa Nostra; alla telefonata, effettuata all’Ospedale di Palermo
nel settembre 1983, per assumere informazioni
sulla salute di Giuseppe Cambria, prossimo congiunto dei Salvo; al
trasferimento, nel 1984, di detenuti mafiosi dal carcere di Pianosa a quello di
Novara, particolarmente significativo perché dimostrava che, ancora all’epoca,
Cosa Nostra e, in particolare, Leoluca Bagarella, esponente di rilievo dello
schieramento emergente, riponevano concrete aspettative nel legame con
l’imputato; all’incontro, avvenuto nel dicembre (rectius: agosto) 1985, con il
boss emergente Andrea Manciaracina, uomo di fiducia di Riina; ai contatti,
anche diretti e talora negati, con Vito Ciancimino, protrattisi fino al 1983;
alle vicende concernenti il maxiprocesso; alla perdurante convinzione, anche in
seno al nuovo schieramento di Cosa Nostra, di poter contare sull’aiuto del sen.
Andreotti attraverso i tradizionali referenti politici dell’organizzazione;
alle vicende relative alle elezioni regionali del 1991 e ai candidati della
corrente Andreottiana Bevilacqua e Giammarinaro, sostenuti da Lima e osteggiati
dalla Direzione Nazionale del partito per la loro contiguità a Cosa Nostra,
episodi che, se non erano inequivocamente sintomatici della continuità delle
relazioni dell’imputato con la mafia, certamente non erano neppure rivelatori
del recesso e dimostravano che, anche per il periodo in esame, non vi era vuoto
probatorio, ma consistente quadro indiziario, soprattutto in considerazione
dell’atteggi amento dell’imputato, in diversi casi ispirato al mendacio.
A parere della ricorrente, la
sentenza impugnata non aveva compiuto la necessaria vantazione globale delle
emergenze probatorie e invece aveva insistito nella frammentazione della
condotta tipica del reato associativo, che pure era stata oggetto di specifica
doglianza nei confronti della sentenza di primo grado.
Gli asseriti vizi avevano avuto
effetto nella valutatone di rilevanza e concludenza degli elementi indizianti
ai fini della "affectio societatis" che caratterizza l’elemento
psicologico del reato di associazione mafiosa, mentre invece l’indagine sul
dolo andava compiuta su tutti i frammenti della fattispecie complessivamente
considerata e non su ciascuno dei facta concludenti per evitare di chiedere una
vera e propria "probatio diabolica". Pertanto la sentenza impugnata
avrebbe dovuto esaminare le dette risultanze in relazione e in rapporto di
reciproca interferenza anche con i fatti ritenuti dimostrativi di
"affectio" fino al 1980, invece di richiedere, ai fini
dell’accertamento della permanenza, una prova autonoma e autosufficiente, libera
dalla dovuta considerazione delle vicende precedenti e dalla conservazione da
parte dell’imputato di rapporti amichevoli e di solidarietà politica con L’on.
Lima e di relazioni amichevoli con i cugini Salvo.
Secondo la ricorrente, la
sentenza impugnata era pervenuta a tale erronea statuizione perché non aveva
applicato correttamente i criteri di valutatone applicabili nei casi in cui, in
relazione all’esistenza di elementi idonei ad esprimere la partecipazione ad
un’associazione di tipo mafioso, riferibili ad epoca antecedente e successiva
all’entrata in vigore della legge n. 646/82, vengono contestati i reati di cui
agli artt. 416 e 416 bis c.p., casi in cui il primo, essendo reato meno grave,
viene assorbito nella nuova fattispecie che assume il carattere di reato
progressivo permanente e il momento perfezionativo del nuovo delitto coincide
con l’entrata in vigore della nuova e più severa normativa, mentre quello
consumativo si verifica solo all’atto del recesso volontario del partecipe
all’associazione.
Da ciò la ricorrente ha tratto la
conclusione che gli ulteriori elementi, emersi successivamente all’entrata in
vigore della nuova normativa, dovessero essere valutati in correlazione logica
e giuridica con la precedente situazione di fatto, per cui il giudice d’appello
avrebbe dovuto valutare se essi deponessero nel senso della perdurante
partecipazione dell’imputato o nel senso di un suo recesso dall’associazione.
9 – Il ricorso dell’imputato.
Il ricorso della difesa
dell’imputato è articolato in sette motivi.
1) – Con il primo ha eccepito
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale (artt. 416
e 416 bis c.p.p.) e processuale (artt. 187 e 192 c.p.p.) e manifesta illogicità
della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata.
In particolare, il ricorrente ha
censurato la definizione teorica dei reati contestati, come ritenuta dal
giudice di appello, di cui ha ricapitolato gli assunti in diritto da questo
espressi.
La prima possibile forma di
partecipazione all’associazione – affiliazione a Cosa Nostra organica e rituale
– era stata categoricamente esclusa nei confronti dell’imputato, che, quindi,
non aveva mai rivestito la qualità di uomo d’onore secondo la definizione della
Corte territoriale. Lo aveva confermato proprio un episodio su cui questa si
era soffermata: Cosa Nostra non considerava il sen. Andreotti tra i suoi
affiliati tanto è vero che non lo aveva reso partecipe della decisione di
uccidere Mattarella (vedi l’incontro -scontro con Bontate, che peraltro l’imputato
nega essere mai avvenuto). La Corte territoriale ha ritenuto configurabili due
forme di partecipazione non formale al sodalizio, realizzate attraverso
comportamenti che non concretizzano una vera e propria affiliazione.
La prima di esse esige un’attività
di cooperazione continuativa con il sodalizio criminale e – sul piano
sostanziale – si risolve in una vera e propria adesione del soggetto al
sodalizio con la consapevolezza degli affiliati di poter contare sul suo
apporto. Si tratta, in definitiva, di una sorta di tirocinio cui viene
assoggettato chi aspira a divenire uomo d’onore, situazione esclusa dalla
sentenza per quanto riguarda la posizione dell’imputato.
La Corte d’Appello ha inserito in
tale ambito una forma subordinata di partecipazione a Cosa Nostra
caratterizzata dal fatto che l’agente presta al sodalizio mafioso, inteso nel
suo complesso, deliberatamente e consapevolmente un contributo (concetto
certamente ambiguo) non episodico, ma di apprezzabile continuità e stabilità,
in tal modo rivelando coscienza e volontà di aderirvi.
Sempre secondo la Corte
territoriale, l’altra forma si realizza attraverso singoli e concreti
contributi all’associazione mafiosa, posti in essere in momenti di sua
particolare difficoltà allo scopo di consentirle di superarli.
Ma neppure questo schema astratto
era attinente al caso concreto perché essa non aveva addebitato al sen.
Andreotti nessun atto specifico e concreto realizzato in favore di Cosa Nostra,
ma si era limitata a rilevarne soltanto una mera disponibilità.
Il ricorrente ha concluso sul
punto che, secondo la stessa sentenza impugnata, ai fini dell’affermazione
della responsabilità penale non basta la disponibilità, ma sono comunque
necessari concreti apporti per la sussistenza di una condotta penalmente
tipica; d’altra parte detti apporti sono la prova della partecipazione.
Ma poi, passando all’esame del
caso concreto, essa era precipitata in una serie di contraddizioni e di errori,
soprattutto quando si era posta il problema di accertare se, nella peculiarità
del caso Andreotti (un uomo che era stato protagonista di primo piano per
lunghi decenni della storia italiana ), la stabile partecipazione a Cosa Nostra
potesse essere radicata nella prova di una semplice, continuativa
disponibilità, anche in assenza della dimostrazione piena e concreta di
singoli, specifici apporti.
Errata in diritto, questa
impostazione, secondo il ricorrente, era risultata inconferente ai fini
dell’affermazione di responsabilità anche sotto il profilo probatorio, atteso
che, tenuto conto del dettato dell’art, 192, comma 2 c.p.p., la sentenza
avrebbe dovuto chiarire i percorsi probatori idonei a dimostrare la semplice,
continuativa disponibilità diversi da quelli legati alla ricerca di concreti e
specifici apporti al sodalizio criminoso (la stessa sentenza aveva escluso che
semplici relazioni o frequentazioni con mafiosi fossero al riguardo
sufficienti).
Il ricorrente ha assunto che il
ragionamento della Corte aveva violato i principi della tipicità della condotta
costitutiva del delitto associativo e della tassatività e determinatezza della
fattispecie legale, essendo pervenuta alla conclusione che anche una condotta
intrinsecamente equivoca, quindi non qualificabile in se come partecipazione,
possa essere considerata penalmente rilevante.
A suo dire, a causa di questo
errore, la Corte aveva dimenticato che il primo controllo avrebbe dovuto
riguardare la conformità, sul piano materiale, della condotta concreta a quella
astrattamente descritta dalla norma.
Quanto all’elemento psicologico,
il ricorrente ha rilevato che la relativa prova scaturisce dalle
caratteristiche della condotta concreta, che deve essere tale da provare che il
soggetto abbia agito assistito dalla consapevolezza e volontà di interagire con
l’associazione mafiosa, prova che, quindi, non può essere desunta da una
condotta intrinsecamente equivoca.
2) – Con il secondo motivo il
ricorrente ha censurato la sentenza impugnata sotto il duplice profilo
dell’erronea applicazione della legge penale e della mancanza e illogicità
della motivazione.
Ha premesso che la disponibilità
(stabile e continuativa) implica inevitabilmente la volontà di far parte
dell’associazione (come riconosciuto dalla giurisprudenza) e non può consistere
in un semplice stato d’animo, per cui la relativa prova non può prescindere
dall’analisi del comportamento del soggetto, il quale deve avere prestato una
adesione dichiarata all’associazione mafiosa o una concreta attività
collaborativa idonea a contribuirne al potenziamento, consolidamento o mantenimento.
In ogni caso occorre dimostrare almeno che il soggetto abbia piena
consapevolezza delle caratteristiche dell’associazione mafiosa.
Invece dalla stessa sentenza
impugnata era risultata l’assenza di prove del compimento da parte
dell’imputato di attività concrete in favore di Cosa Nostra. Anzi, dalla sua
motivazione, era emerso che Andreotti aveva rifiutato i metodi tipici
dell’agire mafioso, che non vi erano elementi che consentissero di affermare
che sarebbe stato sollecitato dai mafiosi; che si era ignorato cosa avrebbe
fatto in loro favore; che tutto era restato affidato a voci correnti in Cosa
Nostra.
Conclusivamente sul punto, dalla
sentenza era risultato che l’imputato, fino alla primavera del 1980, aveva
coltivato relazioni amichevoli con i cugini Salvo e con i vertici della fazione
moderata di Cosa Nostra. Ciò aveva indotto la Corte a pensare che in tal modo
fosse divenuto per essi un riferimento, che essi contassero sulla sua amicizia
e che da essa traessero prestigio interno, ma senza che ciò implicasse
necessariamente che la sua amichevole disponibilità avesse dato luogo
automaticamente al coinvolgimento di Andreotti in affari la cui soluzione
premesse ai mafiosi, a loro volta pronti a soddisfare ogni sua esigenza per
conquistarsene la benevolenza.
Quindi il ricorrente ha passato
in rassegna alcuni episodi che la Corte territoriale aveva considerato
dimostrativi della disponibilità idonea a costituire la ritenuta adesione a
Cosa Nostra.
Il primo riferimento è stato per
l’affermato dalla sentenza, ma negato dall’imputato, duplice incontro (prima
dell’omicidio di Mattarella per contrastare il progetto mafioso e dopo per
esprimere contrarietà e irritazione, divenendo poi irriducibile avversario di
Cosa Nostra) con Bontate e altri boss mafiosi.
La stessa sentenza aveva
riconosciuto che Andreotti non aveva mai accettato, anzi, aveva contrastato il
metodo mafioso di eliminare i propri avversari, affermazione razionalmente
inconciliabile con la ritenuta disponibilità e che aveva escluso consapevolezza
e volontà di partecipare all’associazione.
Considerazioni analoghe valevano
– ha sostenuto il ricorrente – con riferimento alla vicenda Sindona, a favore
del quale l’ipotesi accusatoria aveva affermato che Andreotti era intervenuto
su richiesta di Cosa Nostra, circostanza negata dalla Corte di Appello, secondo
cui la conclusione positiva stava a cuore a Bontate e agli altri esponenti di
Cosa Nostra che avevano investito denaro nelle banche di Sindona, ma Andreotti
non aveva avuto alcuna richiesta da parte di costoro e si era limitato ad
interessarsi senza svolgere alcun intervento concreto.
Tale comportamento, ancora una
volta, aveva escluso che vi fosse concreta disponibilità dell’imputato nei
confronti del sodalizio mafioso.
Quanto ai benefici che il sen.
Andreotti avrebbe tratto o comunque sperato di trarre dalle amichevoli
relazioni con Cosa Nostra, il ricorrente ha sottolineato che la stessa Corte
territoriale aveva concluso, sul piano generale, che alla stregua di alcune,
pregnanti indicazioni raccolte, appare piuttosto frutto di un luogo comune
l’attribuzione a Cosa Nostra di un determinato peso nell’orientamento del voto
e, in particolare, che è difficile affermare che l’appoggio elettorale
(peraltro neppure esclusivo) accordato da esponenti di Cosa Nostra alla
corrente andreottiana fosse il risultato (in qualche modo negoziato) degli
amichevoli rapporti dei vertici mafiosi con l’imputato e non piuttosto il
naturale portato dei legami intrattenuti a livello locale dal Lima,
innanzitutto, e dai singoli soggetti di volta in volta candidati nei vari
collegi o circoscrizioni.
Del resto, la stessa sentenza
impugnata, in armonia con la Storia, aveva escluso che Andreotti, il quale già
in precedenza aveva ricoperto incarichi di grande prestigio, fosse divenuto una
stella di prima grandezza nel firmamento politico italiano soltanto dopo
l’approdo di Lima nella sua corrente.
3) – Con il terzo motivo il
ricorrente ha censurato l’affermata erronea applicazione dell’art. 530 c.p.p.,
rettificabile ai sensi del successivo art. 619.
Riformando la decisione del
Tribunale, la sentenza impugnata aveva prosciolto per prescrizione Andreotti
dalla violazione dell’art. 416 c.p. protrattasi fino al 1980, avendo ritenuto
la sua partecipazione a Cosa Nostra, mentre, perii periodo a partire dalla
primavera del 1980 (quindi anche per un periodo riconducibile esclusivamente
all’operatività dell’art. 416 c.p.), aveva affermato che l’imputato aveva
condotto una strenua battaglia contro la mafia, esponendosi anche a rischio di
vita.
Pertanto, anziché limitarsi a
confermare, relativamente a tale periodo, la sentenza di primo grado,
assolutoria ai sensi del comma 2 dell’art. 530 c.p.p., la Corte territoriale
avrebbe dovuto riformarla applicando il comma 1 del medesimo articolo.
4) – Con il quarto motivo il
ricorrente ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche
e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione,
sostenendo la tesi che il fatto non sussiste anche per il periodo anteriore
alla primavera del 1980.
In proposito egli ha rilevato
che, assolto in primo grado perché il fatto non sussiste, aveva sottoposto
all’esame del giudice di appello una corposa memoria di cui quest’ultimo
sostanzialmente non aveva dato conto nello svolgimento del processo e che non
aveva considerato ai fini della decisione, cosi incorrendo nel palese vino di
omessa motivazione (vedi, in proposito, la migliore dottrina e la stessa
interpretazione giurisprudenziale), dovendosi condividere l’affermatone che un
controllo sulla motivazione della sentenza ha senso, in quanto attraverso la
sentenza si controlla il processo. E perché questo avvenga è necessario che la
sentenza rifletta i risultati del processo.
Ciò, per evidenti ragioni, vale a
priori quando l’imputato, assolto in primo grado, sia invece ritenuto colpevole
dal giudice di appello.
A questo punto l’analisi del
ricorrente si è soffermata sull’episodio che la sentenza impugnata aveva
ritenuto effettivamente accaduto e che, nella sua motivazione, aveva assunto
particolare rilievo: il preteso incontro con Bontate che sarebbe avvenuto nella
primavera del 1980, dopo l’omicidio di Mattarella, strettamente collegato ad
altro incontro, avvenuto precedentemente, per discutere del mutato
atteggiamento del medesimo Mattarella nei confronti della mafia, connessione
puntualmente rilevata dal primo giudice, che però aveva escluso l’incontro.
Invece la sentenza impugnata
aveva rotto il collegamento tra i due episodi, aveva dato per scontata la
credibilità di Marino Mannoia, che pure aveva riferito del primo solo "de
relato", aveva irrazionalmente ritenuto la prova del medesimo non
fondamentale, poi aveva creduto alla supposizione che il verificarsi del
secondo incontro accreditasse anche la sussistenza del primo e, cosi, aveva
finito per recuperare la credibilità di Mannoia anche con riferimento ad esso.
Il ricorrente ha, quindi,
ripercorso la ricostruzione probatoria della vicenda per concludere che le
emergenze processuali (come evidenziato da sentenza di primo grado e difesa)
avevano escluso che il suddetto primo incontro potesse esservi stato, essendo
risultato che, giorno dopo giorno, il sen. Andreotti era stato in tutt’altre
faccende e in tutt’altri luoghi affaccendato e dovendosi escludere – alla luce
delle stesse emergenze processuali – che il medesimo avesse potuto, all’epoca,
compiere viaggi in Sicilia segreti e senza lasciare alcuna traccia.
Del resto, per affermare il
contrario, la sentenza impugnata aveva fatto leva sull’argomento della
compatibilita, come se la compatibilità di un accadimelo con altro accadi mento
o altre situazioni valesse come vero e proprio riscontro del fatto da provare;
aveva svalutato l’assenza di qualsiasi traccia di viaggi di Andreotti in
Sicilia; aveva giustificato – con argomentazioni cui si potevano agevolmente
contrapporre altre anche più razionali di segno contrario • la tardività del
ricordo di Marino Mannoia; aveva disinvoltamente superato il problema
concernente la scorta di cui l’imputato era stabilmente dotato; aveva dato
credito alle dichiarazioni – delle quali egli ha argomentato l’asserita falsità
– di Angelo Siino, peraltro forzandole circa l’epoca in cui sarebbe avvenuto
l’episodio, e le aveva erroneamente ritenute valido riscontro a quelle di
Mannoia.
Particolare disamina il
ricorrente ha riservato allo slittamento dell’incontro verso l’autunno 1979
proposto dalla Procura Generale (e non accolto neppure dalla sentenza
impugnata), per sottrarre il racconto di Siino a critiche demolitrici e per
vanificare lo sforzo compiuto, nei giudizio di primo grado, per verificare se
esso potesse essere avvenuto tra il 15 giugno e il 17 luglio 1979, allo scopo
di ricavarne la conferma della falsità del collaboratore, le cui dichiarazioni,
invece, erano state ritenute credibili dalla Corte di Appello con
argomentazioni palesemente irrazionali e talvolta addirittura acrobatiche
(come, ad esempio, la giustificazione dell’asserita originaria dimenticanza
dell’episodio e della ritenuta errata collocazione temporale dell’incontro).
In ogni caso, a decisiva
dimostrazione della irrazionalità ed erroneità della sentenza impugnata, il
ricorrente ha posto la constatazione che essa aveva fissato la data
dell’incontro in modo assolutamente ipotetico, arbitrario e in contrasto, ad
esempio, con le annotazioni contenute nell’agenda e nel diario, redatti in
epoca non sospetta, di esso imputato, la cui richiesta di produrre ulteriore
documentazione dimostrativa era stata respinta.
Analoga illogicità il ricorrente
ha ravvisato nel preteso secondo incontro tra Andreotti e Bontate, incontro che
ha definito privo di senso, stante l’indissolubile connessione con il primo,
che egli riteneva avere dimostrato non essere in realtà avvenuto.
A tale proposito, ha sostenuto
l’erroneità giuridica e l’implausibilità logica di ritenere l’episodio provato
alla stregua delle indicazioni fomite dalla sola, specifica fonte costituita
dal collaboratore Francesco Marino Mannoia, senza considerare che costui era
imputato di reato connesso, con la conseguenza che le sue dichiarazioni
sottostavano alla disciplina dell’art. 192, comma 3, c.p.p. e da sole non
potevano costituire prova.
Inoltre l’intrinseca credibilità
di Mannoia era stata affermata sulla base di criteri (essere stato il primo nel
processo a parlare del sen. Andreotti, non avere intenti persecutori nei
confronti del medesimo e nessuna ragione per accusarlo falsamente, ecc.) non
persuasivi e spesso contraddetti da altri criteri richiamati in diverse
occasioni dalla stessa Corte territoriale, oltre tutto con svalutazione dei
rilievi sollevati dalla sentenza di primo grado, che invece aveva ritenuto
alcune sue dichiarazione idonee a mettere in discussione l’attendibilità del
collaborante (quali la versione sicuramente falsa offerta in un primo momento
da Mannoia sulle dichiarazioni rese al dott. Falcone, che indagava
sull’omicidio di Piersanti Mattarella, la genericità dell’indicazione circa il
periodo in cui Andreotti si sarebbe recato in Sicilia per incontrare Bontate,
l’errore di avere inserito Piersanti Mattarella nella corrente andreottiana,
ecc).
Quindi il ricorrente è passato
all’esame analitico degli elementi che la sentenza impugnata aveva ritenuti
validi riscontri delle dichiarazioni di Mannoia.
Ricordate le argomentazioni
sottoposte all’esame della Corte di Appello per dimostrare l’inattendibilità di
Antonino Giuffrè e la non veridicità delle sue affermazioni, il ricorrente ha
sottolineato che la stessa sentenza aveva riconosciuto l’assoluta genericità
del riferimento al preteso incontro, riferito doppiamente "de relato"
(il collaborante aveva riferito il racconto del boss mafioso Greco che, a sua
volta, gli aveva riferito fatti appresi da altri).
Inoltre, irrazionalmente, la
sentenza impugnata aveva dato credito alle dichiarazioni di Giuseppe Lipari in
quanto contrarie ad Andreotti, mentre aveva affermato che non sarebbero state
credibili quelle eventualmente a lui favorevoli; aveva riconosciuto che si
erano sostanziate in voci, ma le aveva credute ugualmente sul rilievo che esse
– come quelle di Giuffré – avevano trovato riscontro nelle credibili
dichiarazioni di Mannoia, che erano appunto quelle oggetto di verifica e di
controllo.
Del resto la sentenza, esaurita
la disamina delle dichiarazioni di Mannoia, aveva sviluppato considerazioni
sconcertanti sul piano logico, avendo riconosciuto insufficienti i riscontri
alle sue dichiarazioni, per poi tornare ad affermare il contrario, senza
comunque preoccuparsi di valutare l’attendibilità intrinseca delle varie
notizie (ad esempio, per verificare la veridicità del viaggio di Andreotti in
Sicilia allo scopo di incontrare Bontate: che cosa avrebbe potuto fare
l’imputato per indurre Mattarella, ormai in lotta con la mafia, a modificare la
sua linea politica?) e senza considerare che il riscontro deve consistere in un
fatto acclarato che consenta di formulare, in
termini di certezza, un giudizio intorno ad un fatto e al suo autore. Inoltre
le dichiarazioni accusatone di Marino Mannoia (e anche quelle di Angelo Siino)
erano state – secondo il ricorrente – generiche (per esempio sull’elemento
temporale) e, quindi, limitative del diritto di difesa perché il sen. Andreotti
era stato in grado si smentire qualsiasi accusa ancorata a precisi riferimenti
temporali.
Il ricorrente ha lamentato,
altresì, che la sentenza aveva ignorato le conseguenze della denunciata
vaghezza delle dichiarazioni concernenti il dato in esame e che, per superarla,
aveva fatto ricorso a viaggi fantasma, cioè a viaggi che Andreotti avrebbe
effettuato senza lasciare traccia, giustificando la mancanza di documentazione
con l’asserita incompletezza della medesima, peraltro agevolmente colmabile
perché dovuta a lacune investigative (vedi le deposizioni dell’ambasciatore
Riccardo Sessa e del colonnello Gallitelli).
Resasi conto della portata
probatoria del tema dei viaggi, la Corte territoriale aveva tentato di
minimizzarlo attribuendogli significato neutro, ma cosi si era venuta a trovare
nella necessità di riscontrare altrimenti le dichiarazioni di Mannoia e ciò
aveva fatto basandosi sulle dichiarazioni di Giuffrè, Lipari, Buscetta, Brusca
e Mammoliti, i quali non avevano neppure sfiorato il tema del presunto
incontro, ma avevano riferito episodi diversi che – a ben guardare –
addirittura avevano smentito Marino Mannoia.
L’episodio narrato da Antonino
Mammoliti – privo di qualsivoglia riscontro e non creduto dal primo giudice –
aveva riguardato il presunto intervento presso Girolamo Piromalli operato da
Bontate, su sollecitazione di Andreotti, e finalizzato a far cessare le
estorsioni in corso in Calabria in danno dell’imprenditore petrolifero laziale
Bruno Nardini.
La Corte territoriale aveva
indicato le ragioni che l’avevano indotta a ritenere necessario procedere a
indagine particolarmente penetrante e rigorosa in ordine alla credibilità di
Mammoliti, ma poi aveva tradito l’originario proposito, attribuendo
erroneamente a costui la formulazione di un’accusa esplicita nei confronti di
Andreotti, mentre invece Mammoliti non aveva mai detto che l’imputato fosse
stato edotto della situazione del Nardini e che fosse intervenuto nei confronti
di Bontate.
Inoltre, secondo il ricorrente,
la sentenza impugnata non aveva motivato la scelta di interpretare le
dichiarazioni di Mammoliti nel senso di un sicuro ruolo attivo di Andreotti
ignorando altre e più plausibili interpretazioni (ad esempio, l’ipotesi di
un’iniziativa autonoma di Bontate con la spendita indebita del nome di
Andreotti); aveva attribuito a Mammoliti una dichiarazione sui rapporti tra
Andreotti e Nardini del tutto difforme da quelle effettive, che invece li
avevano erroneamente qualificati come parenti o soci o amici; aveva travisato
il senso delle dichiarazioni del teste colonnello Pellegrini, relative al
descritto viaggio in Sicilia di Mammoliti (che invece all’epoca era detenuto),
inserendo arbitrariamente alcuni puntini di sospensione in un passaggio della
trascrizione della registrazione effettuata in udienza.
Ancora, il ricorrente ha
censurato la sentenza assumendo che essa aveva fatto assurgere al rango di
riscontri fatti che invece non provavano il ruolo attivo di Andreotti nella
vicenda, come l’effettività della estorsione subita da Nardini, e fatti notori,
quale era la relativa notizia, diffusa dai mass media. Infine, ha rilevato che
la sentenza aveva superato le riserve scaturenti dalla genesi delle accuse
mosse da Mammoliti richiamando la peculiarità del narrato, come se a
riscontrare l’attendibilità fosse sufficiente la considerazione che egli non
era stato mosso da intenti calunniatori atteso che aveva attribuito ad
Andreotti un contatto con boss mafiosi finalizzato non già a nuocere, ma a far
cessare le estorsioni.
D’altra parte, le dichiarazioni
di Mammoliti erano state smentite dal significativo silenzio sull’episodio di
Marino Mannoia, penetrante conoscitore della ’ndrangheta dei fratelli
Piromalli, e di Angelo Siirto, ripetutamente accompagnatore di Bontate, che
pure avevano dichiarato di essere venuti a conoscenza, proprio attraverso le
confidenze di Stefano Bontate, di notizie relative ai presunti rapporti tra
costui e il sen. Andreotti; ignoranza tanto più rimarchevole considerato che,
secondo Mammoliti, il boss mafioso si era apertamente vantato del favore fatto
all’uomo politico.
Ma, soprattutto, come
riconosciuto dalla sentenza di primo grado, le dichiarazioni di Mammoliti erano
state esplicitamente smentite da quelle dello stesso Bruno Nardini, che invece
la Corte di Appello aveva ritenuto menzognere sul rilievo che costui aveva
ricoperto una serie di incarichi di nomina politica che, essendo di matrice
democristiana, gli erano stati sicuramente conferiti da Andreotti, pur mancando
qualsiasi prova al riguardo, almeno per l’epoca dei fatti.
Il ricorrente ha affermato che la
sentenza impugnata aveva posto, a conforto del proprio assunto, la non
corrispondenza della deposizione di Nardini (sarebbe riuscito da solo ad
indurre i malviventi a ridimensionare la richiesta iniziale) con i contenuti
delle intercettazioni telefoniche da cui la trattativa non era risultata e poi
ha spiegato che essa era incorsa nell’errore di compiere un’indagine incompleta
e di esaminare solo brandelli fugaci delle conversazioni, concernenti un
rapporto indubbiamente anomalo e non conforme a quelli comuni di affari,
condotto autonomamente da Nardini secondo una strategia poi risultata vincente,
che la sentenza impugnata aveva ritenuto inverosimile senza considerare che
costui già in altra occasione aveva tenuto una condotta del tutto analoga,
utilizzando come tramite la medesima persona (Vincenzo Riso).
Poi il ricorrente ha criticato
l’argomentazione della Corte di Appello, secondo cui anche le dichiarazioni di
Tommaso Buscetta costituirebbero riscontro idoneo ad avvalorare quelle di
Francesco Marino Mannoia, in quanto dimostrerebbero l’esistenza di rapporti tra
l’imputato ed esponenti mafiosi di primo piano del gruppo moderato di Cosa
Nostra e di legami tra i cugini Salvo e l’imputato.
In proposito, ha rilevato che
Buscetta non aveva mai dichiarato di essere venuto a conoscenza di relazioni
tra Bontate e Andreotti, avendo riferito solo di aver saputo di un incontro
dell’imputato con Badalamenti e che, in altra occasione, quest’ultimo e Bontate
gli avevano detto che l’omicidio Pecorelli era stato fatto da loro,
dichiarazioni che la stessa Corte aveva definito oscillanti, vaghe e confuse.
A questo punto il ricorrente ha
analizzato l’attendibilità di Tommaso Buscetta, rilevando che la Corte aveva
utilizzato criteri del tutto illogici e in contrasto con la giurisprudenza di
legittimità, avendo in sostanza affermato che non coerenza, costanza e precisione,
ma contraddizioni, incertezze e oscillazioni rendevano credibili le
dichiarazioni in quanto permettevano di escludere che le accuse fossero il
deliberato parto di una maliziosa fantasia e inoltre che, grazie all’assunto
che il propalante sconta indiscutibili improprietà lessicali, aveva ignorato il
tenore letterale dei verbali privilegiando il senso delle dichiarazioni, cosi
ovviando a contraddizioni insuperabili.
Questa tecnica aveva consentito
di dare credito ad un episodio completamente inventato, cioè al presunto
incontro tra Badalamenti e Andreotti per l’aggiustamento del processo Rimi,
inizialmente collocato in epoca in cui alcuni protagonisti di tale incontro
erano detenuti. Oltre tutto la credibilità di Buscetta era stata affermata
ignorando totalmente le approfondite argomentazioni con cui la difesa aveva
dimostrato le numerose falsità da costui riferite, ad esempio a proposito
dell’omicidio Pecorelli e del sequestro di Aldo Moro (egli aveva
pedissequamente copiato le dichiarazioni di Marino Mannoia).
Ancora, a proposito del predetto
incontro tra Andereotti e Badalamenti per aggiustare il processo di Cassazione
a carico dei Rimi, utilizzato dalla Corte palermitana quale riscontro delle
dichiarazioni di Mannoia sull’incontro tra Andreotti e Bontate nel 1980, il
ricorrente ha rilevato trattarsi di episodi del tutto diversi e autonomi.
Nella prospettazione accusatoria
questo incontro, riferito "de relato" da Buscetta e originariamente
collocato nel 1971 (la sentenza della Cassazione è del 3.12.1971), quando in
realtà sia Vincenzo Rimi (poi deceduto nelle more del giudizio) e Filippo Rimi
sia Badalamenti erano detenuti, era stato a lungo il fulcro del processo, quale
rivelatore dell’esistenza del patto di scambio tra Andreotti (che avrebbe
ottenuto appoggio elettorale) e Cosa Nostra. Ma in dibattimento Buscetta,
appresa la smentita di Badalamenti, aveva modificato la propria versione
riferendo di un incontro avvenuto nel 1979 a Roma nello studio del sen.
Andreotti di ringraziamento da parte di Badalamenti per l’interessamento svolto
a favore di suo cognato Filippo Rimi (Vincenzo era ormai deceduto) per il
processo non più in Cassazione, ma genericamente celebrato a Roma (giudice di
rinvio fu designata la Corte di Assise di Appello di Roma, che decise il
13.2.1979).
La sentenza di primo grado aveva
preso atto delle molteplici contraddizioni e incongruenze. Invece la sentenza
di appello le aveva ignorate ritenendo, contraddittoriamente, provato
l’incontro, ma non l’intervento di Andreotti per pilotare il verdetto, senza
considerare che, in tal modo, veniva sgretolatata causale de) presunto
incontro, essendo priva di qualsiasi prova, oltre che irrazionale,
l’argomentazione secondo cui Andreotti avrebbe fatto finta di attivarsi e che
il particolare riferimento ricavato dalle dichiarazioni dei collaboranti era
inesistente, avendo essi fornito notizie diverse e contrastanti, come
ampiamente dimostrato dalla stessa sentenza di primo grado oltre che dalla
memoria che la difesa dell’imputato aveva depositato nel giudizio di appello.
Quindi il ricorrente ha
analizzato i rapporti con i cugini Ignazio e Nino Salvo, ritenuti certi dalla
sentenza, che li aveva inquadrati nelle presunte relazioni con l’ala moderata
di Cosa Nostra e che si sarebbero affievoliti nel 1980. Sul punto della
conoscenza con i Salvo, il ricorrente ha rilevato che la Corte di Appello aveva
addirittura ritenuto inconcludenti i dati di fatto valorizzati (il numero di
telefono del sen. Andreotti in possesso di Ignazio Salvo, il regalo di nozze
alla figlia di Nino Salvo, la richiesta di notizie sulla salute di Cambria) e
le argomentazioni addotte dal Tribunale per dimostrarla, e che si era invece
basata sulle dichiarazioni di Marino Mannoia, affermando che sarebbero state
riscontrate da quelle di Tommaso Buscetta, che invece il Tribunale aveva
definito assolutamente inattendibile.
Quanto a Mannoia, la Corte
territoriale era incorsa in una palese petizione di principio perché aveva
indicato proprio nei rapporti tra Andreotti e i Salvo un elemento di riscontro
alle dichiarazioni del collaboratore e una prova indiretta della verità di
quanto da lui detto circa gli incontri tra il sen. Andreotti e Stefano Bontate,
per cui aveva trasformato un elemento di riscontro in prova autonoma di un
fatto che, a sua volta, necessitava di essere dimostrato con fatti diversi ed
esterni alle suddette dichiarazioni.
Il ricorrente ha rilevato che le
minuziose ed esasperate indagini svolte non avevano offerto alcuna prova di
incontri, contatti, conversazioni tra l’imputato e i cugini Salvo (mancanza
gratuitamente attribuita dalla sentenza impugnata alla riservatezza dei
protagonisti), a eccezione di fotografie che avevano documentato circostanze
tanto occasionali quanto irrilevanti, tali da spiegare per quale ragione l’imputato
non ne avesse conservato memoria: la presenza di Nino Salvo nella platea del
Cinema Nazionale di Palermo tra le numerose persone che assistevano al comizio
di Andreotti alla chiusura della campagna elettorale per le elezioni al
Parlamento europeo del 1979 e il successivo ingresso del medesimo all’Hotel
Zagarella, certamente da lui non scelto, ove era stato organizzato un
ricevimento cui parteciparono varie personalità democristiane e ove venne
accolto da Nino Salvo, che ne era proprietario e che lo guidò attraverso i
saloni dell’albergo.
Il ricorrente non ha riconosciuto
maggior risultato alte argomentazioni di carattere logico con le quali il
giudice di appello aveva tentato di dare sostegno alla propria statuizione,
ritenendole intrinsecamente contraddittorie e frutto di un apprezzamento
erroneo delle risultanze processuali. Cosi, ad esempio, la sentenza impugnata
non si era avveduta che le osservazioni sviluppate per spiegare le ragioni per
cui Andreotti non avrebbe avuto motivo di negare la conoscenza con i Salvo, se
fosse stato preoccupato soltanto del possibile appannamento della propria
immagine, valevano, in identica misura, a spiegare anche il motivo per cui
l’imputato non avrebbe avuto ragione di negare tali rapporti anche nell’ipotesi
in cui essi fossero stati illeciti, cosi come non si era resa conto
dell’irrazionalità che permeava l’interpretazione delle dichiarazioni e dei
giudizi espressi dal gen. Dalla Chiesa rispetto ad appartenenti alla corrente
andreottiana siciliana (nell’incontro avvenuto il 5 aprile 1982 il generale
avrebbe detto ad Andreotti di sapere dei suoi in Sicilia e costui si sarebbe
sbiancato in volto).
Inoltre il ricorrente ha
rimproverato alla sentenza impugnata di avere trascurato le osservazioni con
cui la difesa aveva rivalutato la deposizione dell’attendibile Nicolo Mario
Graffagnini, già segretario provinciale della DC di Palermo, il quale aveva
dichiarato che, in occasione di una visita di Andreotti a Palermo, Ignazio
Salvo aveva declinato l’invito di Salvo Lima, che desiderava presentarlo al
senatore, spiegando di voler evitare che si pensasse che egli intendesse
passare agli andreottiani, circostanza che dimostrava che i due non si
conoscevano e non avevano rapporti.
Infine, il ricorrente ha preso in
esame i presunti riscontri ravvisati dalla sentenza impugnata nelle
dichiarazioni di Giovanni Brusca, affermando che esse erano assolutamente
insignificanti e che la Corte di Appello aveva fatto ricorso all’artifizio
retorico di negare o ridurre il valore di un dato per far risaltare quello del
dato che aveva inteso valorizzare.
Cosi, dopo aver sostenuto
l’attendibilità e la credibilità di Buscetta, ne aveva ammesso oscillazioni e
approssimazioni per concludere che qualcuno avrebbe potuto dissentire sulla
efficacia corroborativa delle sue dichiarazioni per poi subito dopo sostenere
che non era invece possibile disconoscere l’efficacia delle dichiarazioni di
Giovanni Brusca.
Ma, sul conto di costui, la
stessa sentenza impugnata aveva introdotto rilievi gravi (non era un
collaboratore della prima ora, ma era intervenuto quando i temi del processo
erano conosciuti; non era esente dal sospetto di perseguire benefici
processuali e personali, dipendenti anche dall’apparato inquirente) senza poi
addurre elementi concretamente idonei a superarli, tali non potendo essere
considerati il mancato sostegno alle propalazioni di Baldassare Di Maggio in
merito al preteso incontro tra Andreotti e Totò Riina in casa di Ignazio Salvo
o la negata conoscenza di leggi o provvedimenti favorevoli a Cosa Nostra emessi
per intervento dell’imputato.
Del resto, le fonti di conoscenza
di Giovanni Brusca sarebbero state, secondo quanto da lui stesso riferito, il
padre, dei colloqui con il quale non esisteva alcun riscontro, e Nino Salvo, il
quale gli avrebbe confidato che, in passato, era riuscito ad interessare il
sen. Andreotti per l’aggiustamento di un processo a carico dei Rimi. Ma anche
di questo colloquio nessuno aveva potuto dare la prova e, comunque, lo stesso
Brusca aveva riferito che il suo interlocutore aveva escluso di poter
intervenire ancora presso il sen. Andreotti.
Il ricorrente ha anche
sottolineato che nessun riscontro era ricavabile dal collaborante Di Carlo,
delle cui dichiarazioni in merito ai presunti rapporti tra il sen. Andreotti e
i cugini Salvo era stata dimostrata la plateale falsità (si veda, ad esempio,
la collocazione dello studio privato di Andreotti nel popolare e periferico
quartiere di San Lorenzo, mentre all’epoca esso si trovava proprio in Piazza
Montecitorio e successivamente era stato trasferito nella vicinissima e
centrale Piazza San Lorenzo in Lucina).
5) – Con il quinto motivo il
ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza e della ordinanza 25.10.2001
della Corte di Appello per mancata assunzione di una prova decisiva, consistita
nella produzione di ulteriore documentazione atta a contrastare quella
prodotta, nel corso del dibattimento, dalla Procura Generale e concernente i
movimenti del sen. Andreotti negli ultimi mesi del 1979 e i suoi impegni dall’agosto
al dicembre di quell’anno, per dimostrare l’assoluta impossibilità di viaggi
segreti in Sicilia al fine di incontrarsi con i vertici di Cosa Nostra.
La Corte territoriale, dopo aver
ritenuto l’indagine non necessaria, aveva esaminato la possibilità che il sen,
Andreotti si fosse recato in Sicilia anche in giorni diversi da quelli
originariamente presi in considerazione, possibilità che sarebbe stata esclusa
dalla documentazione che si era in grado di produrre.
6) – Con il sesto motivo il
ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per mancanza e manifesta
illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione, fino
alla primavera del 1980, all’associazione per delinquere denominata Cosa
Nostra, da cui, a partire da detta epoca, si sarebbe dissociato per poi
combatterla senza quartiere, mettendo a repentaglio la vita propria e dei
familiari.
Infatti, secondo la implausibile
sentenza impugnata, il sen. Andreotti avrebbe partecipato a Cosa Nostra per un
lungo periodo senza capirne esattamente natura, finalità e metodi di azione;
avrebbe frequentato tranquillamente, anche se segretamente, personaggi mafiosi
di notevole calibro; avrebbe partecipato al sodalizio allo scopo di perseguire
obiettivi illeciti, altrimenti irraggiungibili; si sarebbe recato in Sicilia
per discutere della linea politica dell’on. Mattarella con boss mafiosi;
sarebbe rimasto folgorato dall’omicidio di Piersanti Mattarella; scoperta la
vera natura di Cosa Nostra, avrebbe impunemente e tranquillamente voltato le spalle
al sodalizio criminoso e scatenato contro di esso una guerra senza quartiere.
D’altra parte, la stessa sentenza
aveva riconosciuto che moltissimi dei collaboranti avevano disinvoltamente
dichiarato il falso nella ricerca di facili benefici e che molte propalazioni
erano state generiche e, quindi, inconsistenti sul piano probatorio e aveva
inoltre arrecato un duro colpo alla tesi accusatoria secondo cui Andreotti
avrebbe partecipato a Cosa Nostra da tempo immemorabile fino al 1992, senza
peraltro dimostrare cosa avrebbe fatto a favore della mafia.
Invece la condotta tenuta a
partire dalla primavera del 1980 era stata tale da escludere che egli, in
precedenza, potesse avere assunto atteggiamenti in conflitto con i principi cui
si era palesemente ispirato in seguito, dimostrando una effettiva, specifica e
concreta condotta contro la mafia.
Quanto alle motivazioni che lo
avrebbero spinto ad associarsi con Cosa Nostra, la stupefacente tesi
dell’accusa, secondo cui egli avrebbe accolto nel 1970 nella propria corrente
Salvo Lima riuscendo grazie al suo apporto ad uscire dal ghetto della politica
laziale, era ridicola sul piano storico, essendo nota la sua carriera politica
e, in particolare, le circostanze che venne scoperto, giovanissimo, da Alcide
De Gasperi, il quale ne aveva fatto il suo più prezioso e vicino collaboratore
e che la sua ascesa politica era stata continua e costante, come dimostrava, ad
esempio, l’elezione ancora molto giovane all’Assemblea Costituente.
Il ricorrente ha poi sottolineato
che la sua carriera politica si era svolta a livello governativo piuttosto che
di partito, ragione per cui non aveva avuto alcuna necessità di gestire una
grande corrente e infatti si era sempre curato poco della propria.
Egli ha anche sostenuto che la sentenza
di appello non aveva condiviso l’impostazione dell’accusa, ma aveva prescelto
una tesi altrettanto illogica e assurda, avendo affermato che il sen. Andreotti
avrebbe partecipato a Cosa Nostra allo scopo di usufruire di canali paralegali
per ottenere risultati non raggiungibili con metodi ortodossi, risultati
peraltro non concretamente indicati, non potendo essere credibilmente
considerato tale l’episodio Nardini.
Ha concluso, sul punto, con il
rilievo che la stessa sentenza era stata costretta – conformemente a quella di
primo grado – a riconoscere che mancava la prova di un qualsiasi suo intervento
concreto in favore di Cosa Nostra, ragione per cui egli avrebbe solo millantato
credito, facendo credere per anni ai vertici mafiosi (evidentemente considerati
una congregazione di ingenui amiconi, disponibili ad essere presi in giro) di
essersi attivato in loro favore, mentre nella realtà sarebbe rimasto inerte.
Per accreditare questa tesi, la
Corte di Appello era stata costretta ad introdurre una massima di esperienza
illogica e paradossale, essendo giunta ad affermare che la possibilità di
realizzare extra ordinem obiettivi non ortodossi è un fatto suscettibile di
affascinare qualsiasi uomo di governo.
7) – Con il settimo e ultimo
motivo il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per inosservanza ed
erronea applicazione di norme giuridiche.
Il riferimento è all’art. 129
c.p.p. sul rilievo che, per quanto riguarda il reato sub a), la Corte
territoriale, anziché verificare allo stato degli atti se risultasse evidente
l’innocenza dell’imputato – unica valutazone possibile in presenza di una causa
di estinzione del reato (nella specie la prescrizione) – si era impegnata a
dimostrarne la colpevolezza prima di dichiarare il reato estinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10 – I principi giuridici
applicati da questa Corte
Le argomentazioni dei ricorrenti
hanno proposto all’esame della Corte questioni che rendono necessaria
l’enunciazione di alcuni principi giuridici che vanno esaminati in questa sede
in quanto costituiscono le linee guida della decisione.
Vengono, perciò, qui di seguito
trattati i problemi concernenti la partecipazione all’associazione mafiosa e la
permanenza in essa, la valutatone delle deposizioni dei collaboratori di
giustizia, l’onere motivazionale del giudice di appello che riformi la sentenza
di primo grado, i limiti di censurabilità nel giudizio di cassazione del vizio
di motivazione, l’assoluzione nel merito in presenza di una causa estintiva del
reato.
a) I giudici di merito e i
ricorrenti si sono preoccupati di delineare gli elementi costituitivi dei
contestati delitti di associazione per delinquere e di associazione di tipo
mafioso e di individuare i limiti della partecipazione a tali associazioni.
Con la nota sentenza n. 16 del
2004, Demitry, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che partecipante
all’associazione mafiosa è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque
assiduo, l’associazione non raggiungerebbe i suoi scopi o non li raggiungerebbe
con la dovuta speditezza.
E’, quindi, partecipante
all’associazione colui che agisce nella "fisiologia" della vita
corrente del sodalizio, al contrario del concorrente esterno che non ne fa
parte e che non è chiamato "a far parte", ma al quale si rivolge sia
per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel
momento in cui la "fisiologia" dell’associazione entra in
fibrillazione, attraversando una fase "patologica" che, per essere
superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico
intervento, del terzo. L’argomento, che ha formato oggetto di successive
elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali, ha trovato ulteriore, completa,
condivisibile trattazione nella recente sentenza di questa Corte n. 22327 del
2003, Carnevale.
Nell’occasione le Sezioni Unite
hanno affermato che l’appartenenza di taluno ad un’associazione criminale
dipende anche dalla volontà di coloro che già vi partecipano. Il relativo
accordo può risultare anche solo di fatto, purché vi siano elementi indicativi
di una volontà di inclusione del soggetto partecipe.
Quindi hanno chiarito che la
tipologia della condotta di partecipazione è delineata dal legislatore sotto
l’espressione "chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso"
(art. 416 bis, comma 1). Tenuti presenti i connotati assegnati all’associazione
mafiosa dal terzo comma dell’art 416 bis, deve intendersi che "fa
parte" di questa chi si impegna a prestare un contributo alla vita del
sodalizio, avvalendosi (o sapendo di potersi avvalere) della forza di
intimidazione dei vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e
di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti. Al contempo,
l’individuazione di una espressione come "fa parte" non può che
alludere ad una condotta che può assumere forme e contenuti diversi e variabili
cosi da delineare una tipica figura di reato "a forma libera",
consistendo in un contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale,
all’esistenza o al rafforzamento dell’associazione e, quindi, alla realizzazione
dell’offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice. Sicché a
quel "far parte" dell’associazione, che qualifica la condotta del
partecipe, non può attribuirsi il solo significato di condivisione meramente
psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, bensì anche
quello, più pregnante, di una concreta assunzione di un ruolo materiale
all’interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e
costante, funzionalmente orientato alla struttura e alla attività
dell’organizzazione criminosa: il che è espressione di un inserimento
strutturale a tutti gli effetti in tale organizzazione nella quale si finisce
con l’essere stabilmente incardinati. Ne deriva che, se a quel "far
parte" dell’associazione si attribuisce il significato testé detto, si
deve conseguentemente affermare che, da un punto di vista logico, la situazione
di chi "entra a far parte di una organizzazione" condividendone vita
e obiettivi, e quella di chi, pur non entrando a fame parte, apporta dall’esterno
un contributo rilevante alla sua conservazione e al suo rafforzamento, sono
chiaramente distinguibili, In definitiva, la figura del partecipe e la relativa
condotta tipica sono configurabili non in virtù della mera assunzione di uno
"status", ma bensì del contributo arrecato al sodalizio criminale da
chi è stabilmente incardinato nella struttura associati va con determinati,
continui compiti anche per settori di competenza.
L’elemento psicologico consiste
nella consapevolezza e volontà di associarsi con lo scopo di contribuire alla
realizzazione del programma dell’associazione. Non è richiesto che il
concorrente voglia realizzare i fini propri dell’associazione, ma è sufficiente
che abbia la consapevolezza che altri fa parte e vuole far parte dell’associazione
e agisce con la volontà di perseguirne i fini.
Accanto alla partecipazione
intesa come "intraneità" all’associazione, le citate Sezioni Unite
hanno riaffermata la configurabilità del concorso esterno, ridefinendone i
limiti.
Esso sussiste in capo alla
persona che, priva della "affectio societatis" e non inserita nella
struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto,
specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale
o continuativo, purché detto contributo abbia un’effettiva rilevanza causale ai
fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione e l’agente se ne
rappresenti, nella forma del dolo diretto, l’utilità per la realizzazione,
anche parziale, del programma criminoso.
Nell’ occasione le Sezioni Unite
hanno anche precisato che la prova del concorso esterno nel reato associativo
deve avere ad oggetto gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa,
con la conseguenza che esulano dall’ipotesi in esame situazioni quali la
"contiguità compiacente" o la "vicinanza" o la
"disponibilità" nei riguardi del sodalizio o di suoi esponenti, anche
di spicco, quando non siano accompagnate da positive attività che abbiano
fornito uno o più contributi suscettibili di produrre un oggettivo apporto di
rafforzamento o di consolidamento sull’associazione o quanto meno su un suo
particolare settore.
Non basta, quindi, neppure ai
fini del concorso esterno, la mera disponibilità a fornire il contributo
richiesto dall’associazione, ma occorre l’effettività di tale contributo, cioè
l’attivazione del soggetto nel senso indicatogli dal sodalizio criminoso.
Queste ultime affermazioni
assumono particolare rilievo in quanto delineano in maniera corretta i precisi
limiti del reato in esame (art. 416 bis c.p.p.) e, apparendo del tutto conformi
al dettato normativo e all’inquadramento sistematico del reato stesso,
risultano pienamente applicabili al caso di specie.
Mette conto, peraltro, di
rilevare, per completezza di indagine, che, in precedenza, l’orientamento
giurisprudenziale non era consolidato sul punto e tendeva prevalentemente ad
una interpretazione più estensiva dei limiti stessi.
Ad esempio, Cass. n. 6992 del
1992, Altadonna, ha ritenuto configuratole come partecipazione effettiva, e non
meramente ideale, ad una associazione per delinquere (nella specie di tipo
mafioso), anche quella di chi, indipendentemente dal ricorso o meno a forme
rituali di affiliazione, si sia limitato a prestare la propria adesione, con
impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera,
all’associazione anzidetta, giacché anche in tal modo il soggetto viene
consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità
dell’organizzazione delinquenziale.
Il diverso e più ampio
orientamento è ben espresso anche da Cass. n. 4976 del 1997, Accardo, secondo
cui la condotta di partecipazione all’associazione per delinquere di cui
all’art. 416 bis c.p. è a forma libera, nel senso che il comportamento del
partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un
contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi
dell’organismo: in questo modo, infatti, si verifica la lesione degli interessi
salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto
dall’agente nell’ambito dell’associazione, ne consegue che la condotta del
partecipe può risultare variegata, differenziata, ovvero assumere connotazioni
diverse, indipendenti da un formale atto di inserimento nel sodalizio, sicché egli
può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo
sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo
per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene
perseguito con l’utilizzazione di metodi mafiosi.
In relazione alla prova della
partecipazione all’associazione va condiviso l’orientamento espresso da Cass.
n. 1631 de 2000, Bonavota, secondo cui, in siffatto tema, la prova logica
costituisce il fondamento della dimostrazione dell’esistenza del vincolo
associativo. E, invero, occorre procedere all’esame delle condotte criminose,
ciascuna delle quali può non essere dimostrativa del detto vincolo, sicché solo
attraverso un ragionamento logico può desumersi correttamente che le singole
intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono espressione del
programma delinquenziale, oggetto della stessa associazione.
Infatti, come ha ben spiegato
Cass. n. 1525 del 1997, Pappalardo, la prova dell’esistenza della volontà
partecipativa è desunta per lo più dall’esame d’insieme di condotte frazionate
ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa della partecipazione
stessa e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole
intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono l’espressione del
programma delinquenziale oggetto dell’associ azione.
Ciò è rilevante anche sotto il
profilo della motivazione, perché costituisce vizio della medesima, censurabile
in Cassazione, sia la parcellizzazione della valenza significativa di ogni
singola fonte di prova, sia l’attribuzione di una valenza assolutamente neutra
sul piano indiziario all’indicazione di appartenenza al sodalizio mafioso da
parte di un collaborante. Non solo perciò l’indicazione siffatta di appartenenza
al sodalizio proveniente dal collaborante è utilizzabile sul piano indiziario,
ma la chiamata in correità riferita a fatti specifici e non supportata dai
necessari elementi di conferma, proveniente tuttavia da soggetto
intrinsecamente attendibile ed attendibile essa stessa, può essere utilizzata,
quale elemento indiziario, ai fini dell’accertamento del reato associativo,
quantomeno nel senso del coinvolgimento del soggetto in un determinato contesto
ambientale e del suo apporto alla vita della consociazione, anche se non sarà
possibile fondare esclusivamente su tale elemento di indizio un’affermazione di
colpevolezza per il reato associativo.
Naturalmente l’elaborazione
giurisprudenziale ha esaminato anche il problema della permanenza del singolo nell’associazione,
ovvero della dissociazione del partecipante.
Secondo il condivisibile
orientamento espresso da Cass. n. 3089 del 1999, Caruana, ai fini della
configurabitità del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, il
vincolo associativo tra il singolo e l’organizzazione si instaura nella
prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae
sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della
cessazione del carattere permanente del reato soltanto l’avvenuto recesso
volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di
partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita,
coerente e univoca e non in base ad elementi indiziari di incerta valenza.
Questo orientamento è stato
ulteriormente precisato da Cass. n. 22897 del 2001, Riina, secondo cui la
rottura del vincolo associativo che lega taluno al sodalizio criminoso può
avvenire attraverso la prestazione di un’attività di segno contrario a quella associativa,
consistente in un contributo concreto alla difesa sociale dal sodalizio
delinquenziale, essendo irrilevante per l’ordinamento giuridico un’abiura o
un’altra forma di manifestazione di pentimento che assume carattere indicativo
nel solo contesto culturale mafioso.
In altri termini, a differenza di
quanto si deve ritenere nell’ipotesi di concorso esterno, il partecipante
organicamente inserito nel sodalizio criminoso non cessa di farne parte in
virtù di mera inattività, ma occorre un comportamento concreto ed effettivo che
dimostri inequivocabilmente la dismissione della in precedenza acquisita
qualità di associato (si vedano, in proposito, anche Cass. n. 3319 del 1994,
Contempo Scavo e Cass. n. 1896 del 1988, Abbate).
L’orientamento è univoco posto
che alcune decisioni, formalmente difformi, solo apparentemente si sono
discostate da esso, come Cass. n. 3231 del 1995, Mastrantuono, secondo cui, ai
fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per
delinquere, comune di tipo mafioso, non è sempre necessario che il vincolo
associativo fra il singolo e l’organizzazione si instauri nella prospettiva di
una sua futura permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo
vantaggio dell’organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario, pensare a
forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata
limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere
l’obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri
di quest’ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di
vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il
vincolo associativo può assumere anche, nell’ottica del soggetto, una funzione
meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza
penale. E ciò senza necessità di ricorrere, in detta ipotesi, alla diversa
figura giuridica del cosiddetto "concorso eventuale esterno" del
singolo nella associazione per delinquere.
Infatti trattasi di decisioni
attinenti ad ipotesi particolari come dimostra la stessa sentenza citata, che
riguardava i rapporti di collaborazione instauratisi fra un esponente politico
e un’organizzazione camorristica, in cui la Corte, in base ai suddetti
principi, ha riconosciuto legittimamente configurabile, a carico del primo, il
reato di partecipazione alla detta associazione.
D’altra parte, la permanenza a
tempo indeterminato nell’associazione appare in linea con il carattere
pacificamente ritenuto permanente del reato in esame, il quale non si esaurisce
nell’atto con cui l’associato presta la sua adesione all’organizzazione, ma
perdura nel tempo finché l’adesione non venga meno mediante la dissociazione.
Infatti il bene giuridico tutelato dalla norma sulla materia è il pericolo di turbativa
dell’ordine pubblico derivante potenzialmente dall’organizzazione criminosa,
pericolo che non cessa fino a quando essa è in vita o, comunque, con
riferimento specifico all’attività partecipativa del singolo aderente, finché
questi non sia uscito dall’organizzazione facendo venir meno il suo apporto
personale o non sia stato espressamente estromesso.
Come si è appena visto,
l’elaborazione giurisprudenziale non ha trascurato i rapporti tra politica e
criminalità organizzata. La posizione dell’uomo politico che ottenga vantaggi
elettorali dall’alleanza con sodali" mafiosi è stata per lo più
inquadrata, diversamente da quanto ritenuto dalla risalente sentenza appena
sopra citata, nello schema del concorso esterno, anche se con riferimento ad
ipotesi peculiari.
Più recentemente (Cass. n. 2285
del 2000, Pangallo), si è affermato che, in tema di concorso esterno in
associazione per delinquere di tipo mafioso, premesso che tale ipotesi, a
differenza di quella costituita dalla partecipazione "organica", si caratterizza
per l’assenza di una compenetrazione strutturale e di un vincolo
psicologico-finalistico stabile e richiede, quindi, necessariamente, una
concreta attività collaborativa idonea a contribuire al potenziamento,
consolidamento o mantenimento in vita del sodalizio mafioso in correlazione a
congiunturali esigenze del medesimo, deve ritenersi che, nel caso particolare
di una relazione fra uomo politico e gruppo mafioso, non basti, per la
sussistenza del concorso esterno, una mera vicinanza al detto gruppo o ai suoi
esponenti, anche di spicco, e neppure la semplice accettazione del sostegno
elettorale dell’organizzazione criminosa, ma sia necessario un vero patto in
virtù del quale l’uomo politico, in cambio dell’appoggio elettorale, si impegni
a sostenere le sorti della stessa organizzazione in un modo che, sin
dall’inizio, sia idoneo a contribuire al suo rafforzamento o consolidamento. In
tale ottica non appare necessaria, per la consumazione del reato, la concreta
esecuzione delle prestazioni promesse anche se, il più delle volte, essa
costituisce elemento prezioso per la dimostrazione del patto e della sua
consistenza.
Questa Corte è tornata a
riesaminare la questione ribadendo (Cass. n. 4893 del 2000, Frasca) che, mentre
nel reato di scambio elettorale politico-mafioso (art 416 ter c.p.) non è
necessario, e anzi è improbabile, che il politico aderisca, quale componente o
concorrente esterno, alla struttura malavitosa (essendo semplicemente previsto
che egli abbia ottenuto promessa di appoggio elettorale, contro effettivo
versamento di denaro), nella ipotesi in cui la associazione mafiosa si impegni
per ostacolare il libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti ad
un determinato candidato (art. 416 bis comma terzo, ultima parte c.p.), quest’ultimo
o sarà un aderente, a pieno titolo, alla suddetta associazione, ovvero, in
quanto uomo politico estraneo alla associazione, ma disponibile al
soddisfacimento delle esigenze della stessa, potrà eventualmente rivestire, in
ragione del suo concreto comportamento, il ruolo di concorrente esterno, ciò in
quanto, anche se non "intraneus" alla "societas sceleris",
potrà allacciare con la stessa un rapporto collaborativo e una relazione di
reciproca utilità.
La stessa sentenza ha
ulteriormente affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, poiché il
procacciamento del voto costituisce una delle eventuali finalità cui la
suddetta associazione può tendere, la condotta punibile va ravvisata
nell’azione di associarsi ad una (o in una) struttura criminale, avente le
caratteristiche descritte dall’art. 416 bis c.p., allo scopo, tra l’altro, di
controllare e influenzare il consenso politico e i flussi elettorali. Il
conseguimento dello scopo non è, tuttavia, elemento costitutivo della
fattispecie, anche perché il bene giuridico tutelato, l’ordine pubblico, è
vulnerato per il solo fatto che un’associazione mafiosa faccia valere il suo
peso a favore di un candidato (in motivazione, la Corte ha chiarito che,
applicando il suddetto principio in tema di concorso esterno – nel quale l’uomo
politico si impegni, in cambio dell’appoggio elettorale, a favorire, una volta
eletto, con la concessione di appalti ed altro, l’associazione e i suoi
appartenenti – il rapporto sinallagmatico sussiste, non tra le due "prestazioni",
ma tra le due promesse, anche perché una delle due, quella relativa
all’appoggio elettorale, dovrà essere necessariamente mantenuta prima
dell’altra, quella relativa ai favoritismi che il politico ha assicurato al
clan, e anzi il suo mantenimento e la sua realizzazione costituiranno il
presupposto per il rispetto dell’impegno preso dall’associato esterno, che,
solo se eletto, potrà "sdebitarsi").
Da ultimo (Cass. n. 33915 del
2001, Allegro) è stato precisato che, in tema di associazione per delinquere di
stampo mafioso, nel caso particolare di una relazione tra un uomo politico e un
gruppo mafioso, non è sufficiente per la sussistenza del reato una mera
vicinanza al detto gruppo o ai suoi esponenti, anche se di spicco, e neppure la
semplice accettazione del sostegno elettorale dell’organizzazione criminosa, ma
è necessario un accordo in base al quale l’uomo politico, in cambio
dell’appoggio elettorale, si impegni a sostenere le sorti dell’organizzazione
in modo idoneo a contribuire al suo rafforzamento.
Ritiene, peraltro, questo
Collegio che non sia configurarle in astratto la natura del rapporto tra
sodalizio criminoso e uomo politico ma che essa vada configurata caso per caso
a seconda di "come" quel rapporto si svolge di guisa che la giurisprudenza
richiamata sul punto non è risolutiva, dovendosi, invece, in relazione alla
"peculiarità del caso Andreotti", richiamarsi ai principi generali,
in precedenza delineati, in tema di reato associativo.
Orbene, come si vedrà nel
prosieguo, la Corte territoriale ha ritenuto l’imputato partecipe, sia pure non
"formale", al sodalizio criminoso sino al 1980, con motivazione che
non risulta irragionevole.
Definita la problematica relativa
all’associazione di tipo mafioso, restano semplificati i riferimenti all’associazione
per delinquere semplice come delineata dall’art. 416 c.p., considerato che la
prima ha carattere speciale rispetto alla seconda, da cui si differenzia per
l’eterogeneità degli scopi che mira a realizzare (quindi per l’oggetto del
programma criminoso) e per il ricorso alla sua forza di intimidazione (vedi
Cass. n. 6203 del 1991, Grassonelli).
E’ qui sufficiente ricordare che
gli elementi strutturali dell’associazione per delinquere (vedi, ad esempio,
Cass. n. 3402 del 1992, Niccolai) sono la formazione e la permanenza di un
vincolo associativo continuativo, fra tre o più persone, allo scopo di
commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune
dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale e con la
permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio
criminoso e di essere disponibile ad operare per l’attuazione del programma
stesso.
Si tratta (Cass. n. 403 del 1991,
Marin) di un reato a forma libera, per la consumazione del quale si richiede
una qualsiasi azione, con qualsiasi modalità eseguita, purché causale rispetto
all’evento tipico, cioè idonea a cagionarlo.
Anche nel reato di partecipazione
ad associazione a delinquere è configurabile (Cass. n. 12591 del 1995,
Arcidiacono) il concorso eventuale di persone che si verifica nel caso in cui
taluno contribuisca al pregiudizio che l’associazione reca all’ordine pubblico,
mediante un contributo materiale o morale al vincolo dei partecipi, senza che
egli sia a sua volta vincolato. Ne deriva che, quando il contributo sia
duraturo, la prova negativa del vincolo proviene dall’esclusione secondo regole
interne dell’associazione, anche consuetudinarie, circa l’affiliazione o il
comportamento dei membri. In assenza di esse, ove si dimostri che gli affiliati
fanno preventivo affidamento sul contributo di taluno, la condotta di questi,
non essendo svincolata dallo scopo sociale, va considerata alla stregua di
quella di qualsiasi partecipe. Al contrario, ove gli affiliati non facciano preventivo
conto sul suo apporto, la relativa condotta è qualificabile come concorso
eventuale nel reato.
Infine, giova ricordare (Cass.
12525 del 2000, Buscicchio) che, ai fini della configurabilità del reato di
associazione per delinquere, non è necessario che il vincolo associativo assuma
carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori
e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti
predeterminati, atteso che l’elemento temporale insito nella nozione stessa di
stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del
legame criminale, essendo, per contro, sufficiente ad integrare l’elemento
oggettivo del reato una partecipazione all’associazione anche limitata ad un
breve periodo.
Dall’identità strutturale e dal
carattere permanente dei reati rispettivamente previsti dagli artt. 416 e 416
bis c.p. consegue che, pur essendo i medesimi autonomi, tutta la condotta
incriminata, se cessata in epoca successiva all’entrata in vigore della norma
speciale (introdotta dall’art. 1 Legge 13 settembre 1982, n. 646) è
assoggettata alla disciplina da questa dettata (Cass. n. 6992 del 1992,
Altadonna, Cass. n. 3492 del 1988, Altivalte, Cass. n. 6580 del 1989,
Bonaccorsi; Cass. n. 11669 del 1987,Liccardo).
La considerazione finale del
Collegio, in aderenza ai principi giurisprudenziali innanzi enunciati, è che
partecipante nel reato associativo è colui che viene "accolto" e
"accettato" da! sodalizio criminoso e che non si limita ad una adesione
"ideologica" o espressa in termini di mera vicinanza o disponibilità,
ma tiene un comportamento, estrinsecato nel porre in essere attività effettive,
omogeneo agli scopi del sodalizio, cui viene fornito un contributo concreto,
protratto nel tempo sino al momento della eventuale dissociazione.
b) La Corte territoriale ha
ritenuto determinante, ai fini della decisione, la ricostruzione in punto di
fatto che ha effettuato sulla base delle dichiarazioni di numerosi
collaboratori di giustizia, tra i quali particolare credito ha attribuito a
Francesco Marino Mannoia.
In linea di diritto, il tema
della valutazione della prova ha ormai raggiunto un notevole grado di
definizione grazie al contributo della elaborazione dottrinaria e
giurisprudenziale.
Giova in primo luogo riaffermare,
in linea generale, che l’indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza
logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene
alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del
cosiddetto sillogismo giudiziario. E’ possibile che da un fatto accertalo sia
logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è
significativo di una pluralità di fatti non noti e in tal caso può pervenirsi
al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi
applicando la regola metodologica fissata nell’ari 192, comma secondo, c.p.p..
Peraltro l’apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza
verso un’univocità indicativa che dia la certezza logica dell’esistenza del
fatto da provare costituisce un’operazione logica che presuppone la previa
valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa
individuale. Acquisita la valenza indicativa – sia pure di portata
possibilistica e non univoca – di ciascun indizio, deve allora passarsi al
momento metodologico successivo dell’esame globale e unitario, attraverso il
quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può
risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si
integra con gli altri, di tal che l’insieme può assumere quel pregnante e
univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova
logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato
rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la
rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto
libero convincimento del giudice (Cass. S.U n. 6682 del 1992, Musumeci).
Passando ad una disamina più specifica,
per costante interpretazione giurisprudenziale, la chiamata di correo ha valore
di prova diretta contro l’accusato in presenza di tre requisiti, che devono in
concreto essere accertati dal giudice di merito e che sono: a) l’attendibilità
del dichiarante (confidente e accusatore), valutata in base a dati e
circostanze attinenti direttamente alla sua persona, quali il carattere, il
temperamento, la vita antefatta, i rapporti con l’accusato, la genesi e i
motivi della chiamata di correo; b) l’attendibilità intrinseca della chiamata
di correo, desunta da dati specifici e non esterni ad essa, quali la
spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione
dei fatti, la concordanza tra te dichiarazioni rese in tempi diversi, e altri
dello stesso tenore; e) l’esistenza di riscontri esterni, ovvero di elementi di
prova estrinseci, da valutare congiuntamente alla chiamata di correo, per
confermarne l’attendibilità, al cui esame peraltro non si può procedere se
persistono dubbi sulla credibilità del dichiarante o sull’attendibilità
intrinseca delle sue dichiarazioni (Cass. n. 4888 del 2000, Orlando; Cass. sez.
II, n. 15756 del 2003, Contrada).
Quando la relativa verifica abbia
avuto esito positivo e individualizzante, la chiamata in reità assurge al rango
di prova pienamente valida a carico del chiamato e può essere posta a
fondamento dell’affermazione di responsabilità (confrontaCass. SU. n. 45276del
2003, Andreotti).
Invece la chiamata in correità
priva di adeguato riscontro non può giustificare un’affermazione di
responsabilità, ma non può neppure essere considerata "taraquam non
esset" per cui ad essa, purché resa da soggetto intrinsecamente
attendibile, va pur sempre riconosciuto valore di indizio il quale, però, per assumere
il carattere della gravita, deve trovare il necessario riscontro estrinseco in
relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto della imputazione
(confronta Cass. n. 1743 del 1995, Libri; Cass. n. 3124 del 1994, Mazzurco;
Cass. n. 811 del 1991, Mercuri).
Particolare rilievo, con
riferimento al caso di specie, assume proprio il problema delle dichiarazioni
rese dai cosiddetti collaboratori di giustizia. Al riguardo Cass. n. 9723 del
1999, D’Arrigo, ha convincentemente spiegato che i canoni di valutazione
specificamente dettati dall’art. 192, commi 3 e 4, e.p.p., per le dichiarazioni
provenienti da coimputati del medesimo reato o da imputati di reati connessi o
interprobatoriamente collegati, ponendosi come derogativi al principio del
libero convincimento del giudice, recepito anche nel codice vigente come regola
generale di valutazione della prova, non possono essere considerati
suscettibili di applicazione al di fuori dei rigorosi limiti loro assegnati dal
legislatore. Detti canoni, quindi, non debbono venire obbligatoriamente
osservati quando si tratti di valutare dichiarazioni provenienti da soggetti i
quali, pur essendo investiti della qualità di "collaboratori di
giustizia", non rientrino, però, con riguardo al procedimento nel quale
dette dichiarazioni debbono essere utilizzate, in alcuna delle categorie
indicate nelle summenzionate disposizioni normative.
Sono state esaurientemente
affrontate e decise anche situazioni particolari quali la pluralità di chiamate
in correità, la chiamata in correità unica e le dichiarazioni "de
relato".
Sulla prima questione va ribadito
l’orientamento espresso da Cass. n. 13885 del 1999, Greco, secondo cui le
chiamate in correità, provenienti da soggetti diversi, possono riscontrarsi a
vicenda, nel senso che ciascuna può essere ritenuta, rispetto alle altre come
ulteriore elemento che ne conferma l’attendibilità; ciò tuttavia a condizione
che le dichiarazioni accusatone siano tra loro indipendenti e non frutto di un
accordo calunnioso (nello stesso senso, ad esempio, Cass. n. 4140 del 1997,
Pirozzi).
Sulla seconda è sufficiente fare
riferimento a quanto già affermato da Cass. n. 21621 del 2001, Marra, secondo
cui, in caso di unica chiamata di correità, le dichiarazioni rese a carico
dell’imputato debbono trovare riscontri probatori individualizzanti, questi,
tuttavia, possono essere dedotti dagli elementi di causa e la valutatone del
giudice può basarsi anche su rilievi logici che, in modo coerente e fondato,
riconducano all’imputato riscontri singolarmente non univoci rispetto alla sua
persona.
Il terzo dei problemi sopra
indicati è quello più frequentemente esaminato dalla giurisprudenza di
legittimità.
Significativamente fin da Cass.
n. 24711 del 2002, Mondeilo era stato chiarito che, in tema di dichiarazioni provenienti
da collaboratore di giustizia che abbia militato all’interno di un’associazione
mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni
che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio
cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle
ordinarie dichiarazioni "de relato", che non sono utilizzabili se non
attraverso la particolare procedura prevista dall’art. 195 c.p.p., in quanto
l’impossibilità di esperire, nel primo caso, l’anzidetta procedura rende le
stesse propalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee di per se a
giustificare un’affermazione di colpevolezza; nondimeno, le stesse possono
assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi
elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca,
davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso
circolare di informazioni attinenti a fatti di
interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti
per le propalazioni dei collaboratori di giustizia.
Nella sostanza, la statuizione
citata ha confermato la linea su cui si era attestata Cass. n. 17804 del 2002,
Graviano, secondo cui la dichiarazione accusatoria "de relato", resa
da un collaboratore di Giustizia, può integrare la prova della colpevolezza
solo se è sorretta da adeguati riscontri estrinseci che – a differenza di
quanto è richiesto per la chiamata in correità – devono riguardare
specificatamente il fatto che forma oggetto dell’accusa e la persona dell’incolpato,
in quanto il minore tasso di affidabilità di una dichiarazione resa su
accadimenti non direttamente percepiti dal dichiarante rende necessaria
l’individualizzazione del riscontro (sostanzialmente negli stessi termini Cass.
n. 43464 del 2002, Pinto).
Ora sul problema si sono
pronunciate, in termini condivisibili, le Sezioni Unite (Cass. n. 45276 del
2003, Andreotti), affermando che la chiamata in realtà fondata su dichiarazioni
"de relato", per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a
carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna,
necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità
non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie,
oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere
carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche
circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il
chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura
indiretta dell’accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto
narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa.
Ma le affermazioni che precedono
non esauriscono il tema perché occorre ancora individuare i criteri di
valutazione dei riscontri.
Sul punto si è chiaramente
espressa Cass. n. 3616 del 2000, Calascibetta, spiegando che i riscontri alle
dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un
procedimento connesso possono essere costituiti anche da ulteriori
dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la
loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per
la loro indipendenza – intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente –
da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della
concordanza; e) per la loro specificità, nel senso che la cosiddetta
convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e
riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte,
fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli
elementi d’accusa fomiti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto
sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della
questione fattuale da decidere.
Del resto trattasi di
orientamento che era già stato sostanzialmente espresso da questa stessa
sezione (Cass. n. 7437 del 1999, Cataldo) la quale aveva appunto affermato che,
in tema di valutatone della chiamata in correità secondo le regole dettate
dall’art. 192, comma 3, c.p.p., ben possono costituire riscontro alla chiamata
medesima le plurime dichiarazioni accusatone, le quali, per poter essere
reciprocamente confermative, devono mostrarsi convergenti in ordine al fatto
materiale oggetto della narrazione, indipendenti (nel senso che non devono
derivare da pregresse intese fraudolente, da suggestioni o condizionamenti che
potrebbero inficiare il valore della concordanza) e specifiche (nel senso che
la ed. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente
individualizzante, ossia le varie dichiarazioni, pur non necessariamente
sovrapponigli, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la
persona dell’incolpato, sia Le imputazioni a lui attribuite).
Naturalmente non occorre che i
riscontri riguardino ogni singola circostanza riferita (in tal caso verrebbe
richiesta una sorta di "probatio diabolica") essendo evidente
(confronta sul punto Cass. n. 5036 del 1997, Pesce) che, ai sensi dell’art.
192, comma terzo, c.p.p., per ritenere la responsabilità di un imputato sulla
base delle dichiarazioni accusatone di un coimputato o di persona imputata in
un procedimento connesso è necessario che le dette dichiarazioni siano
suffragate da riscontri obiettivi. Ma non è necessario che i detti riscontri
riguardino le singole circostanze riferite dal dichiarante, essendo sufficiente
che riguardino la dichiarazione nel suo complesso. Infatti, la citata
disposizione richiede che gli "altri elementi di prova", unitamente
ai quali il giudice di merito deve valutare le dichiarazioni di cui si tratta,
confermino l’attendibilità delle stesse e non le singole circostanze riferite;
altrimenti, la prova sarebbe data dai cosiddetti riscontri, e le dichiarazioni
delle persone menzionate nell’art. 192, commi terzo e quarto, c.p.p. sarebbero
svuotate di quel valore probatorio che il legislatore ha attribuito loro,
disponendo che le stesse "sono valutate unitamente agli altri elementi di
prova", i quali, peraltro, possono esser costituiti da dichiarazioni di
altri collaboranti, dato che il legislatore non ha posto alcuna limitazione a
riguardo.
Altrettanto evidente è (Cass. n.
13385 del 1999, Greco) che, in tema di valutatone della prova, gli
"altri" elementi di prova, di cui al terzo comma dell’art. 192
c.p.p., non devono necessariamente riguardare la prova in se della colpevolezza
dell’imputato, quanto piuttosto devono costituire un riscontro
dell’attendibilità del dichiarante, con riferimento specifico all’imputato e al
fatto delittuoso a lui attribuito.
c) La sentenza di appello non è
completamente conforme alla sentenza del Tribunale. DI qui la necessità di
precisare l’onere motivazionale gravante sul giudice di secondo grado con
riferimento alle modifiche apportate a quella di primo grado.
E’ noto che, quando le due
sentenze di merito concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi
di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura
motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per
formare un unico complesso corpo argomentativo (vedi Cass. n. 8868 del 2000,
Sangiorgi).
Ma allorché le decisioni dei due
giudici di merito discordano, non soltanto non si verifica l’integrazione
motivazionale di cui si è detto, ma il giudice di grado superiore è tenuto ad
indicare le ragioni che lo hanno indotto a non condividere la statuizione della
sentenza sottoposta al suo esame e a pervenire a conclusioni diverse,
riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice
di primo grado, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione
e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima
sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale (Cass. SU.
n. 6682 del 1992, Musumeci). Ciò detto, va però precisato che oggetto della
verifica in sede di legittimità è unicamente la sentenza di appello e che alla
Corte regolatrice non è consentito scegliere quale delle due sentenze di merito
sia più rispettosa dei consueti canoni ermeneutici.
Infatti fin da Cass. n. 617 del
1984, Arancio, questa Corte ha stabilito che il giudice di appello è libero,
nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni
probatorie il significato e il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini
della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi
logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento; obbligo che, nel caso di
decisione difforme da quella del giudice di primo grado, impone anche
l’adeguata confutazione delle ragioni poste a base della sentenza riformata.
Ma la stessa sentenza ha
precisato che, anche nel caso di disparità di valutazoni tra i giudici nei
gradi del giudizio di merito, oggetto dell’esame in sede di legittimità è soltanto
la sentenza del giudice di appello, la cui opinione si sostituisce a quella
diversa del primo giudice. Quindi nemmeno in tal caso il giudice di legittimità
può estendere – operando una inammissibile scelta tra le due diverse valutazoni
– il suo esame oltre i limiti istituzionalmente stabiliti dalla legge, sicché
la valutatone degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente
all’apprezzamento del giudice di appello.
Più recentemente, questo
orientamento è stato ribadito, in termini sostanzialmente identici, da Cass. n.
6839 del 1999, Menditto, secondo cui, in tema di giudizio di legittimità, la
regola secondo cui, nel caso di decisione difforme da quella del giudice di
primo grado, si impone un’adeguata confutazione delle ragioni poste a base
della decisione riformata non comporta che, laddove sussista diversità di
valutazoni tra i giudici di merito, oggetto dell’esame in sede di legittimità
siano entrambe le decisioni, dovendo la verifica investire soltanto la sentenza
del giudice di appello, la cui opinione si sostituisce a quella del primo
giudice. Ne consegue che, in sede di giudizio di legittimità, non potendo
estendersi l’esame oltre i limiti istituzionali, la valutatone degli elementi
probatori rimane sempre affidata esclusivamente all’apprezzamento del giudice
di appello.
Trattasi di affermazioni
indiscutibilmente corrette in quanto i casi di ricorribilità per cassazione
sono soltanto quelli tassativamente previsti dall’art. 606 c.p.p., il quale,
alle lettere b), c), e), in particolare, e anche d) del comma 1, la limita ai
vizi attinenti la sentenza direttamente impugnata con esclusivo riferimento al
suo contenuto intrinseco.
d) A questo punto vanno precisati
i limiti della censurabilità in Cassazione del vizio di motivazione, che la
lettera e) del comma 1 dell’art. 606 c.p.p. consente esclusivamente nelle
ipotesi di mancanza o manifesta illogicità della medesima risultante dal testo
del provvedimento impugnato.
E’ ormai orientamento consolidato
che il sindacato di legittimità sul vizio di mancanza o manifesta illogicità
della motivazione è circoscritto al riscontro di un logico apparato
argomentativo sui punti della decisione impugnata, perché il legislatore non ha
previsto la verifica dell’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di
merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, né la loro
rispondenza alle acquisizioni processuali (Cass. Sez. Un. n. 6402 del 1997,
Dessimone).
Di conseguenza il compito del
giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutasene a
quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di
prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi
a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi,
dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano
esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle
argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a
preferenza di altre (Cass. Sez. Un. n. 930 del 1996, Clarke).
Infine, come risulta dal chiaro
testo dell’art. 606 lett. e) c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità
della motivazione debbono risultare dal testo del provvedimento impugnato,
sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che detto
testo è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non già opporre
alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa
ricostruzione, magari altrettanto logica (Cass. Sez. Un. n. 16 del 1996, Di
Francesco).
In definitiva il Collegio
ribadisce e, conclusivamente, fa proprio quanto appena sopra detto, cioè che
(vedi anche Cass. n. 5285 del 1998, Calia) la mancanza e l’illogicità della
motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché
dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del
provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già
opporre alla logica valutatone degli atti, effettuata dal giudice di merito,
una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica.
A quanto sopra è opportuno
aggiungere che la ricorribilità in sede di legittimità del vizio in esame non
può essere artificiosamente estesa attraverso l’utilizzazione impropria di
differenti via quali la violazione di legge o il travisamento del fatto.
Infatti, quanto al primo, la
specificità dell’art. 606, lett. e) c.p.p., dettato in tema di ricorso per
cassazione al fine di definirne l’ammissibilità per ragioni connesse alla
motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata, per effetto delle
regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l’utilizzazione del
vizio di violazione di legge di cui alla lettera e) dello stesso articolo. £
ciò, sia perché la deducibilità per cassazione è ammessa solo per la violazione
di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità,
inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto
e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale; sicché il
concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a
ricomprendere ogni omissione o errore che concernano l’analisi di determinati,
specifici elementi probatori (Cass. n. 1088 del 1999, Mondello).
Quanto al secondo, poiché il sindacato
del giudice di legittimità sulla struttura razionale della motivazione deve
essere limitato alla verifica della esistenza di un logico apparato
argomentativo, ne consegue che il vizio logico della motivazione, anche sotto
il profilo del travisamento del fatto, deve essere riscontrato tra le diverse
proposizioni contenute nella motivazione stessa senza alcuna possibilità di
ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Proprio per tale ragione,
però, per consentire all’interessato di formulare le più appropriate censure e
alla Corte di Cassazione di esercitare la funzione di controllo, è
indispensabile che il giudice di merito indichi con puntualità, chiarezza e
completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la
propria decisione (confronta Cass. n. 6504 del 2000, De Stefani).
Sempre con riferimento al tema in
esame la Corte, sollecitata dall’imputato, deve porsi il problema di ridefinire
i limiti della eccepibilità del vizio di motivazione per stabilire se la
verifica della motivazione della sentenza possa estendersi oltre il testo
letteralmente inteso sino a controllare il processo verificando che esso sia
compatibile con gli elementi ad esso acquisiti e che non siano stati trascurati
elementi probatori evidenziati dalla sentenza di primo grado o segnalati dalla
difesa dell’imputato assolto con la medesima.
Il tema non è sostanzialmente
dissimile da quello sostenuto dallo stesso imputato in altro giudizio e risolto
dalle Sezioni Unite (Cass. n. 45276 del 2003, Andreotti), con argomentazioni
che sembrano al Collegio ineccepibili e che, quindi, debbono essere recepite.
Nella consapevolezza del deficit
di giustizia sostanziale che può conseguire all’applicazione assoluta e
indiscriminata della regola della rilevabilità "testuale" del vizio
motivazionale determinato dalla mancata valutatone di una prova decisiva per la
difesa, si deve ritenere che la Corte di Cassazione possa fare riferimento, per
lo scrutinio di fedeltà al processo del testo del provvedimento impugnato, non solo
alla sentenza assolutoria di primo grado, ma anche (in assenza di motivi
d’impugnazione dell’imputato, carente d’interesse) alle memorie e agli atti con
i quali questi, nel contestare il gravame del P.M., abbia prospettato al
giudice di appello l’avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse
prove, favorevoli e decisive, oltre quelle utilizzate per fondare la decisione
assolutoria.
La mancata risposta del giudice
di appello a dette prospettazioni inficerebbe la completezza e coerenza logica
della sentenza sfavorevole all’imputato e, a causa delle negativa verifica tra
chiesto e pronunciato, la renderebbe suscettibile di annullamento.
Quindi la Corte di Cassazione è
chiamata a saggiare la tenuta sia "informativa"
sia "logico-argomentativa" della sentenza impugnata prendendone in
esame il testo e confrontandolo con quella di primo grado e con gli apporti
difensivi nel giudizio di appello, senza necessità di accedere agli atti di
istruzione probatoria.
e) Il comma 2 dell’art. 129
c.p.p. stabilisce che, pur in presenza di una causa estintiva del reato, il
giudice deve pronunciare sentenza assolutoria quando dagli atti risulta che il
fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come tate.
E’ "jus receptum" (vedi
Cass. n. 3945 del 1999, Di Pinto) che, in presenza di una causa estintiva del
reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma
dell’art. 129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del
medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile; tanto che la valutatone da compiersi in proposito appartiene più
al concetto di "constatazione" che a quello di
"apprezzamento". E, invero, il concetto di "evidenza",
richiesto dal secondo comma dell’art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione
di una verità processuale cosi chiara, manifesta e obiettiva, che renda
superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi cosi in qualcosa di più di
quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un
accertamento immediato (nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 1506 del
1998, Pasqualetti, Cass. n. 4163 del 1995, Cardillo).
In altri termini, perché
l’assoluzione nel merito prevalga sulla causa estintiva del reato, occorre
l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato, come del resto si evince
chiaramente dal testo della norma sopra citata. Pertanto, (Cass. n. 20807 del
2002, Savignano) in presenza di una causa estintiva del reato, il
proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p., si impone
ogni volta che sussista l’evidenza della prova di innocenza dell’imputato alla
quale è equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità, mentre non
trova applicazione nella sua assolutezza l’ulteriore equiparazione tra mancanza
totale e insufficienza o contraddittorietà della motivazione di cui all’art.
530, comma 2, c.p.p. quando sussista un concorso processuale di cause di
proscioglimento, poiché altrimenti verrebbe a vanificarsi il criterio della
"evidenza" posto dal legislatore per risolvere il predetto concorso
(vedi anche Cass. n. 1460 del 1998, Fraticello, Cass. n, 8859 del 1993, Mussone
e Cass. n. 10896 del 1992, Bronte).
A questo punto occorre accertare
le conseguenze di tale disciplina nel giudizio di legittimità.
In presenza della causa estintiva
della prescrizione, l’obbligo di declaratoria
di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. da
parte della Corte di Cassazione richiede il controllo unicamente della sentenza
impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza
della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza,
in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta
illogicità di motivazione, che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), deve
risultare dal testo del provvedimento impugnato (Cass. n. 9944 del 2000, Meloni).
Conclusivamente sul punto, giova
ribadire ancora (cfr. Cass. n. 2043 del 1997, Bomigia) che, in presenza di una
causa estintiva del reato, non è consentito al giudice di legittimità
l’annullamento con rinvio al giudice di merito, perché ciò sarebbe
incompatibile con il principio secondo il quale non è possibile la prosecuzione
di un procedimento penale nel quale si è già verificata la detta causa
estintiva e questa sia stata dichiarata dal giudice di merito con motivata
esclusione dell’incolpevolezza dell’imputato (vedi anche Cass. n. 10981 del
1993, Agostinelli).
Il Collegio condivide interamente
questa impostazione e, dunque, ritiene che la sua decisione debba uniformarsi
al principio secondo cui (vedi anche Cass. n. 12320 del 1998, Maccan), in presenza
di siffatta evenienza, l’obbligo del giudice di immediata declaratoria
ex art. 129 c.p.p. postula che le circostanze idonee a escludere l’esistenza
del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da
parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile,
sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al
concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Consegue, pertanto,
che, nel giudizio di cassazione, qualora venga riscontrato un vizio di
motivazione della sentenza impugnata implicante il rinvio al giudice di merito,
e le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni,
deve essere pronunciato l’annullamento senza rinvio in applicazione della causa
estintiva della prescrizione quando sia decorso il relativo termine, in quanto
il rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l’obbligo di immediata
declaratoria di essa.
Tutti i principi sopra
evidenziati, da intendersi come implicitamente richiamati e applicati con
riferimento alle questioni specificatamente sollevate con i due ricorsi,
rendono più agevole e spedito l’esame dei medesimi.
11 – Il ricorso della Procura
Generale
Come si è già esposto nella parte
narrativa della presente sentenza, la Procura Generale di Palermo ha impugnato
la statuizione della Corte di Appello stigmatizzandola sotto il duplice profilo
della erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione.
La contestazione della ricorrente
riguarda solo il periodo successivo alla primavera del 1980, atteso che, per
quello precedente, la sentenza ha applicato la prescrizione ritenendo integrata
la condotta partecipativa al sodalizio criminoso (anche se, nel corso della
motivazione, per evidente "lapsus calami", non mancano riferimenti al
"concorso esterno", come avviene nella disamina dell’incontro con
Manciaratina), del resto in conformità di quanto contestato nel capo di
imputazione.
Sotto il profilo della violazione
di legge la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia escluso il
protrarsi dopo il 1980 della disponibilità di Andreotti verso i mafiosi,
affermata invece per il periodo precedente, ritenendo che i fatti successivi
all’incontro – scontro con Bontate non fossero stati adeguatamente dimostrati o
che fossero privi di valenza significativa e che, anzi, nel 1989 l’imputato
avesse manifestato fervore antimafia attraverso comportamenti istituzionali
incisivamente avversi a Cosa Nostra.
Secondo la ricorrente in tal
modo, per escludere il perdurare della condotta criminosa, è stata ritenuta
sufficiente l’assenza di ulteriori comportamenti rivelatori di adesione al
sodalizio successivi a quelli positivamente ritenuti tali, mentre invece
l’elaborazione giurisprudenziale richiede che il recesso risulti da tangibili,
coerenti e inequivocabili segni di ravvedimento incompatibili con la volontà di
perpetuare il legame con l’organismo criminale.
E’ agevole osservare al riguardo
che, dal punto di vista teorico e astratto, la sollevata censura è in aderenza
al costante orientamento giurisprudenziale appena sopra citato e più ampiamente
riportato netta parte generale.
Infatti in quella sede si è
ricordato che la giurisprudenza ormai consolidata ritiene che, una volta
affermata la partecipazione al delitto associativo, occorre considerare che,
per sua natura, il vincolo tra il singolo e l’organizzazione si instaura nella
prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato, che, di
conseguenza, la consumazione del reato si protrae indeterminatamente nel tempo
e che, quindi, la rottura del vincolo associativo che lega il singolo al
sodalizio è configurabile (oltre che nell’ovvio caso qui certamente non
ricorrente di scioglimento dell’organismo) soltanto a seguito di recesso
volontario o di esclusione del partecipe che devono essere accertati caso per
caso in virtù di una condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a
elementi indiziali di valenza incerta, nel cui novero va compresa anche la
asserita in sentenza mancata prova di ulteriori comportamenti omogenei alle
finalità del sodalizio.
In definitiva, va ribadito che,
come la partecipazione all’associazione non può essere meramente ideologica (su
ciò si tornerà in prosieguo di motivazione), cosi non può esserlo la
dissociazione, la quale deve invece estrinsecarsi non in un mero rifiuto morale
o sentimentale, ma nella manifestazione di atteggiamenti positivi incompatibili
con il perdurare della partecipazione.
Di certo il ragionamento della
Corte territoriale sulla questione non risulta irreprensibile e, a quel che
sembra, aderente al principio di diritto più volte enunciato, avendo fatto
riferimento a una sorta di "desistenza" dell’imputato dall’attività
associativa per un "deficit" probatorio in ordine ai fatti successivi
alla primavera 1980 contestati allo stesso, il che non equivale certo a un suo
recesso nei termini in precedenza enunciati.
La questione stessa, malamente e
non compiutamente affrontata, non risulta, però, in pratica decisiva, ai fini
dell’accoglimento del proposto gravame, poiché occorre verificare se la Corte
palermitana, malgrado l’erronea e confusa enunciazione di principio, abbia poi
sul piano concreto ravvisato comportamenti significativi considerati idonei a
provare il recesso.
E, in effetti, dalle sue argomentazioni
si arguisce che, al di là delle affermazioni teoriche,essa ha fondato il
proprio convincimento, oltre che sul rilevato deficit probatorio, anche su due
fatti che ha ritenuto concretamente significativi di un sostanziale recesso,
l’incontro – scontro tra Andreotti e Bontate nella primavera del 1980 e
l’impegno istituzionale antimafia dimostrato dall’imputato a far data dal 1989.
Quest’ultimo non ha formato
specifico oggetto di contestazione da parte della Procura Generale, che però ha
rilevato la sussistenza in epoca ad esso successiva di un ulteriore episodio
contrario all’imputato, le vicende relative alle elezioni regionali del 1991,
Ma, riguardo a queste ultime, la sentenza impugnata ha escluso qualsiasi
coinvolgimento personale dell’imputato, affettuando, in modo non manifestamente
illogico, che l’appoggio elettorale degli "uomini d’onore" ai
candidati Bevilacqua (che peraltro non venne eletto) e Giammarinaro fu legato
più ai rapporti intrattenuti a livello locale (e il riferimento concreto ha
coinvolto Salvo Lima) con il singolo candidato che ad orientamenti e
considerazioni di carattere generale, riguardanti l’azione politica riferibile
al leader nazionale della corrente adreottiana. Le argomentazioni con cui la
Corte territoriale è pervenuta a queste conclusioni, sostanzialmente analoghe a
quelle del Tribunale, sono frutto di vantazioni di merito espresse in termini
accettabili per cui esse non risultano, come detto, illogiche e non possono
essere oggetto di ulteriore disamina critica in sede di legittimità.
Maggiore attenzione richiede,
invece, l’incontro con Bontate, su cui si sono appuntate anche le contestazioni
dell’imputato, che ne nega la ontologica esistenza (quest’ultima questione sarà
trattata a proposito del quarto motivo del suo ricorso), in quanto ad esso,
come emerge da tutto quanto sin qui esposto, il giudice di merito attribuisce
la valenza determinante del recesso di Andreotti.
Secondo la Corte di Appello
l’incontro suddetto – che nella sua ricostruzione sarebbe stato il secondo
avente ad oggetto il problema rappresentato da Piersanti Mattarella – da un
lato concorre a provare la partecipazione dell’imputato al sodalizio mafioso,
ma dall’altro ne segna il momento di crisi, quindi di distacco, stante il
totale e grave disaccordo tra i due interlocutori, l’asprezza dei toni usati da
Bontate e, soprattutto, le considerazioni e le reazioni che l’omicidio di
Mattarella avrebbero indotte nell’imputato.
La valutatone della Corte di
Appello, circa il valore dell’episodio ai fini del processo, è basata su
apprezzamenti di merito che rispondono ai canoni logici e che, quindi, non sono
censurabili nel giudizio di legittimità.
Ma occorre anche considerare che,
sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente assume che il convincimento
della Corte palermitana circa l’effetto dissociativo del secondo incontro con
Bontate è fondato su argomentazioni che si sostanziano in mere congetture,
talora illogiche e non autorizzate da specifiche risultanze processuali, e che
inoltre essa contesta, sempre sul piano motivazionale, la mancata attribuzione
di valenza probatoria agli episodi successivi al 1980.
Sul primo punto, in particolare,
la Procura Generale rileva che la Corte d’Appello ha interpretato l’incontro
con Stefano Bontate, nella primavera del 1980, come decisivo ai fini del
ripensamento radicale da parte di Andreotti dei rapporti fino a quel momento
intrattenuti con l’organizzazione criminale, sebbene la fonte utilizzata
(Francesco Marino Mannoia) si fosse limitata ad affermare soltanto che
l’imputato aveva preteso spiegazioni sulla scelta sanguinaria assumendo una
posizione decisamente critica sull’operato di Cosa Nostra, tanto che la
discussione era stata caratterizzata da toni accesi.
In realtà, dal testo della
semenza, che ha riportato letteralmente le dichiarazioni di Mannoia (nella
parte in cui ha riferito circa il ricorso dei P.M.), risulta che il disaccordo
tra i due interlocutori fu totale ed espresso in termini aspri, tali da
renderlo razionalmente interpretabile come vero e proprio litigio, ed
espressione, perciò, della volontà di recesso dal sodalizio. La considerazione
di ciò ha indotto la Corte territoriale ad individuare, nel drammatico fatto
che aveva originato l’incontro e nell’esito sconfortante dell’accesa discussione,
le cause che avevano convinto Andreotti a distaccarsi in modo irreversibile e
definitivo da Bontate e da tutto ciò che costui rappresentava.
Questa valutatone rientra
nell’ambito delle attribuzioni del giudice del merito, il quale è libero di apprezzare
le risultanze processuali e di trame conseguenze di carattere logico, le quali
non possono essere inficiate da possibili interpretazioni alternative, purché
egli rispetti il duplice principio di dedurre i fatti ignoti da accadimenti
certi, seguendo percorsi logici coerenti e necessitati e non basati su mere
congetture o intuizioni, e di dare conto delle ragioni che lo hanno indotto a
scegliere la ricostruzione preferita.
Per nozione di comune esperienza
un forte contrasto, originato da ragioni rilevanti e ritenute imprescindibili e
fondamentali da almeno una delle parti, costituisce una circostanza idonea a
determinare una frattura definitiva tra i soggetti in conflitto, anche se è
indubbio che non ogni contrasto, per quanto acceso, cagioni sempre e
necessariamente una scissione insanabile e permanente.
In tale situazione – in presenza
di due diverse conclusioni ugualmente possibili e razionali – è decisivo
verificare che il libero apprezzamento del giudice di merito si sia formato e
sia stato espresso secondo un percorso logico coerente.
Orbene, contrariamente
all’assunto della Procura Generale ricorrente, la sentenza impugnata non ha
motivato il proprio convincimento facendo leva su affermazioni apodittiche, ma
ha inquadrato questo episodio – che ha interpretato come il risultato di una
precedente evoluzione – in un più ampio contesto rappresentato dai gravissimi
fatti (quali gli omicidi di uomini delle istituzioni) che si erano verificati
già prima dell’omicidio Mattarella e che ha ritenuto idonei, sul piano
razionale, a sviluppare nell’imputato insofferenza verso i metodi del sodalizio
criminale e consapevolezza dell’importanza del fenomeno, in precedenza
sottovalutato anche perché il concomitante problema del terrorismo aveva
costituito l’emergenza primaria per il Paese e, quindi, aveva assorbito
l’attenzione degli uomini che, a vario titolo e livello, ne incarnavano le
istituzioni.
D’altra parte, nella
prospettazione della Corte palermitana, l’omicidio Mattarella, che aveva fatto
seguito ad un precedente incontro tra i medesimi interlocutori – organizzato
proprio al fine di stabilire come intervenire per limitare l’azione dell’uomo
politico ritenuta pregiudizievole degli interessi economici del sodalizio –
oltre a sgomentarlo sul piano etico e umano, ha definitivamente convinto
Andreotti della impossibilità di controllare e limitare la drasticità degli
interventi operativi dell’organizzazione e di incanalarli verso soluzioni
politiche e incruente.
In definitiva, è vero che la
ricostruzione prescelta dalla sentenza non è l’unica ipotizzabile, ma è
tranciarne, ai fini della decisione, il rilievo che essa è idonea a resistere
nel giudizio di legittimità perché è stata esposta in termini logici e
conseguenti, tali da renderla esente dalla manifesta irrazionalità sanzionata
dall’art. 606 c.p.p., essendo invece il risultato di un ragionamento sviluppato
in modo coerente.
Del resto occorre considerare un
ultimo accadimento, che pure risulta dalla sentenza impugnata e che ne rafforza
la logica motivazionale: all’epoca dell’incontro si stava per scatenare quella
guerra di mafia che in breve tempo avrebbe condotto alla sconfitta dell’ala
moderata di Cosa Nostra, all’omicidio dello stesso Bontate e all’avvento degli
spietati "corleonesi" guidati da Salvatore Riina.
E’ dunque verosimile che, già
all’epoca, Bontate non fosse più in grado di far prevalere all’interno di Cosa
Nostra soluzioni moderate e che, anzi, dovesse spostarsi – anche per
salvaguardare se stesso – verso comportamenti più violenti, come sembrerebbe
confermare l’avvertimento-minaccia che avrebbe rivolto allo stesso Andreotti di
guardarsi bene dall’adottare misure punitive per Cosa Nostra e i suoi
associati.
D’altra parte non è
manifestamente irrazionale ritenere che, come affermato dalla Corte di Appello,
in esito al secondo incontro con Bontate l’imputato si fosse reso conto della
mutata situazione e delle vicende drammatiche che ne sarebbero ulteriormente
seguite.
In questo quadro debbono essere
inserite le ulteriori censure della Procura Generale concernenti la
sottovalutazione degli episodi successivi al 1980.
Giova ricordare la rilevanza,
attribuita dalla sentenza impugnata, alle dichiarazioni di Marino Mannoia
(rilevanza peraltro criticata dall’imputato). Il collaborante, mentre aveva
offerto una pluralità di elementi che la Corte territoriale ha creduti e
utilizzati per desumerne la prova dei rapporti di Andreotti soprattutto con
Bontate, non ha invece arrecato alcun contributo probatorio idoneo a dimostrare
l’estensione di analoghi rapporti all’ala "corleonese" della mafia,
per cui alla Corte palermitana è venuto a mancare, con riferimento ad essa,
l’ausilio della fonte probatoria su cui riteneva poter fare maggiore
affidamento.
Questo rilievo assume particolare
significato ove si ricordi che, al contrario, dalle risultanze processuali è
emerso un certo disappunto di Riina per non aver potuto instaurare con
l’imputato i rapporti di cui in precedenza si erano vantati Bontate e
Badalamenti.
Passando ad un esame più
analitico, si osserva che la Corte palermitana, nel giustificare la ritenuta
carenza probatoria di contatti con l’ala "corleonese", ha spiegato
che il legame di Andreotti con Lima si protrasse oltre il 1980, ma che non è
provato che costui fosse a sua volta legato a Riina, e in ogni caso che tale
eventuale rapporto si estendesse all’imputato. Essa ha indicato le ragioni che
l’hanno indotta a ritenere affievolito il rapporto con i Salvo (Nino sarebbe
deceduto poco dopo), e scarsamente incidente sul processo quello con Ciancimino
(del resto destinato a cessare rapidamente).
Ancora, ha spiegato il carattere
non individualizzante degli elementi probatori raccolti – in ordine, sia alla
telefonata che dalla segreteria dell’imputato venne effettuata per conoscere le
condizioni di salute di un sodale dei Salvo, sia al trasferimento di detenuti
siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara nel 1984 – nonché ha
rimarcato la carenza probatoria relativa al preteso intervento nella
conclusione del maxiprocesso.
Anche con riferimento ai suddetti
episodi vale una considerazione già fatta: sono certamente possibili
interpretazioni alternative, ma per il principio del libero convincimento del
giudice di merito e per i limiti della rilevabilità in sede di legittimità del
vizio di motivazione, esse non inficiano quelle non manifestamente irrazionali
privilegiate dalla sentenza impugnata. L’episodio forse più significativo da
essa riferito e probabilmente meno razionalmente motivato è quello relativo
all’incontro con Andrea Manciaracina, avvenuto nel 1985 (sulla sua effettività
concordano le due sentenze di merito).
Infatti, mentre il Tribunale
aveva negato qualsiasi valenza probatoria all’episodio, sul rilievo che se ne
ignoravano totalmente i contenuti e che mancava la prova di eventuali conseguenze
sul piano concreto, la Corte d’Appello ha attribuito ad essa un qualche
significato, avendo esplicitamente ritenuto che, non essendo logicamente
possibili spiegazioni diverse, oggetto del colloquio non potessero essere che
sollecitazioni e/o raccomandazioni prospettate dall’interlocutore all’uomo
politico, anche se poi ha ribadito (in questo d’accordo con il Tribunale) che
al colloquio non era seguito alcun comportamento concreto del medesimo.
Trattasi, quindi, di un elemento
neutro perché fondato su una ricostruzione di merito effettuata dalla Corte
territoriale in termini non palesemente illogici. D’altra parte, qualsiasi
ulteriore indagine riguardo all’interpretazione di questo episodio è ormai
preclusa, a ragione della prescrizione già maturata (la Corte d’Appello è
pervenuta a tale statuizione – che non ha formato specifico oggetto di ricorso
– avendo escluso la circostanza aggravante di cui al comma 4 dell’art. 416 c.p.
e avendo affermato di dover comunque escludere l’incidenza delle aggravanti in
dipendenza della concessione delle circostanze attenuanti generiche), in quanto
raffermata dissociazione di Andreotti dal sodalizio criminoso – avvenuta nel
1980 – ha spezzato l’altrimenti necessario collegamento, e quindi la
valutazione unitaria e globale, degli episodi accaduti in epoca antecedente a
tale data con quelli successivi.
Di conseguenza, non
illogicamente, la Corte palermitana ha valutato gli episodi avvenuti dopo la
ritenuta cessazione della partecipazione di Andreotti al reato associativo
svincolati da quelli risalenti nel tempo e quindi ha tenuto conto solo della
loro valenza intrinseca e non di quella ipotizzabilmente diversa loro
attribuibile in esito alla valutazione globale e complessiva di tutti i fatti
ritenuti accertati con riferimento all’intero periodo temporale indicato nel
capo d’imputazione.
E’ appena il caso di precisare
ulteriormente, stante l’ovvietà della considerazione, che, se la partecipazione
di Andreotti nel reato associativo è cessata nel 1980, gli episodi accaduti
successivamente non possono essere considerati come indice della prosecuzione
della disponibilità attiva ritenuta per il periodo precedente, ma vanno tenuti
presenti al solo fine di verificarne l’interpretabilità come manifestazione di
una nuova adesione e, quindi, di una rinnovata partecipazione.
Ma si è detto che il giudizio
negativo sul punto della Corte territoriale non è inficiato da manifesta
irrazionalità e, quindi, non merita censura in questa sede.
Pertanto, l’episodio da ultimo
esaminato (l’incontro con Manciaracina) e tutti gli altri successivi al 1980
debbono essere valutati soltanto come idonei a confermare la correttezza
dell’assoluzione ai sensi del comma 2 dell’art. 530 c.p.p. in quanto, pur
rivestendo, in alcuni casi, possibile valore indiziario, ma non potendo più
essere collegati – in virtù del ritenuto recesso – a quelli anteriori a detta
epoca e dovendo essere considerati, come già detto, distintamente, non
risultano più sufficienti per una pronuncia di condanna. Alle considerazioni sopra
svolte consegue che il ricorso della Procura Generale, pur fondato su
incontrovertibili e pacifici principi di diritto, si svela carente e va,
perciò, rigettato.
12 – Il ricorso dell’imputato
Il ricorso dell’imputato si
incentra soprattutto, anche se non esclusivamente, sulla configurazione
giuridica della partecipazione all’organizzazione criminosa; sui riscontri
necessari per utilizzare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; sulla
tenuta della motivazione della sentenza impugnata con riferimento, sia alla
parte informativa, sia alla parte decisionale.
a) Con il primo motivo l’imputato
tratta il tema, che ritiene fondamentale ai fini della decisione, della
partecipazione nel reato associativo.
A tale scopo, esamina
criticamente le argomentazioni su cui la sentenza impugnata, passate in
rassegna le possibili forme di partecipazione al reato associativo, lo ha
ritenuto sodale della succitata organizzazione criminosa.
Esclusi sia il formale
inserimento organico (Cosa Nostra non considerava il sen. Andreotti tra i suoi
affiliati, tanto che non lo rese partecipe della decisione di uccidere l’on.
Mattarella), sia l’attività di cooperazione continuativa con il sodalizio
criminoso (il sen. Andreotti certamente non si sottopose al necessario tirocinio
criminoso), sia la prestazione di singoli e concreti contributi
all’associazione mafiosa posti in essere in momenti di particolare difficoltà
per consentirne il superamento (al sen. Andreotti non è stato possibile
addebitare neppure un solo atto specifico e concreto a favore di Cosa Nostra),
la Corte di Appello ha configurato nei confronti dell’imputato l’ipotesi di
prestazione cosciente e volontaria, al sodalizio nel suo complesso, di un
contributo (parola definita dal ricorrente di per se ambigua per l’ampiezza e
varietà di significati possibili) non episodico, bensì di apprezzabile
continuità e stabilità.
La stessa sentenza impugnata ha,
dunque, esclusa nei confronti del ricorrente la sufficienza della mera
disponibilità, poiché tale situazione è possibile soltanto nella prima ipotesi,
ove la formale affiliazione (nella specie non avvenuta) determina la qualifica
di "uomo d’onore".
In mancanza della formale
affiliazione, la condotta associativa è radicata dal contributo recato
dall’agente alla organizzazione mediante apporti puntuali, occorrenti per
integrare la condotta penalmente tipica.
In questo quadro la Corte di
Appello ha fatto riferimento alla "peculiarità del caso Andreotti" –
determinata dalla considerazione che l’imputato è un uomo che per lunghi
decenni è stato protagonista di primo piano della storia italiana – per
chiedersi se potesse essere sufficiente, ai fini dell’affermazione di
responsabilità, la semplice e continuativa disponibilità, anche in assenza
della dimostrazione piena e concreta di singoli specifici apporti.
Il ricorrente osserva che, in tal
modo, l’asserita peculiarità ha consentito alla sentenza impugnata di annullare
i profili di tipicità della condotta costitutiva del delitto contestato e le
esigenze di prova.
Egli lamenta ancora che la
sentenza non ha chiarito i percorsi probatori idonei a fornire la prova
dell’esistenza di "una semplice, continuativa disponibilità"
distinguendoli da quelli legati alla ricerca di concreti e specifici apporti
dell’imputato a favore del sodalizio criminoso (la stessa Corte d’Appello ha
escluso che comportino partecipatone a Cosa Nostra le frequentazioni con boss
mafiosi).
L’ultimo tema specificamente
trattato con il primo motivo è quello della tipicità della condotta costitutiva
del delitto in esame. Il ricorrente sostiene che la tesi della sentenza
impugnata attrae nell’ambito della punibilità anche comportamenti
intrinsecamente equivoci e non estrinsecatisi in un concreto, specifico ed
esattamente individuato apporto alla organizzazione criminale (la semplice
disponibilità).
b) Con il secondo motivo il
ricorrente stigmatizza la statuizione della sentenza impugnata anche sotto il
profilo logico – motivazionale.
L’assunto principale è che il
concetto di disponibilità implica, inevitabilmente, la volontà di far parte del
sodalizio, affermazione del resto condivisa dalla Corte di Appello.
Sennonché ciò implica pure che la
disponibilità non può consistere in un semplice stato d’animo, ma va provata
analizzando il comportamento del soggetto, che, in mancanza di una
dichiarazione di impegno a prestare la propria opera secondo le richieste
dell’associazione, deve denotare attività concrete dimostrative e attuative
della volontà di adoperarsi per l’associazione.
A questo punto il ricorrente
assume che nulla di ciò è emerso dalle risultanze processuali e che, anzi, la
stessa sentenza impugnata ha escluso che siano stati provati suoi comportamenti
concreti interpretabili nel senso indicato (a tali argomentazioni ha fatto
seguire l’analisi critica di alcune affermazioni della Corte d’Appello anche
con riferimento a singoli episodi da essa riferiti).
A giudizio di questa Corte, le
due doglianze sopra sintetizzate sono complementari e, quindi, possono essere
esaminate congiuntamente.
Nella premessa relativa alla
individuazione dei principi giuridici da applicare nel caso di specie si è già
precisato che, per configurare la partecipazione nel reato associativo, non è
sufficiente la condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle
relative metodiche, occorrendo anche che la manifestata disponibilità trovi
concreta estrinsecazione attraverso comportamenti specifici.
Questa affermazione risponde
anche ad un’altra esigenza: in mancanza di un’affiliazione rituale, con
conseguente assunzione formale della qualifica di "uomo d’onore", è
solo attraverso la prestazione di un contributo concreto al sodalizio
associativo che si materializza e si manifesta anche all’esterno la prova della
relativa partecipazione.
Occorre, cioè, che l’agente
assuma all’interno della organizzazione un ruolo specifico e ad essa
funzionale, fornendole un contributo che può anche essere minimo e di qualsiasi
forma e contenuto, ma che deve essere effettivo e provato.
Sotto il profilo del principio di
tipicità, è agevole osservare che l’indicato principio, specie nei reati di
pericolo – quali indubbiamente sono quelli in contestazione – esige un
particolare rigore da parte dell’interprete, al fine di evitare una
inammissibile dilatazione della fattispecie penale, sicché la condotta
integrativa della fattispecie stessa deve trovare esatta corrispondenza nella
realtà assunta come parametro valutativo concreto della trasgressione
contestata (confronta Cass. n. 1973 del 1993, Thirez).
Né può giovare il riferimento alla
"peculiarità" del caso Andreotti, al fine di legittimare
un’interpretazione diversa e più estesa, poiché non solo in virtù del principio
di tassatività della condotta criminosa, ma anche alla stregua di quelli di
uguaglianza e di certezza del diritto, il legislatore prima e l’interprete poi
debbono rispettivamente emanare e individuare paradigmi normativi e
interpretativi validi per qualunque soggetto e per qualunque situazione ad essi
astrattamente riconducibili, senza poter enucleare ipotesi individuali, cioè
condotte criminose definite a seconda della personalità e della posizione del
soggetto cui vengono attribuite.
E’ appena il caso di precisare
che il concetto di peculiarità espresso nei termini sopra criticati è cosa ben
diversa dalla valutatone della personalità dell’imputato ai fini della
verosimiglianza dei fatti che gli vengono attribuiti o comunque riferiti, cui,
invece, il giudice può legittimamente ricorrere.
E in proposito va precisato che,
di norma, la personalità dell’imputato, nel senso e allo scopo sopra indicati,
è desumibile esclusivamente dagli atti processuali, mentre è indubbio che, nel
caso di Andreotti, possano essere di ausilio anche nozioni acquisite aliunde in
considerazione della sua notorietà, trattandosi di un uomo che è stato ai
vertici della vita politica e istituzionale del Paese per moltissimi anni, e
che ha sempre avuto ed ha tuttora una notevole esposizione mediatica (libri,
giornali, radio, televisione).
Le affermazioni che precedono, in
ordine alla configurabilità della partecipazione nel reato associativo, non
esauriscono la disamina, perché occorre ancora valutare in quali termini la
Corte di Appello abbia poi affrontato il tema concreto e abbia motivato la
propria decisione.
A tal fine è necessario occuparsi
del periodo antecedente al 1980, con riferimento al quale essa, ritenuta la
sussistenza di relazioni amichevoli e dirette di Andreotti con esponenti
mafiosi di spicco – propiziate dai suoi legami con Salvo Lima, con i cugini
Salvo e con Ciancimino – ha affermato essere intercorsi rapporti di scambio,
consistiti, da una parte, in un generico appoggio elettorale alla corrente
andreottiana e nel solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare possibili
esigenze, non necessariamente illecite, dell’imputato o di suoi amici e,
dall’altra parte, nella palesata disponibilità e nell’asserito apprezzamento
del ruolo dei mafiosi, frutto non solo di buone relazioni, ma anche di una
effettiva sottovalutazione del fenomeno mafioso, oltre che nella travagliata
interazione dell’imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, pur risoltasi
con il fallimento dei disegno andreottiano.
Più analiticamente, la Corte
territoriale ha affermato che il sen. Andreotti aveva avuto piena
consapevolezza che i suoi referenti siciliani (Lima, i Salvo e poi anche
Ciancimino) intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi; che
egli aveva, quindi, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi
boss; che aveva palesato ai medesimi una disponibilità non necessariamente seguita
da concreti, consistenti interventi agevolativi; che aveva loro chiesto favori;
che li aveva incontrati; che aveva interagito con essi; che aveva loro indicato
il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima questione
Mattarella, sia pure senza riuscire ad ottenere, in definitiva, che le stesse
indicazioni venissero seguite; che aveva conquistato la loro fiducia tanto da
discutere insieme anche di fatti gravissimi (come appunto l’assassinio del
Presidente Mattarella), nella sicura consapevolezza di non correre il rischio
di essere denunciati, che aveva omesso di denunciare le loro responsabilità, in
particolare in relazione all’omicidio del Presidente Mattarella, malgrado
potesse, al riguardo, offrire utilissimi elementi di conoscenza.
La Corte di Appello, in esito a
imprescindibili e quindi incensurabili valutazoni di merito, ha valutato questi
fatti come processualmente rilevanti e significativi ai fini della
configurabilità del reato contestato.
Per questa ragione, in presenza
dell’assoluzione dubitativa pronunciata dal Tribunale, ha applicato la causa
estintiva della pena – la prescrizione – nel frattempo maturata, assumendo non
essere evidente la prova dell’innocenza dell’imputato.
In tale situazione, e fatta salva
la successiva verifica analitica, rileva il Collegio che, sotto il profilo
teorico ora in esame, la sentenza impugnata ha configurato la condotta di
Andreotti in termini tali da escludere, quanto meno, l’evidenza probatoria
della sua estraneità, ai sensi dell’art. 129, comma 2 c.p.p..
Va quindi ribadito che, poste le
premesse di fatto come innanzi riportate e apprezzate dalla Corte territoriale,
non può ritenersi palesemente viziata – sotto il profilo logico – la
conclusione cui la medesima è pervenuta in ordine all’intera vicenda
Mattarella.
Analogamente, quanto ai benefici
elettorali che Andreotti avrebbe ricevuto o si sarebbe aspettato, va detto che
le conclusioni riduttive sul piano concreto cui la Corte territoriale è alla
fine pervenuta (i rapporti di scambio che dette amichevoli relazioni hanno
determinato: il generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana,
peraltro non esclusivo e non esattamente riconducibile ad una esplicitata
negoziazione e, comunque, non riferibile precisamente alla persona
dell’imputato) vanno coordinate con la precisazione che, all’epoca del ritenuto
rapporto di scambio, non era ancora emersa in termini chiari la fallacità del
comune convincimento circa la determinante forza elettorale di Cosa Nostra, che
aveva indotto il Bontate ad ammonire il suo illustre interlocutore circa la
necessità di conservare il favore della mafia e che poteva astrattamente
indurre a coltivare buone relazioni con i mafiosi.
In definitiva, il ragionamento
della Corte territoriale – che naturalmente può non essere condiviso, ma che
oggettivamente non è tacciatole di manifesta irragionevolezza – è il seguente:
un organismo criminale qual è Cosa Nostra non è certamente disponibile a
compiere alcuna azione senza ritenere di poter conseguire una controprestazione
adeguata.
Nei motivi in esame, l’imputato
utilizza la vicenda Mattarella come idonea a dimostrare che egli non accettò
mai il metodo mafioso (che prevede l’eliminazione fisica degli avversari) e che
semmai – a voler ritenere avvenuti gli incontri con Bontate da lui
costantemente negati – cercò di contrastarlo. Il Collegio rileva che la Corte
territoriale ha ritenuto che l’incontro sia avvenuto (su ciò si tornerà in
seguito) e che sia significativo sotto il profilo della asserita
partecipazione.
Gli argomenti addotti a sostegno
dalla Corte palermitana non sono affetti dal vizio di manifesta illogicità, né
dal testo del provvedimento impugnato emerge l’evidenza della prova che
rincontro non sia avvenuto.
Ne consegue che lo scontro con
Bontate, che il giudice di appello ha ritenuto essersi verificato in quella
occasione, non vale ad escludere i fatti su cui esso ha basato le proprie
conclusioni; ma, in ogni caso, esso è stato utilizzato dal medesimo giudice
come dimostrativo dell’avvenuta dissociazione. Per dimostrare l’erroneità della
sentenza, il ricorrente si riferisce anche alla vicenda Sindona, osservando che
la conclusione positiva stava a cuore a Bontate e ad altri uomini di Cosa
Nostra, e che, per contro, la stessa Corte d’Appello ha riconosciuto che Bontate
non aveva sollecitato il sen. Andreotti ad intervenire, come sarebbe stato
logico nel caso di effettiva esistenza di un patto di scambio tra i due.
Un primo problema – proprio sul
piano logico qui considerato – consiste nello stabilire che cosa si debba
intendere per "intervento", in quanto che la sentenza ha spiegato
anche che l’allora Presidente del Consiglio non si disinteressò totalmente
della vicenda, dal momento che incaricò l’on. Franco Evangelisti e il sen.
Gaetano Stammaù di esaminare un progetto di salvataggio, e considerato anche
che, proprio la carica all’epoca ricoperta, suggeriva di evitare una sua
esposizione maggiore.
D’altra parte – e ciò costituisce
il secondo problema – la sentenza impugnata, sia pure nel valutare altre
vicende, ha ritenuto che talvolta Andreotti potesse avere promesso il proprio
interessamento senza poi farlo seguire da interventi concreti.
Infine, la Corte territoriale
correttamente non ha valutato la vicenda come elemento a carico dell’imputato,
mancando la prova che Bontate avesse rivolto ad Andreotti una richiesta di
interessamento e non avendo quest’ultimo compiuto alcun intervento
concretamente idoneo a salvare il finanziere siciliano.
Ma la mancanza della prova di un
fatto non è – come in questo caso sostanzialmente vorrebbe il ricorrente – la
dimostrazione del fatto contrario, cioè la prova della insussistenza di
rapporti tra Andreotti e Bontate.
L’esame, sottoposto dal
ricorrente a questo Collegio, di alcune frasi estrapolate dal testo della
sentenza impugnata (ad esempio: "alla stregua di alcune, pregnanti
indicazioni raccolte, appare piuttosto frutto di un luogo comune la
attribuzione a Cosa Nostra di un determinato orientamento del voto"), non
coglie nel segno, poiché si sostanzia in censure non prospettabili in sede di
legittimità, atteso che il vizio indicato dalla lettera e) dell’art. 606 c.p.c.
attiene alla ricostruzione del fatto nei suoi termini fondamentali e rilevanti,
quindi consiste nel contrasto concettuale che infirma il percorso logico-giuridico
della sentenza si da rendere incomprensibile la ratio decidendi, e non si
riferisce a qualsiasi affermazione, per di più di carattere generale e non
rapportata ad una particolare situazione di fatto.
Ciò che rileva – ai fini della
verifica dell’iter logico della decisione e fatta salva la concreta correttezza
dell’affermazione – è il ritenuto sostegno elettorale, pur nei limiti
evidenziati dalla Corte di Appello.
Quanto poi alle considerazioni
concernenti il rapporto tra il sen. Andreotti e la propria corrente in Sicilia,
il ricorrente si muove su un piano che, da un lato, ricorre al dato storico,
dall’altro, all’apprezzamento delle risultanze processuali, esulando quindi
dalle verifiche consentite al giudice di legittimità.
D’altra parte la Corte territoriale
ha descritto (si legga, ad esempio, il capitolo "Conclusioni") la
rilevanza dei rapporti sicuramente intrattenuti dall’imputato con Salvo Lima,
il suo più importante referente in Sicilia, ritenuto legato ai mafiosi
appartenenti alla corrente moderata di Cosa Nostra, per inferirne che, proprio
grazie ai rapporti con l’uomo politico siciliano, egli aveva intrattenuto
relazioni amichevoli anche con costoro, oltre che con i cugini Salvo, i quali
dominavano in un settore di grande spessore economico e quindi costituente un
notevole centro di potere.
Dalle precedenti argomentazioni
si evince che l’impianto teorico della sentenza impugnata non è manifestamente
illogico, per cui è indispensabile vagliare le ulteriori censure del
ricorrente, risultando gli esaminati motivi del ricorso infondati.
c) Nell’esame del gravame la
Corte ritiene preferibile, per comodità di esposizione, seguire l’ordine delle
censure stabilito dal ricorrente anche se, ragioni di ordine logico,
indurrebbero a posporre l’analisi del terzo motivo che – in teoria – potrebbe
rimanere assorbito in altre statuizioni.
Tale motivo contesta la formula
di assoluzione adottata dalla Corte di Appello in riferimento al periodo
successivo al 1980. Il Tribunale aveva assolto l’imputato da entrambe le
imputazioni (di associazione per delinquere sino al 28.9.1982, di associazione
di tipo mafioso per il periodo successivo) ai sensi del comma 2 dell’art. 530
c.p.p., avendo ritenuto carente o contraddittoria la relativa prova. La Corte
di Appello ha riformato la statuizione relativa al primo periodo, applicando la
prescrizione perché ha ritenuto che l’imputato avesse in tale periodo fatto
parte del sodalizio criminoso, mentre ha confermato la statuizione assolutoria
per quello successivo.
A ciò è pervenuta sul rilievo che
"eventuali e non compiutamente dimostrate manifestazioni di disponibilità
personale del sen. Andreotti successive a tale periodo (cioè al 28.9.1982)
erano state semplicemente strumentali efittizie, comunque non assistite dalla effettiva
volontà di interagire con i mafiosi anche a tutela degli interessi della
organizzazione criminale; anzi, in termini oggettivi era emerso un sempre più
incisivo impegno antimafia, condotto dall’imputato nella sede sua propria
dell’attività politica, per cui, in relazione al periodo in questione,
l’impugnata statuizione assolutoria, che aveva negato la sussistenza della
contestata condotta associativa, doveva essere confermata".
Il ricorrente assume che dallo
stesso testo della sentenza risulta l’errore in cui essa è incorsa, e spiega
che, avendo negato la sussistenza del reato, avrebbe dovuto pronunciare
l’assoluzione ai sensi del comma 1 dell’art. 530 c.p.p.. La censura, di cui il
P.G. ha eccepito in udienza l’inammissibilità, è in ogni caso infondata.
Il P.G. sostiene che la formula
assolutoria adottata dal Tribunale è passata in giudicato e, quindi, che non è
impugnabile la statuizione meramente confermativa della Corte di Appello.
Inoltre, rileva l’inapplicabilità dell’art. 619 c.p.p. perché il vizio denunciato
non riguarda esclusivamente la motivazione della sentenza, ma ricade sul
dispositivo, con la conseguenza che si renderebbe necessaria una nuova
valutazione di merito.
Il ricorrente obietta che la sua
doglianza è originata proprio dalla statuizione della sentenza di secondo
grado, la quale è parzialmente difforme da quella del Tribunale, che egli non
era legittimato ad impugnare.
Questa Corte ritiene corretta la
tesi del P.G., in quanto la difformità tra le due sentenze concerne
esclusivamente il periodo precedente, mentre nulla è stato modificato per il
periodo successivo al 1980.
In ogni caso non è condivisibile
l’assunto che la Corte di Appello abbia ritenuto dimostrata la prova positiva
della insussistenza del fatto contestato per il periodo in esame.
La formula assolutoria
"perché il fatto non sussiste" presuppone appunto che nessuno, tra
gli elementi integrativi della fattispecie criminosa contestata, risulti
provato, e si applica quando l’assenza della condotta delineata dalla norma incriminatrice
travolge in radice la configurabilità del reato.
Ma ciò non è accaduto nella
specie, non solo per quanto statuito da questa Corte con riferimento al ricorso
della Procura Generale palermitana, ma già sulla base delle sole affermazioni
della Corte territoriale.
E, invero, è sufficiente
considerare la frase sopra testualmente riferita (e comunque la valutazione
globale della Corte di Appello è nel senso indicato) per inferirne che la
sentenza impugnata non ha ritenuto positivamente accertata la dissociazione, ma
ha giudicato carente e non perspicuamente significativa !a prova di
comportamenti agevolativi in epoca successiva al 1980. Ne discende che ha
applicato correttamente il comma 2 dell’art. 530 c.p.p., il quale regola le
ipotesi di assoluzione perché la prova è mancante, carente oppure
contraddittoria, e non il precedente comma 1 – che invece disciplina ipotesi
diverse, tra cui appunto quella della provata insussistenza del fatto.
d) II quarto motivo si sostanzia
in tutta una serie di censure. In primo luogo, affronta sul piano teorico il
tema dei limiti della eccepibilità in cassazione del vizio di motivazione, che
il ricorrente assume doversi estendere al "contenuto informativo"
della sentenza impugnata, di modo che l’esame della sua motivazione consenta di
controllare anche il processo, nel senso che la prima deve riflettere i
risultati del secondo.
Il ricorrente esclude che,
mediante tale controllo, si possa verificare una "caduta" nel merito,
perché con esso la Corte di Cassazione si deve limitare ad accertare solo se la
sentenza abbia tenuto conto di quanto offerto dal processo senza che ciò
implichi un controllo sull’impiego del materiale probatorio, la cui
valutazione, operata dal giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità.
Secondo il ricorrente
l’applicazione di questi principi deve comportare, nell’ipotesi di sentenza di
primo grado assolutoria riformata "in pejus" dal giudice di appello
(nel cui giudizio sono mancati motivi di impugnazione dell’imputato privo di
titolo e interesse a ricorrere), che la Corte di Cassazione possa essere
chiamata a verificare se la sentenza di secondo grado abbia dato conto delle
prove favorevoli all’imputato e delle indicazioni in tal senso contenute nella
eventuale memoria difensiva.
Il Collegio ha già affrontato
questa problematica in sede di esposizione dei principi giuridici generali,
pervenendo alla conclusione che il giudice di appello peccherebbe di omessa
motivazione solo ove non considerasse il contenuto informativo
della sentenza di primo grado e quanto rappresentato nella eventuale memoria
difensiva dell’imputato.
Quindi il ricorrente ha indicato
e analizzato i singoli riferimenti concreti al vizio denunciato – a cominciare
dall’episodio relativo all’incontro con Bontate, da lui sempre negato e che
invece la Corte di Appello ha ritenuto effettivamente avvenuto nella primavera
del 1980.
Tale convincimento è stato
ingenerato in essa dalla ritenuta riscontrata credibilità di Marino Mannoia, il
quale lo ha attestato.
Il ricorrente ricorda che,
secondo la sentenza impugnata, ci sarebbero stati due incontri strettamente
collegati (collegamento che è stato riconosciuto anche dalla sentenza del
Tribunale): il primo nella tenuta degli imprenditori Costanzo "la
Scia", presso Catania, al fine di stabilire la linea da adottare nei
confronti dell’on. Mattarella; il secondo in una villetta appartenente ad
Inzerillo, in prossimità di Palermo, per parlare dell’avvenuto omicidio
dell’uomo politico.
Ma il Tribunale, inquadrata
l’epoca in cui sarebbe avvenuto il primo incontro (tra il 15-20 giugno e la
prima settimana di luglio del 1979) sulla base delle dichiarazioni di Angelo
Siino, lo aveva negato valorizzando tutta una serie di elementi forniti da
costui e dall’imputato e con considerazioni logiche (ad esempio: l’imputato –
all’epoca Presidente del Consiglio – era sempre scortato), che impedivano di
ritenere che il sen. Andreotti si fosse recato segretamente in Sicilia nel
periodo indicato.
Poi, negato il primo, il
Tribunale aveva considerato il secondo incontro non giustificato (proprio per
la loro interconnessione) e comunque aveva ritenuto non riscontrate le
dichiarazioni assertive di Marino Mannoia.
Invece, la sentenza impugnata,
che l’imputato afferma essere indissolubilmente legata al postulato della
credibilità di Mannoia (costui aveva riferito del primo incontro "de
relato", del secondo per conoscenza diretta), ha irragionevolmente
spezzato il collegamento tra i due incontri, affermando che in ogni caso la
eliminazione del primo non influirebbe sulla dimostrazione della sussistenza
del secondo.
Quindi la Corte di Appello, non
essendo contestabile il nesso tra i due incontri, ha affermato che il secondo
suggerisce logicamente un pregresso contatto tra l’imputato e Bontate e, in tal
modo, secondo il ricorrente, ha recuperato e riaffermato la credibilità di
Mannoia.
Ritiene il Collegio che, in
conseguenza della sintetizzata prospettazione, il primo problema da affrontare
debba essere la valutazione compiuta dalla Corte palermitana circa
l’attendibilità di costui e, di seguito, circa la credibilità delle sue
dichiarazioni.
In proposito la Corte
territoriale ha recepito la valutazione del Tribunale circa la
"sperimentata attendibilità personale del collaboratore" e il
"giudizio ampiamente positivo" formulato sul tema dal medesimo.
Inoltre, ha autonomamente
vagliato la personalità di Marino Mannoia e le sue dichiarazioni per verificare
che non fossero "condizionate da una preconcetta avversione nei confronti
del sen. Andreotti ovvero dall’intento di accreditare la propria
collaborazione, arricchendola di un contributo particolarmente importante qual
è indubbiamente quello in questione".
All’esito, ha attribuito
credibilità alle dichiarazioni del collaboratore dando una risposta – che può
anche non essere condivisa, implicando ricorso a massime di esperienza e ad
apprezzamenti di merito, ma che in sede di legittimità non è soggetta a censura
– alle perplessità sollevate dal primo giudice a proposito di taluna di esse.
Come premesso nella parte
generale, questa Corte non è chiamata a stabilire quale sia preferibile tra le
diverse argomentazioni addotte dai due giudici di merito a supporto delle
rispettive decisioni, ma ha cognizione limitata alla verifica della
conseguenzialita logica della motivazione della sentenza di appello e deve
effettuare il relativo controllo basandosi sui consueti canoni e tenendo
presente che, una volta stabilito che la motivazione è razionale, la sentenza
supera positivamente il vaglio di legittimità anche in presenza di possibili
soluzioni diverse e alternative pur dotate di uguale forza logica.
Sul piano generale e teorico, che
è quello qui proposto dallo stesso ricorrente, che poi passerà all’esame
analitico e specifico di queste vicende, i necessari riscontri alle
dichiarazioni del collaborante sono stati ravvisati dalla Corte di Appello
nelle dichiarazioni di un altro collaborante, Antonino Giuffré (riferì di avere
appreso da Michele Greco di incontri che sarebbero avvenuti tra l’imputato e
Stefano Bontate e di contrasti tra essi intervenuti), definite dalla medesima
non prive di efficacia dimostrativa e del teste assistito Giuseppe Lipari
(riferì di avere appreso da Bernardo Provenzano dell’esistenza nell’ambito di
Cosa Nostra di voci circa incontri di Bontate con l’imputato).
Quanto ai riscontri indiretti
(ricavati, tra l’altro, dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta e di Giovanni
Brusca) e ai riscontri logici alle dichiarazioni di Mannoia che la Corte di
Appello, cui competeva valutarne la rilevanza probatoria, ha ritenuto di
individuare, soccorrono le considerazioni di carattere generale poco sopra
vedute, che dovranno essere poi integrate con l’analisi dei singoli punti per
verificare la razionalità delle singole trattazioni.
Non inducono a diversa statuizione
le osservazioni del ricorrente circa l’utilizzo da parte della Corte di Appello
del concetto di compatibilità. E’ certamente vero che la compatibilità di un
accadimento con altri episodi o situazioni non vale a giustificare un giudizio
di certezza in ordine al fatto oggetto di prova, dovendo quest’ultima essere
reperita aliunde. Ma è indubbio che l’affermazione di compatibilità costituisce
pur sempre un elemento logico di utile supporto alla prova dell’effettività
dell’accadimento, la cui non compatibilità varrebbe invece drasticamente ad
escludere.
Ne, consegue ai fini della
decisione, che è determinante la valenza che la motivazione oggetto di
controllo ha di volta in volta attribuito all’elemento della compatibilità,
fermo restando -alla stregua di quanto sopra precisato – che esso ben può
costituire conferma di un fatto altrimenti accertato, ma che da solo è privo di
significato probatorio.
Sul piano teorico e generale, ora
in discussione, rimpianto motivazionale della sentenza non è, quindi, tacci
abile di gravi omissioni, né di evidenti irrazionalità, per cui supera
agevolmente il vaglio di legittimità.
Ma a questo punto, seguendo la
prospettazione del ricorrente, occorre procedere all’esame analitico delle
singole risultanze processuali con riferimento alle vicende sopra indicate per
verificare se, anche riguardo ad esse la motivazione della Corte di Appello sia
conforme ai canoni logici comunemente applicati.
In relazione al primo incontro
essa non ha ritenuto rilevante la mancata prova del viaggio dell’imputato in
Sicilia giustificandola con asserite carenze investigative e attribuendole
significato neutro.
E’ evidente sul piano logico che,
ove tale prova fosse stata acquisita e fosse stata accertata la coincidenza
temporale tra viaggio e incontro, la tesi accusatoria fondata sulle
dichiarazioni "de relato" di Mannoia (il quale ha riferito
rivelazioni avute da Stefano Bontate) avrebbe ricevuto un riscontro di valore
probabilmente decisivo.
Per contro, su tale piano può
destare perplessità la circostanza che l’imputato abbia effettuato un
qualsivoglia viaggio senza lasciarne traccia (all’epoca rivestiva la carica di
Presidente del Consiglio, con i relativi impegni, l’onere di reperibilità, la
presenza della scorta, ecc).
Resta, però, la considerazione
insuperabile in questa sede che la Corte territoriale ha offerto una
spiegazione del proprio convincimento non manifestamente irrazionale e fondata
su apprezzamenti di merito (si veda, a titolo di esempio, il riferimento ad un
viaggio a Firenze sicuramente effettuato da Andreotti per ragioni del tutto
legittime e non riguardanti questo processo, di cui pure la documentazione era
carente) prospettando sostanziai niente un viaggio di natura
"riservata" e gestito mediante canali e secondo modalità "non
istituzionali" e per questa ragione privo di quella documentazione che
altrimenti sarebbe stato facile reperire.
Superato questo ostacolo, la
sentenza impugnata ha ritenuto di ravvisare i necessari riscontri nelle
dichiarazioni del collaboratore Angelo Siino, a suo tempo esaminate anche dalla
sentenza di primo grado, che però non le aveva considerate idonee allo scopo.
La Corte territoriale, pur
premettendo che le dichiarazioni di costui avevano tratto spunto da quelle, a
lui note, di Marino Mannoia, ha poi indicato le ragioni che l’hanno convinta a
ritenere attendibile il collaborante e credibili le sue dichiarazioni.
Di esse la difesa argomenta anche
in questa sede la falsità ricorrendo, però, a considerazioni indissolubilmente
connesse ad apprezzamenti di merito. Pertanto occorre ancora una volta ribadire
che, quanto alle affermazioni di attendibilità del collaboratore e di
credibilità delle sue dichiarazioni, la motivazione della sentenza rimane entro
i limiti degli apprezzamenti demandati al giudice di merito, il cui solo onere
è di dare conto razionale del proprio convincimento.
Semmai la debolezza del valore
probatorio delle dichiarazioni di Siino deriva dalla circostanza, ovviamente
riconosciuta anche dalla Corte territoriale, che costui ha spiegato di non
avere visto personalmente Andreotti, pur essendo egli in loco, ma di aver
saputo della sua presenza da altra persona (un sorvegliante detto "u
cchiu") e di averne poi avuta, a sua richiesta, sostanziale conferma da
parte dello stesso Bontate.
Quanto alla collocazione
temporale dell’episodio, oggetto di attenta disamina da parte del giudice di
appello e della severa critica del ricorrente, occorre considerare che Siino ha
fornito una serie di riferimenti su cui la sentenza impugnata si è dilungata
negando loro il requisito detta certezza ed esprimendo una serie di
considerazioni che, anche in questo caso, possono non essere condivise perché
fanno leva su squisite considerazioni di merito, come tali sempre contestabili
(non è disagevole prospettare verità alternative), ma che proprio per questo
non possono essere censurate con successo, E infatti, per stigmatizzarle, il
ricorrente è costretto ad "entrare nel merito" con argomentazioni e
apprezzamenti tesi appunto a contrastare quelli privilegiati dalla sentenza ma
che, pur essendo essi stessi logici, appaiono inidonei a manifestarne la
irrazionalità.
Del pari non palesemente
illogiche sono le considerazioni svolte dalla Corte palermitana sulle
risultanze delle agende e dei libri dell’imputato per inferirne la
compatibilità dei suoi impegni con l’epoca del ritenuto viaggio in Sicilia
finalizzato all’incontro in esame.
D’altra parte è opportuno
aggiungere due considerazioni: in primo luogo, l’eventuale incertezza sulla
effettività dell’incontro con Bontate non esclude che esso possa essere
avvenuto perché la prova incerta o inadeguata di un fatto non significa
negazione categorica di esso; in secondo luogo, a ragione la sentenza ha
affermato che la insussistenza di questo incontro non varrebbe a travolgere
automaticamente il secondo.
E’ indubbio che, sotto il profilo
logico, un colloquio poi trasformatosi in scontro avente ad oggetto un
avvenimento di rilievo come l’omicidio dell’on. Mattarella lascia presupporre
che il comportamento da adottare nei confronti di quell’uomo politico fosse
stato precedentemente esaminato e discusso tra gli stessi interlocutori.
Ciò in definitiva è stato
riconosciuto pure dalla sentenza impugnata, anche se in termini concettualmente
più sfumati rispetto a quelli perentori del Tribunale.
Conclusivamente è opportuno
ribadire che, sul piano strettamente logico, non può ritenersi che la mancata
prova certa del primo incontro secondo i tempi e i modi indicati dalla sentenza
impugnata induca ad affermare, come conseguenza razionalmente necessitata, che
non vi fosse stato alcun contatto tra i predetti interlocutori e, quindi, essa
non esclude a priori e senza apposita verifica il secondo incontro.
Ne deriva l’ulteriore conseguenza
che non è viziata la motivazione in esame laddove afferma che la dimostrazione
dell’incontro successivo attribuisce significato alla dichiarazione " de
relato " di Mannoia concernente il primo e ne costituisce un riscontro
logico.
Di tutto ciò sembra essere ben
consapevole lo stesso ricorrente che, infatti, non si limita a negare il
secondo incontro sulla base della mera affermazione della insussistenza del
primo, ma affronta in modo approfondito e specifico anche il relativo tema.
Piuttosto egli non considera che,
nella prospettazione della Corte di Appello, l’incontro con Bontate, che essa
ritiene essere avvenuto nell’aprile del 1980, non è solo uno degli elementi da
cui il giudice di secondo grado ha tratto il convincimento della partecipazione
nel reato associativo, ma ne costituisce anche la prova della cessazione, cioè
del distacco dell’imputato dall’ala moderata di cui Bontate era un esponente di
vertice.
Ne consegue che la negazione
della sussistenza di questo incontro non varrebbe solo ad indebolire la tesi
accusatori ma, qualora questa resistesse in forza di altri elementi probatori,
paradossalmente eliminerebbe anche la prova della dissociazione dell’imputato.
Il convincimento della Corte
territoriale circa la effettività del secondo incontro con Bontate è basato
sulle dichiarazioni di Marino Mannoia, il quale è stato esaminato come imputato
di reato connesso, con conseguente applicabilità della disciplina dell’art.
192, comma 3 c.p.p..
Il giudice di appello, fatto
riferimento al giudizio complessivamente positivo del Tribunale, si è espresso
favorevolmente in ordine all’attendibilità del collaboratore di giustizia nel
rispetto di quei criteri costantemente affermati dalla giurisprudenza di
legittimità, di cui si è fatta precedente menzione.
Il ricorrente esamina e contesta
ciascuna delle affermazioni rese in tal senso dalla sentenza impugnata. Ma, a
parte il rilievo che la razionalità di una motivazione non deve essere valutata
soffermandosi criticamente sui suoi singoli aspetti espungendoli dal contesto
globale in cui sono stati inseriti, dal momento che questo controllo non può
prescindere dalla valutatone della sua tenuta logica complessiva, è agevole
rilevare che, seguendo fino in fondo un siffatto ragionamento e dando pratica
attuazione a tali argomentazioni, diverrebbe estremamente difficile, se non
addirittura impossibile, affermare in concreto 1* attendibilità di qualsiasi
collaborante.
D’altra parte, considerare un
collaboratore di giustizia attendibile non significa ritenere provati tutti i
fatti da lui riferiti, essendo necessario compiere due ulteriori valutazoni
allo scopo di accertare che le sue dichiarazioni siano intrinsecamente
credibili e che trovino riscontro in altri elementi probatori indipendenti
acquisiti al processo.
Ciò implica ancora una volta che
il giudizio di attendibilità attiene in generale alla persona e non esclude che
qualcuna delle affermazioni specifiche del collaborante, per fallanza di
conoscenza o di memoria o per altra ragione, non risulti veritiera; proprio per
questo l’interpretazione giurisprudenziale ritiene necessarie le due ulteriori
verifiche di cui si è detto.
Per concludere sul punto, va
ancora ribadito che, comunque, il tema implica indispensabili apprezzamenti di
merito (e difatti anche in questo caso le argomentazioni del ricorrente sono
improntate a valutazioni di fatto) su cui il giudice di legittimità non è
chiamato a pronunciarsi ove, come nella specie, il ragionamento della sentenza
impugnata non sia affetto da manifesta irrazionalità.
Considerazioni del tutto analoghe
valgono per quanto riguarda la credibilità intrinseca delle dichiarazioni
accusatorie del collaborante. Disamina più approfondita meritano gli asseriti
riscontri.
Il primo di essi (secondo
l’ordine prescelto dalla sentenza impugnata) è costituito dalle dichiarazione del
neo collaboratore (è stato esaminato nel corso del giudizio di appello)
Antonino Giuffré, che ha riferito di avere appreso da Michele Greco di incontri
– e anche di scontri- che vi sarebbero stati tra Andreotti e Bontate.
A questo riscontro è stato attribuito
significato molto limitato dalla stessa sentenza, dal momento che essa recita
testualmente: tenuto conto che l’episodio era stato oggetto di ampio dibattito
nel corso del primo grado del giudizio e che, inevitabilmente, era stato
riportato dai mezzi di comunicazione, si deve riconoscere che la genericità
delta nuova propalazione non può non menomare la efficienza dimostrativa della
stessa, del resto frutto di una conoscenza solo indiretta, posto che, a tutto
volere concedere, neppure il Greco, asserita fonte del Giuffrè, era portatore
di cognizioni dirette, non risultando fra i presenti a quella riunione.
Il secondo riscontro è stato
ravvisato nelle dichiarazioni di Giuseppe Lipari, il quale ha riferito di voci
diffuse in seno al sodalizio mafioso.Ora non è dubbio che la eventuale presenza
e partecipazione attiva di un personaggio qual è il sen. Andreotti ad un
incontro del tipo di quello in esame fosse circostanza rilevante per l’ambiente
mafioso e, quindi, oggetto di discussioni e propalazioni.
E’ ben vero che, anche se il
riscontro non deve essere costituito da elementi idonei a provare autonomamente
il fatto, le semplici voci, pur se logicamente attendibili, non assurgono a
dignità di riscontro come preteso dal comma 3 dell’art. 192 c.p.p., in quanto
esso deve sostanziarsi in un fatto certo da cui potere logicamente dedurre la
sussistenza del fatto oggetto di prova e del suo autore. Tuttavia esse
costituiscono pur sempre un indizio, anche se generico e di significato
modesto.
La Corte di Appello ha ravvisato
un ter2o riscontro nelle dichiarazioni di Tommaso Buscetta. Orbene, non è
illogico ricercare – come appunto ha fatto la Corte territoriale – la prova
della conoscenza e dei rapporti intercorsi tra il sen. Andreotti e Bontate ove
ciò serva a meglio definire, integrare e comprendere il quadro probatorio.
Le dichiarazioni di Buscetta
valgono a confermare un quadro generico, indicativo sul pian indiziario della
verosimiglianza e probabilità della effettività del singolo episodio oggetto di
prova.
A prescindere dal problema
relativo all’attendibilità di Buscetta, sollevato dal ricorrente ma con
riferimento al quale valgono le medesime considerazioni esposte a proposito
dell’attendibilità di Mannoia e sul quale si tornerà in seguito, ciò che appare
rilevante è la considerazione che, ancora una volta, la Corte di Appello è
pervenuta alla conclusione che le dichiarazioni di Buscetta dimostrino la
esistenza di quei singolarissimi rapporti (tra l’imputato e i vertici mafiosi
con particolare riferimento a Bontate e qui soprattutto a Badalamenti), che
costituiscono il necessario presupposto dell’episodio narrato dal Marino
Mannoia.
Ha, cioè, attribuito alle
dichiarazioni di Buscetta il valore non di un riscontro specifico e
individualizzante, ma di un indizio, di per se labile, e pur sempre
significativo perché inserito in un quadro di riferimento più ampio e
articolato.
Neppure al riguardo, dunque, è
ravvisabile un vizio di motivazione in quanto non è irrazionale il
convincimento basato su una serie di elementi nessuno dei quali è dotato di
efficacia probatoria autonoma ma che acquistano pregnante significato se
vagliati in connessione diretta tra loro e interpretati in modo da trame
deduzioni razionalmente coerenti.
Il quarto riscontro è offerto –
sempre nell’impostazione del giudice di appello – dalle dichiarazioni di
Giovanni Brusca, a proposito dell’attendibilità del quale valgono le medesime
argomentazioni prospettate per Buscetta.
Brusca ha riferito di avere
conoscenza soltanto indiretta dei rapporti tra Andreotti e il gruppo
Bontate/Badalamenti, quindi anche costui ha offerto un elemento di per se certo
non decisivo ma efficacemente valutabile in unione agli altri.
L’ultimo riscontro è stato
ravvisato nelle dichiarazioni rese da Antonino Mammoliti, secondo cui Stefano
Bontate fece un favore ad Andreotti intervenendo presso Girolamo Piromalli,
esponente di vertice della ’ndrangheta calabrese, per far cessare le estorsioni
in danno del petroliere laziale Bruno Nardini.
Ancora una volta manca il riferimento
specifico e concreto all’incontro tra Andreotti e Bontate nella primavera del
1980 per discutere dell’omicidio Mattarella, ma si tratta pur sempre di un
episodio utile a definire un quadro indiziario di carattere generale e teso a
dimostrare la sussistenza di rapporti tra Andreotti e i vertici dell’ala
moderata di Cosa Nostra.
E’ noto che i riscontri debbono
riguardare il fatto da provare e non le singole circostanze e che, come si è
detto, quelli indicati dalla Corte di Appello possono valere a confermare un
quadro generale relativo all’esistenza di rapporti tra Andreotti e Bontate, nel
quale razionalmente inserire l’incontro in discussione.
Nel valutare i riscontri occorre
tenere sempre presente che essi non debbono rappresentare la dimostrazione
diretta del fatto da riscontrare, perché altrimenti ne costituirebbero una
prova autonoma che renderebbe superflue ulteriori analisi e valutazoni.
Pertanto è sufficiente che da
essi si snodi un percorso logico idoneo a confermare la veridicità delle dichiarazioni
oggetto di riscontro. La valutatone conseguente rientra nella competenza del
giudice di merito ed è, quindi, soggetta ai noti limiti di censurabilità.
Inoltre va considerato che la
Corte di Appello ha, non certo irrazionalmente, valutato i rapporti di cui
sopra alla stregua di informazioni
riconducigli ad un patrimonio conoscitivo comune agli associati de) sodalizio
circa l’esistenza di rapporti tra l’imputato e i vertici dell’ala moderata di
Cosa Nostra.
L’ultimo episodio sopra citato
(quello relativo al petroliere Nardini) è stato accuratamente sviscerato dal
ricorrente, il quale rileva trattarsi di accadimento completamente diverso
rispetto all’incontro con Bontate; che i due episodi sono stati riferiti da
imputati di reato connesso; che quindi debbono essere esaminati separatamente e
non possono essere utilizzati l’uno come riscontro dell’altro.
Come anticipato nella premessa
generale, sul piano teorico due chiamate in correità provenienti da soggetti
diversi possono essere utilizzate come riscontri reciproci ed episodi diversi
possono essere valutati al fine di provare il quadro generale in cui ciascuno
di essi si inserisce.
La stessa sentenza ha indicato
una serie di ragioni che hanno indotto la Corte dapprima a valutare con grande
cautela le dichiarazioni di Mammoliti, ma poi a dare loro credito e a svalutare
nel contempo la credibilità di Nardini, le cui affermazioni sono state smentite
da Vincenzo Riso.
Come avviene ogni volta che si
compiono apprezzamenti di merito, anche riguardo all’episodio in esame le varie
argomentazioni della Corte territoriale non sono ineccepibili.
Cosi, ad esempio, quando ha
attribuito a Nardini incontestabili legami con ambienti politici di matrice
democristiana, legami affermati in base ad un suo convincimento logico
piuttosto che mediante indicazione di fatti accertati, oppure a proposito dei
suoi certi rapporti con l’imputato, anche questi, almeno con riferimento
all’epoca dei fatti, intuiti piuttosto che dimostrati.
Ma anche in questo caso la
vantazione della tenuta della scelta interpretativa della Corte territoriale va
ancorata alla coerenza complessiva del tessuto motivazionale piuttosto che
all’esame analitico delle singole trame che lo compongono.
Il vizio censurabile nel giudizio
di legittimità consiste, rispettivamente, nell’assenza di motivazione su un
punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito e non già nella
mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della
decisione che pur sia stato trattato, sebbene in un’ottica diversa, dalla
sentenza impugnata, la quale abbia dato una risposta anche solo implicita
all’osservazione della parte, oppure nella frattura logica evidente tra una
premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono.
Nessuna di queste due ipotesi
inficia la motivazione sul punto della sentenza.
Essa ha considerato le
argomentazioni di segno contrario sia del Tribunale sia della difesa, ha posto
in rilievo i punti in cui non ha condiviso le tesi sostenute dall’accusa ed è
pervenuta alla sua ricostruzione della vicenda e alla valutatone della medesima
secondo apprezzamenti squisitamente di merito e, quindi, insindacabili, avendo
esaminato gli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e avendo
esplicitato l’iter logico seguito in modo coerente ed esaustivo.
Ancora con il quarto motivo il
ricorrente contesta vigorosamente l’attendibilità di Tommaso Buscetta. A tale
proposito giova osservare che questo collaboratore di giustizia è stato
ritenuto credibile anche in altre vicende processuali con sentenze passate in
giudicato e che il giudizio positivo espresso dalla sentenza impugnata trova
fondamento su considerazioni di merito sulle quali questa Corte non è
legittimata a soffermarsi.
Non le è consentito, ad esempio,
indugiare sulla vicenda relativa all’omicidio del giornalista Pecorelli, decisa
in altro processo, anche se può rilevare che è indubbio che la conclusione del
medesimo ha smentito le propalazioni di Buscetta; ma va ricordato – ed è la
considerazione che rileva ai fini di questo processo – che anche in quella
occasione le Sezioni Unite di questo Supremo Collegio negarono di poter
rimettere in discussione l’apprezzamento fattuale del giudice di merito sulle
circostanze caratterizzanti la credibilità soggettiva e l’intrinseca
affidabilità del racconto del collaboratore e delle fonti primarie (si trattava
di dichiarazione "de relato") per attestarsi sulla rilevata carenza
di riscontri individualizzanti.
Considerazioni del tutto analoghe
valgono per le dichiarazioni di Buscetta attinenti all’atteggiamento che Cosa
Nostra avrebbe tenuto in relazione al sequestro dell’on. Aldo Moro.
Invece, va esaminata la
motivazione che la sentenza ha offerto in ordine alla credibilità intrinseca e
alla riscontrabilità delle affermazioni del collaboratore significative ai fini
di questo giudizio.
Indubbiamente rilevante è
l’incontro che vi sarebbe stato tra Andreotti e Badalamenti allo scopo di
aggiustare il processo penale a carico di Filippo e Vincenzo Rimi, ritenuto utile
dalla sentenza impugnata a provare l’esistenza di un patto di scambio tra
Andreotti e i vertici mafiosi e a confermare indirettamente il rapporto –
quindi gli incontri – tra il primo e Bontate.
L’episodio qui in esame
certamente non prova l’incontro, ma può valere per dimostrare l’esistenza di
rapporti con i vertici del sodalizio e quindi costituire ulteriore indizio di
quelli con Bontate.
Il tentativo di influire
sull’esito di un processo a carico di autorevoli esponenti di Cosa Nostra, tali
da interessare i vertici del sodalizio criminoso, rappresenta, sul piano
logico, un accadimento oggettivamente idoneo a dimostrare un solido legame con
il medesimo.
Anche per questa vicenda la Corte
palermitana ha vagliato la difforme ricostruzione del Tribunale ed ha
considerato le argomentazioni della difesa, fornendo una interpretazione delle
dichiarazioni di Buscetta, fondata sulla valutatone, tra l’altro, delle sue
capacità lessicali e della loro influenza sul suo pensiero, interpretazione che
il ricorrente contesta con argomenti che, in definitiva, si sostanziano nella
evidente esortazione rivolta a questa Corte perché, attraverso la enucleazione
di via motivazionali, riesamini il merito della relativa decisione.
Pure nell’analizzare questa
vicenda il Collegio è costretto a ripetersi osservando che la Corte
territoriale ha espresso una motivazione contestabile fin che si vuole quanto
agli apprezzamenti di merito, ma non affetta né da omissioni di elementi
fattuali rilevanti ai fini della decisione, né da fratture logiche nella
ricostruzione dei medesimi e nell’espressione delle conseguenti valutazoni.
In definitiva, essa ha spiegato
che l’episodio, indirettamente riferito dal collaboratore, non assicura affatto
la prova della effettività di un intervento dell’imputato volto a pilotare quel
verdetto, ma che non si può obliterare che le propalazioni – sia pure indirette
– di altro storico collaboratore, della cui attendibilità non vi è ragione di
dubitare, anche per la risalente allusione alla asserita vicinanza di Andreotti
ai mafiosi, assicurano, in ogni caso, una autonoma conferma della esistenza di
quei singolarissimi rapporti, che costituiscono il necessario presupposto
dell’episodio narrato da Marino Mannoia.
Ha cioè ritenuto indubitabile
che, sfrondate dalle parti inficiate dalle incertezze, le dichiarazioni di
Buscetta attestino, comunque, che egli ebbe ad apprendere dai più importanti
capi dello schieramento "moderato" di Cosa Nostra – Bontate e
Badalamenti – che costoro avevano intrattenuto rapporti, quanto meno indiretti,
con Andreotti e che in una occasione, in relazione al processo Rimi, lo stesso
Badalamenti avesse personalmente incontrato l’imputato in compagnia del proprio
cognato, Filippo Rimi, e di uno dei cugini Salvo.
Ancora non irrazionalmente,
prendendo spunto proprio dalla svolgimento di questa vicenda, la Corte di
Appello l’ha ritenuta non incompatibile con l’attivarsi soltanto simulato di
Andreotti per acquisire, senza sporcarsi le mani, benemerenze presso i mafiosi.
L’ipotesi di un falso impegno
dell’imputato può essere ritenuta non manifestamente illogica, anche se occorre
rilevare che non risulta concretamente provata in mancanza di precisi
riferimenti fattuali.
Inoltre la Corte palermitana, nel
riferirsi alle indicazioni fornite da altri collaboratori, ha affermato che la
coralità delle stesse deve essere valutata come una conferma del particolare
impegno profuso – in particolare, proprio dal Badalamenti, cognato di Filippo
Rimi – per un esito favorevole di quella vicenda processuale.
Si ricordi, in proposito, che la
giurisprudenza ha riconosciuto la rilevanza di notizie che circolano
all’interno di un ambiente determinato e circoscritto e che vengono
autonomamente apprese dai suoi aderenti.
Un altro dei punti nodali della
sentenza stigmatizzato con il quarto motivo è costituito dai rapporti di
Andreotti con i cugini Ignazio e Antonino (Nino) Salvo, negati dall’imputato e
affermati dalla Corte di Appello, che li ha inseriti nel quadro delle relazioni
da lui intrattenute con esponenti dell’ala moderata di Cosa Nostra.
La sentenza impugnata ha
inizialmente travolto, considerandoli indizi che perdono efficacia
determinante, i fatti che il Tribunale, nel pervenire sostanzialmente alla
medesima conclusione circa l’esistenza dei rapporti in esame, aveva ritenuto
provati e probanti.
Tuttavia li ha poi almeno
parzialmente recuperati riconoscendo che essi possono assumere una più modesta
e, in definitiva, pleonastica funzione corroborativa di quanto aliunde e con
mezzi assai più pregnanti accertato, e in tal modo ha consentito che la propria
motivazione venisse integrata da quella del primo giudice.
Questo si era basato
principalmente sui seguenti elementi: 1) la riferibilità all’imputato di un
numero telefonico annotato su una agenda di uno dei cugini Salvo, agenda che
non era stata oggettivamente rinvenuta; 2) l’utilizzazione dell’autovettura
della Satris (società riferibile ai Salvo), procurata, peraltro, da Lima che
metteva a disposizione dell’imputato il suo autista; 3) l’impressione di familiarità
che i testi Vittorio De Martino e Sebastiano Conte avevano ricavato
dall’atteggiamento tenuto da Andreotti e da Antonino Salvo nel corso del
ricevimento svoltosi il 7 giugno 1979 presso l’Hotel Zagarella (in particolare,
dopo averlo inizialmente svalutato, la Corte di Appello ha poi definito questo
episodio degno di nota); 4) la prova, ritenuta controversa, della vicenda del
regalo del vassoio in occasione delle nozze della figlia di Antonino Salvo con
Gaetano Sangiorgi, prova fondata sulle variegate rivelazioni, riferite da
terzi, dello stesso Sangiorgi; 5) la telefonata all’ospedale civico per informarsi
delle condizioni di salute di Cambria, telefonata i cui contorni sono stati
ritenuti dalla Corte di Appello quanto mai incerti.
Invece la sentenza impugnata ha
fatto leva soprattutto sulle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, secondo il
quale i Salvo, parlandogli di esponenti politici, si riferirono al sen. Giulio
Andreotti in termini di intima confidenza e tali da indurre a ritenere che
potessero contare in qualsiasi momento su di lui.
Il ricorrente contesta
l’attendibilità di Buscetta, ma su questo tema il Collegio si è già espresso:
il giudice di appello ha motivato in termini non irrazionali la propria
convinzione dell’attendibilità del collaborante, salvo poi verificare la
credibilità delle singole affermazioni e la esistenza di validi riscontri.
Al riguardo si rileva che
elementi razionali di riscontro della vicenda in esame sono proprio i fatti
ritenuti tali dal Tribunale e inizialmente sottostimati, ma poi parzialmente
recuperati, dalla Corte di Appello.
Inoltre quest’ultima ha ravvisato
un ulteriore elemento di valido riscontro nell’asserito mendacio dell’imputato.
Anche ciò forma oggetto di censura, ma occorre affermare che, sul piano teorico,
la valutatone della Corte palermitana sul tema del mendacio è corretta in linea
di diritto (confronta: Cass. n. 3481 del 1991, Scarfò) e che, sul piano
concreto, il relativo apprezzamento (positivo o negativo) implica sempre
valutazoni di merito che non possono essere sindacate quando, come nella
specie, siano state esposte in termini non palesemente irrazionali.
Sempre nel quadro dei rapporti
con i cugini Salvo, la Difesa ha fatto ricorso ad argomenti suggestivi per
dimostrare, ad esempio, l’inconcludenza del riferito incontro del sen.
Andreotti con Nino Salvo presso l’Hotel Zagarella.
Ma si tratta, parimenti, di
argomentazioni di merito che non scalfiscono la parte della sentenza in esame
per la ragione che con esse viene prospettata una verità alternativa che è
indubbiamente logica, ma che non esclude la plausibilità e razionalità di
quella prescelta dalla Corte di Appello (non è irrilevante al riguardo la
circostanza, già posta in evidenza dal Tribunale, che il ricevimento fu
organizzato proprio da Nino Salvo il quale ne sopportò anche la spesa).
Ancora, la sentenza impugnata ha
fatto riferimento alle valutazioni del gen. Dalla Chiesa in ordine alla
situazione della corrente Andreottiana in Sicilia e alle attività dei suoi
grandi elettori, oltre che al colloquio tra il generale e l’imputato
risultante, anche se in termini non del tutto concordanti, dal diario del
medesimo e dalle dichiarazioni del figlio Fernando.
Inoltre, ha ricordato le
dichiarazioni di Antonino Giuffré (le cui propalazioni in altra parte della
stessa sentenza si afferma essere necessario valutare prudentemente) secondo
cui, in colloqui tra Michele Greco e Nino Salvo, si disse che Andreotti
costituiva un punto di riferimento e la sola persona cui ci si potesse
rivolgere con una certa fiducia.
Queste dichiarazioni, di cui la
difesa ha contestato la credibilità con argomentazioni che, però, implicano
apprezzamenti di merito e accesso agli arti processuali oltre che al testo
della sentenza, costituiscono ulteriori elementi probatori considerati nella
valutatone della Corte territoriale.
Le medesime considerazioni
valgono per le dichiarazioni di Giovanni Brusca, su cui pure si è soffermata
criticamente la difesa.
Anche l’attendibilità di costui e
la credibilità intrinseca delle sue dichiarazioni sono state affermate dalla
Corte di Appello in base ad argomentazioni che non possono essere tacciate di
irrazionalità evidente.
Da tali dichiarazioni essa ha
ricavato un ulteriore indizio dei rapporti tra l’imputato e i Salvo. Negli
ambienti mafiosi ci si rivolgeva a costoro (nel caso specifico a Nino) per
tentare di aggiustare processi di rilevante interesse per Cosa Nostra (nello
specifico quello per l’omicidio del capitano Basile).
Infine, la Corte territoriale ha
spiegato le ragioni per cui non ha dato credito ai dinieghi dei familiari dei
Salvo e non ha trascurato di riferire e valutare le dichiarazioni di segno
contrario alla tesi accusatoria rese da Nicolo Mario Graffagnini, già
andreottiano e segretario provinciale della Democrazia Cristiana.
Con riferimento alle
dichiarazioni sopra indicate e alle critiche del ricorrente, è necessario
ribadire, ancora una volta, che gli apprezzamenti di merito che caratterizzano
sul punto i! ricorso non possono trovare ingresso in questa sede e che, quindi,
la Corte è esonerata dalla loro disamina analitica.
Giova ricordare che nella pratica
giudiziaria accade di frequente che gli elementi di valutazione acquisiti al
processo non diano indicazioni univoche. Però ciò non comporta l’esclusione
automatica della veridicità del fatto che ne costituisce l’oggetto.
Infatti, per il principio del
libero convincimento, il giudice di merito ben può dare credito solo ad alcune
delle risultanze processuali disattendendone altre, purché assolva all’onere di
offrire una spiegazione logica della propria scelta. E nella specie risponde ai
comuni criteri logici la motivazione della sentenza nella parte in cui ha
ritenuto esistenti i rapporti tra Giulio Andreotti e i cugini Antonino e
Ignazio Salvo. Infatti la relativa affermazione è stata fondata su una serie di
indizi che, essendo sufficientemente gravi, precisi e concordanti, considerati
con valutazione unitaria, costituiscono una solida e razionale piattaforma
probatoria.
Non induce a diversa statuizione
l’ulteriore rilievo del ricorrente, il quale lamenta che non è stato accertato
né quando, né dove detti rapporti abbiano avuto inizio, dal momento che, anche
in proposito, è nozione di esperienza quotidiana nella pratica giudiziaria che
in sede processuale molto raramente -se non mai – emergono i suddetti elementi,
che di norma non hanno particolare rilievo ai fini del giudizio, come del resto
può serenamente affermarsi in questo caso.
L’ultimo tema affrontato con il
motivo in esame concerne la posizione del collaboratore Di Carlo. Lo stesso
ricorrente riconosce che la sentenza impugnata non lo ha indicato
esplicitamente quale riscontro alle dichiarazioni di Marino Mannoia e tuttavia
lamenta che talvolta essa lo ha richiamato nel corso della motivazione nel
quadro dei rapporti tra imputato e cugini Salvo.
Proprio il carattere molto
sfumato e del tutto secondario della utilizzazione che, per ammissione dello
stesso ricorrente, la Corte di Appello ha fatto delle dichiarazioni di Di Cario
già induce alla conclusione che esse non hanno assunto una valenza apprezzabile
nella formazione del suo convincimento, con conseguente irrilevanza in questa
sede di un’indagine che le riguardi.
Ma è tranciarne considerare che
il ricorrente si è limitato alla riferita contestazione generica senza indicare
in quale specifico errore la sentenza sarebbe incorsa per effetto della
utilizzazione di dichiarazioni di costui erronee o non veritiere; in tal modo
egli ha sottoposto all’attenzione di questa Corte una doglianza specifica e,
quindi, inammissibile.
A conclusione della disamina che
precede è appena il caso di aggiungere che, relativamente ai fatti trattati, la
Corte di Appello ha applicato la prescrizione con la conseguenza non secondaria
che, in questa, sede, la sua statuizione potrebbe essere oggetto di
annullamento solo ove fosse evidente la prova dell’innocenza dell’imputato,
situazione che quanto sopra precisato, in ogni caso, non consente di affermare.
In definitiva, a parte la
premessa iniziale attinente ai limiti di ricorribilità in cassazione del vizio
di motivazione, il quarto motivo del ricorrente consiste in una serie di
argomentazioni di merito, ben esemplificate dalla riproduzione testuale di
molte dichiarazioni dei vari collaboranti interrogati nel corso dei due precedenti
giudizi, che ne determinano la complessiva inammissibilità.
e) Con il quinto motivo il
ricorrente eccepisce la nullità della sentenza e dell’ordinanza 25.10.1995 per
mancata assunzione di una prova decisiva. L’ordinanza impugnata ha respinto
l’istanza probatoria dell’imputato, intenzionato a documentare i propri
movimenti negli ultimi mesi del 1979 e i propri impegni per il periodo compreso
tra agosto e dicembre 1979, al fine di contrastare la documentazione prodotta
dai P.M. per provare che, in quell’anno, l’apertura della caccia avvenne in
epoca diversa da quella affermata da Siino.
Egli assume che, in tal modo, è
stato violato il principio del contraddittorio perché la sentenza ha poi
esaminato la possibilità che il sen. Andreotti fosse recato in Sicilia anche in
giorni diversi da quelli originariamente indicati.
E’ opportuno ricordare, in linea
generale, che la giurisprudenza ha sempre sottolineato il carattere eccezionale
e discrezionale della rinnovazione in appello della istruttoria dibattimentale
e dell’ammissione di nuove prove (confronta, per tutte, Cass. Sez. Un. n. 2780
del 1996, Panigoni), essendo prevista solo se ritenuta assolutamente
necessaria.
Conseguentemente si è affermato
l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, in tema di rinnovazione, in
appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, anche quando sia
investito – con i motivi di impugnazione – di specifica richiesta, è tenuto a
motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in
considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria
compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo
potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter
decidere allo stato degli atti. Non cosi, viceversa, nella ipotesi di rigetto,
in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e
desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con
la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione,
o negazione, di responsabilità (Cass. n. 8891 del 2000, Callegari; Cass. n.
6379 del 1999, Bianchi).
Dai verbali di udienza risulta
che, a fronte di una serie di istanze istruttorie formulate dalle parti, la
Corte di Appello ha deciso di accogliere quelle ritenute utili per provare i
fatti in contestazione.
D’altra parte è giurisprudenza di
questa sezione (Cass. n. 8106 del 2000, Accettola), peraltro in armonia con
l’orientamento ormai consolidato {confronta, ad esempio, Cass. n. 3603 del
2000, Mammana e Cass. n. 2689 del 2000, Rapisarda), che il vizio di mancata
assunzione di prova decisiva è configurabile solo qualora la denegata prova,
confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di tal
natura da determinare una diversa conclusione del processo, ma non quando
trattasi di fatto insuscettibile di incidere in concreto sulla formazione del
convincimento del giudice, risolvendosi esso in una diversa prospettazione
valutativa, quale quelle che informano la
fisiologica dialettica tra le opposte parti processuali. La motivazione addotta
dalla Corte di Appello, in ordine alle circostanze che l’imputato intendeva
provare e alla documentazione da questo già prodotta (essa ha ritenuto
compatibile con l’affermato viaggio l’impegno già documentato dall’imputato,
che quindi ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa sul punto), è tale
da escludere che la richiesta prova avrebbe potuto assumere carattere decisivo.
Il motivo, pertanto, risulta infondato.
f) Il sesto motivo eccepisce un
ulteriore vizio di motivazione della sentenza impugnata. Il riferimento è alla
ritenuta partecipazione dell’imputato al sodalizio mafioso sino alla primavera
del 1980, epoca in cui egli avrebbe sciolto il vincolo assodativo avendo ormai
scoperto la reale dimensione di Cosa Nostra, di cui anzi sarebbe divenuto
inesorabile nemico, pur nella consapevolezza di mettere a rischio la vita
propria e quella dei familiari.
La censura è basata su
considerazioni che attengono alla personalità dell’imputato e all’inverosimiglianza
che egli abbia potuto partecipare al sodalizio mafioso ignorandone la valenza
criminale e accettando di frequentare personaggi mafiosi di notevole spessore
allo scopo di perseguire obiettivi altrimenti irraggiungibili.
La Corte deve necessariamente
rilevare che questa doglianza esprime valutazioni di carattere logico che,
però, rendono indispensabili apprezzamenti di merito preclusi in sede di
legittimità e che involgono considerazioni che esulano dalla mera vicenda
processuale e contengono, anzi, sfumature di carattere etico e storico, cioè
sfociano in un campo nel quale al giudice di legittimità non è consentito
addentrarsi.
D’altra parte lo stesso
ricorrente non nasconde che numerosi collaboranti estratti dalle fila di Cosa
Nostra hanno dichiarato che i vertici mafiosi contavano sul suo appoggio e che
hanno riferito di contatti con personaggi mafiosi o comunque vicini al
sodalizio criminoso, anche se poi rileva che la stessa sentenza di appello ha
dovuto riconoscere che molti tra detti collaboratori hanno dichiarato il falso.
Ma il compito peculiare del
giudice di merito è proprio quello di accertare i fatti quali emergono dalle
risultanze processuali, sceverare tra queste quelle credibili e rilevanti da
quelle non verosimili e ininfluenti e dare contezza delle proprie valutazoni e
scelte con una motivazione che percorra un iter logico conseguente.
Esaustività, razionalità e
conseguenzialità delle argomentazioni dimostrative degli apprezzamenti di
merito rendono la sentenza non censurabile in sede di legittimità sotto il
profilo del vizio di motivazione.
Peraltro è orientamento noto e
costante di questa Corte (confronta Cass. art. 4713 del 1996, Bruno, vedi anche
Cass. n. 4867 del 2001, Maglieri) che i motivi costituiscono una parte essenziale
e inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro
formulazione, debbono essere, ai sensi della lett. e) dell’art. 581 c.p.p.,
articolati in maniera specifica: devono cioè indicare chiaramente, a pena di
inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza.
In altri termini, per essere
specifico, il motivo del ricorso per cassazione deve concretarsi nella precisa
e determinata indicazione dei punti di fatto e di diritto da sottoporre al
giudice di legittimità, in una esposizione, pur concisa, ma chiara, delle
censure che si muovono ai punti indicati, onde consentire a detto giudice di
esercitare il suo sindacato con riferimento alle argomentazioni svolte nel
provvedimento impugnato.
Invece gran parte della censura
in esame non contiene riferimenti specifici e si sostanzia in una serie di
considerazioni generali che la rendono inammissibile.
L’unica questione dotata di un
minimo di specificità, perché contiene un preciso riferimento alla motivazione
della sentenza impugnata, riguarda i vantaggi che, nella prospettazione del
giudice di appello, Andreotti si sarebbe prefigurato in cambio della propria
disponibilità nei confronti del sodalizio mafioso.
Il ricorrente assume che la
stessa sentenza ha finito con il negare effettivi benefici sul piano
elettorale, ma trascura di considerare il convincimento della medesima,
rilevante sotto il profilo in esame, ricavabile da affermazioni come la
seguente: malgrado le esposte considerazioni limitino la effettiva incidenza
sui rapporti fra l’imputato ed i mafiosi dell’appoggio elettorale assicurato da
costoro, non si deve, però, trascurare che le medesime considerazioni sono,
almeno in parte, condizionate, a posteriori, dalla analisi dell’esito
fallimentare della decisione del boss Salvatore Riina di dirottare sul Partito
Socialista i consensi prima accordati alla Democrazia Cristiana e che prima di
tale avvenimento era, al contrario, convincimento comune la essenziale
importanza di procurarsi o conservare in Sicilia l’appoggio elettorale dei
mafiosi: in questo quadro si può richiamare la perentoria affermazione fatta
dal capomafia Stefano Bontate in occasione del più volte ricordato colloquio
della primavera del 1980.
In altri termini, il
convincimento della Corte di Appello è nel senso che fosse nozione comunemente
acquisita e condivisa dallo stesso imputato che non si potesse sperare in un
successo elettorale in Sicilia senza venire a patti con Cosa Nostra e ottenerne
il sostegno.
D’altronde è agevole ricordare, a
titolo esemplificativo, essere risultato che, fosse o meno intervenuto
Andreotti nella vicenda, a seguito del trasferimento dei detenuti siciliani di
cui si è detto più volte, Gaetano Costa, che ne fu uno dei beneficiari, chiese
ai vertici della sua "famiglia" di indirizzare i propri voti a favore
delta corrente andreottiana.
Analogamente, per quanto riguarda
i favori che l’imputato avrebbe reso al sodalizio mafioso, si può ricordare che
la Corte di Appello ha ritenuto provati fatti, la cui analisi specifica è stata
compiuta nell’ambito della disamina del quarto motivo, con riferimento ai quali
questo Collegio ha accertato la non palese illogicità della motivazione.
D’altra parte, l’asserita
inadeguatezza della prova dei ritenuti interventi extra ordinem (vedi, ad
esempio, il caso Nardini), denunciata dal ricorrente, è censura che non può
trovare ingresso nel giudizio di legittimità nel quale, come già evidenziato
nei principi generali, il Supremo Collegio non è chiamato a valutare
l’adeguatezza della prova e della motivazione al riguardo addotta dal
provvedimento impugnato, ma soltanto a controllare che quest’ultima non sia
espressa in termini connotati da acclarata
illogicità.
Non va, infine, neppure in
proposito trascurata la considerazione che, nel caso di specie, per non
applicare la maturata prescrizione, la Corte territoriale avrebbe dovuto
accertare l’evidenza della prova che l’imputato non ha commesso il fatto o che
esso non sussiste.
Il ricorrente sottolinea che egli
non avrebbe avuto benefici elettorali personali e neppure per la propria
corrente perché la sentenza ha rilevato che i politici locali ad essa
appartenenti godevano di un loro seguito sul territorio.
Ma, come risulta anche da quanto
in precedenza esaminato, la Corte territoriale ha fatto leva, piuttosto che
sull’accertato beneficio elettorale, sulla opinione, che ha attribuito anche
all’imputato, che esso si sarebbe potuto verificare. D’altra parte è
significativo al riguardo che, in altre parti della sentenza, si sia segnalato
lo spostamento di voti – anche se non molto rilevante – verso il Partito
Socialista voluto da Salvatore Rima e quello conseguente al trasferimento di
detenuti siciliani.
In definitiva, il motivo sviluppa
argomentazioni genetiche e, comunque, di merito; quindi è inammissibile.
g) Con il settimo e ultimo motivo
il ricorrente eccepisce violazione dell’art. 606, lettera b) c.p.p. perché la
sentenza impugnata dal P.M., pur riconoscendo che il reato contestato al capo
a) era prescritto, ha ritenuto di non limitarsi a dichiarare l’estinzione del
reato, ma ha proceduto all’esame del merito in considerazione della peculiarità
della vicenda e della personalità dell’imputato.
Egli lamenta che, in tal modo, la
Corte di Appello lo ha ritenuto colpevole del delitto previsto dall’art. 416
c.p. che ha poi dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, stravolgendo
l’art. 129 c.p.p. perché, anziché verificare allo stato degli atti se
risultasse evidente l’innocenza dell’imputato, si è impegnata a dimostrarne la
colpevolezza.
Ad evidenziare l’improducenza
della censura è già sufficiente il rilievo che, per effetto dell’impugnazione
del P.M, finalizzata ad ottenere la condanna dell’imputato, la Corte di Appello
ha applicato la prescrizione dopo avere compiuto una disamina tesa anche ad
accertare la data di cessazione della ritenuta attività criminosa, la
sussistenza delle contestate circostanze aggravanti, da essa escluse e, in
definitiva, anche con riferimento alla ritenuta concedibilità delle circostanze
attenuanti generiche.
Pertanto, all’epoca della
pronuncia, l’effetto estintivo non era automaticamente operante, ma esso è
conseguito all’accertamento della data di ritenuta consumazione del reato e
all’esclusione delle circostanze aggravanti che avrebbero prolungato il termine
di prescrizione, per cui il giudizio sulla sussistenza del reato ha costituito
un prius logico e giuridico rispetto alla statuizione che ne ha dichiarato
l’estinzione.
D’altra parte il Collegio
condivide l’orientamento cui ha fatto riferimento la Corte territoriale (vedi
nello stesso senso, più recentemente, Cass. n. 783 del 1999, Di Noto), in base
al quale, ove l’imputato sia stato assolto in primo grado e contro tale
decisone sia stato proposto gravame dal pubblico ministero, il giudice
dell’impugnazione può applicare una sopravvenuta causa di estinzione del reato
solo se reputi fondata l’impugnazione, cosi da escludere che possa persistere
la pronuncia di merito più favorevole all’imputato. Ne consegue che la sentenza
che dichiara la causa estintiva deve essere adeguatamente motivata sul punto.
Non induce a diversa statuizione
la circostanza che il Tribunale avesse assolto Andreotti ai sensi del comma 2
dell’art. 530 c.p.p., perché appare condivisibile l’orientamento recepito dalla
Corte territoriale (Cass. n. 13170 del 2002, Scibelli), secondo cui non può
farsi luogo alla declaratoria di
improcedibilità per estinzione del reato a seguito di maturata prescrizione,
qualora in sentenza si dia atto della sussistenza dei presupposti per la
pronunzia di assoluzione, sia pure ai sensi del secondo comma dell’art 530
c.p.p., atteso che, nel vigente sistema processuale, la assoluzione per
insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparata alla
mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a
quella di estinzione del reato.
Il motivo, pertanto, risulta infondato.
13 – Le considerazioni conclusive
A questo punto, esaurita la
disamina dei due ricorsi, debbono essere tratte le considerazioni conclusive da
cui scaturiranno le statuizioni della Corte.
Come si è rilevato nel primo
paragrafo della parte motiva della presente sentenza, la partecipazione
all’associazione criminosa si sostanzia nella volontà dei suoi vertici di
includervi il soggetto e nell’impegno assunto da costui di contribuirne alla
vita attraverso una condotta a forma libera, ma in ogni caso tale da costituire
un contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all’esistenza o al
rafforzamento del sodalizio.
Non è, dunque, sufficiente una
condivisione meramente psicologica o ideale di programmi e finalità della
struttura criminosa, ma occorre la concreta assunzione di un ruolo materiale al
suo interno, poiché la partecipazione implica l’apporto di un contributo nella
consapevolezza e volontà di collaborare alla realizzazione del programma
societario.
D’altra parte, in mancanza
dell’inserimento formale nel sodalizio, è soltanto la prestazione di contributi
reali che rende concreta ed effettiva, e non meramente teorica, la
disponibilità e nel contempo ne materializza la prova.
In definitiva, la Corte di
Appello non si è discostata da questa impostazione, perché ha ancorato
l’asserita disponibilità dell’imputato ad una serie di fatti e di
considerazioni che ha ritenuti tali da rafforzare il sodalizio criminoso, anche
per effetto dell’apprezzamento e della collaborazione manifestati nei confronti
di alcuni dei suoi vertici.
A tale proposito è sufficiente
ricordare le opinioni di Bontate e di altri uomini d’onore sul rafforzamento
della loro posizione personale e dell’intera organizzazione per effetto delle
presunte amichevoli relazioni intrattenute con Andreotti e, per contro, il
disappunto di Rima per non essere riuscito ad instaurare rapporti analoghi.
Pertanto la Corte palermitana non
si è limitata ad affermare la generica e astratta disponibilità di Andreotti
nei confronti di Cosa Nostra e di alcuni dei suoi vertici, ma ne ha
sottolineato i rapporti con i suoi referenti siciliani (del resto in armonia
con quanto ritenuto dal Tribunale), individuati in Salvo Lima, nei cugini Salvo
e, sia pure con maggiori limitazioni temporali, in Vito Ciancimino, per poi
ritenere (in ciò distaccandosi dal primo giudice) l’imputato compartecipe dei
rapporti da costoro sicuramente intrattenuti con Cosa Nostra, rapporti che, nei
convincimento della Corte territoriale, sarebbero stati dall’imputato coltivati
anche personalmente (con Badai amenti e, soprattutto, con Bontate) e che
sarebbero stati per lui forieri di qualche vantaggio elettorale (quantomeno
sperato, solo parzialmente conseguito) e di interventi extra ordinem,
sinallagmaticamente collegati alla sua disponibilità ad incontri e ad
interazioni (il riferimento della Corte territoriale è alla questione
Mattarella), oltre che alla rinunzia a denunciare i fatti gravi di cui era
venuto a conoscenza.
Quindi la sentenza impugnata, al
di là delle sue affermazioni teoriche, ha ravvisato la partecipazione nel reato
associativo non nei termini riduttivi della mera disponibilità, ma in quelli
più ampi e giuridicamente significativi di una concreta collaborazione,
sviluppatasi anche attraverso l’opera di Lima, dei Salvo e di Ciancimino, oltre
che nella ritenuta interazione con i vertici del sodalizio (basti pensare,
ancora una volta, il suo riferimento alla vicenda Mattarella), la cui valenza
sul piano della configurabilità del reato non è inficiata dalla considerazione
che la soluzione realmente adottata non fu quella politica da lui propugnata,
ma quella omicidiaria da lui avversata.
Ne deriva che la costruzione
giuridica della Corte territoriale resiste al vaglio di legittimità proprio
perché essa ha interpretato i fatti di cui è processo -esprimendo tale suo
convincimento in termini che lo rendono non censurabile in questa sede – nel
senso che Andreotti, facendo leva sulla sua posizione di uomo politico di punta
soprattutto a livello governativo, avrebbe manifestato la propria disponibilità
– sollecitata o accettata da Cosa Nostra – a compiere interventi in armonia con
le finalità del sodalizio ricevendone in cambio la promessa, almeno
parzialmente mantenuta, di sostegno elettorale alla sua corrente e di eventuali
interventi di altro genere.
Piuttosto la Corte territoriale
si è posta in contrasto logico con il delineato concetto di partecipazione nel
reato associativo e con l’elaborazione giurisprudenziale in tema di permanenza
del partecipe nell’organizzazione criminale nel momento in cui non ha
considerato che la sua struttura ne implica necessariamente l’indeterminatezza
temporale, con la conseguenza che l’intraneus recede dalla compagine criminale
solo ponendo in essere una concreta condotta che ne implichi e dimostri
l’irreversibile distacco.
Ma il già indicato (in
precedenza) errore di diritto si è rivelato in concreto inconferente in quanto
quel Giudice (ed anche ciò è stato già considerato) ha risolto la questione del
recesso con rilievi di merito, insindacabili in questa sede.
La costruzione della Corte
d’Appello, giuridicamente non censurabile solo in virtù delle effettuate
precisazioni e fatto salvo il limite appena sopra delineato, è stata poi
raffrontata alla realtà processuale per verificarne la compatibilità con le
risultanze acquisite, verifica il cui controllo va effettuato tenendo presente
l’ovvia precisazione che la cognizione della Corte di Cassazione non consente apprezzamenti
di merito ed è limitata al riscontro di eventuali via di motivazione.
I rapporti con Lima, con i Salvo
e con Ciancimino, gli effetti che ne sono derivati, il loro significato ai fini
della decisione sono stati descritti e valutati dalla sentenza impugnata sulla
base di apprezzamenti di merito espressi in termini logici e conseguenti,
quindi razionalmente incensurabili.
La ricostruzione dei singoli
episodi e la valutatone delle relative conseguenze è stata effettuata in base
ad apprezzamenti e interpretazioni che possono anche non essere condivise e a
cui sono contrapponibili altre dotate di uguale forza logica, ma che non sono
mai manifestamente irrazionali e che, quindi, possono essere stigmatizzate nel
merito, ma non in sede di legittimità. La Corte di Appello ha ritenuto provati
i due incontri con Bontate, riferiti da Marino Mannoia, il quale ha partecipato
personalmente al secondo mentre ha avuto cognizione del primo senza esservi
presente, perché essa ha apprezzato – in termini non palesemente illogici –
adeguati allo scopo i riscontri di carattere generale e le deduzioni di
carattere logico che li confortano, dalla medesima analiticamente illustrati.
Inoltre, mentre del primo è stata
affermato il carattere non determinante ai fini della ricostruzione prescelta,
il secondo incontro è stato apprezzato come dimostrativo della crisi
irreversibile dei pregressi, asseriti rapporti tra i due interlocutori
principali, anche se sulla base di un ragionamento logico conseguente alla
valutazione di fatti noti, o ritenuti accertati, piuttosto che sulla prova
diretta e specifica del recesso dal sodalizio.
La Corte territoriale ha ritenuto
attendibile anche l’episodio Nardini, pur nella affermata problematica
credibilità di Mammoliti, in quanto sufficientemente riscontrato e, quindi, lo
ha valutato anche se ad effetti piuttosto limitati. Considerazioni analoghe
attengono all’intervento per aggiustare il processo Rimi, utilizzato dalla
sentenza impugnata essenzialmente allo scopo di inferirne l’affidamento dei
vertici di Cosa Nostra sulla possibilità di rivolgersi ad Andreotti e
richiederne l’intervento allo scopo di superare situazioni pericolose per
l’organizzazione.
Per contro e sul versante
opposto, la Corte palermitana ha negato pregnante valenza probatoria ai fatti
accaduti nel periodo successivo all’avvento dei "corleonesi", quali
il preteso regalo ad Andreotti di un quadro da parte di Bontate e Calò, gli
interventi dell’imputato, sia pure modesti e non decisivi, espletati a favore
di Sindona, i cui legami con Bontate e Badalamenti ha ritenuto provati, la
telefonata proveniente dalla sua segreteria nel settembre 1983 per assumere informazioni
sulla salute di Giuseppe Cambria, persona legata ai Salvo, di cui, però, ha
posto in dubbio la riferibilità all’imputato, il trasferimento nel 1984 di
detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara, per il quale ha
ipotizzato un interessamento esclusivo di Lima, l’incontro avvenuto nel 1985
con Andrea Manciaracina, uomo d’onore vicino a Riina, la convinzione in seno a
Cosa Nostra, pur in assenza della prova di un suo intervento, di poter
ricorrere ad Andreotti per aggiustare il maxiprocesso, la cui importanza per il
sodalizio criminoso era innegabile. Pertanto il Collegio rileva
conclusivamente: 1) la Corte di Appello ha delineato il concetto di
partecipazione nel reato associativo in termini giuridici non condivisibili, ma
l’erronea definizione teorica è stata emendata per effetto della successiva
ricostruzione dei fatti, da cui essa ha tratto il convincimento di specifiche
attività espletate a favore del sodalizio; 2) pure la cessazione di tale
partecipazione è stata delineata secondo una prospettazione giuridica non
corretta, ma poi anche riguardo ad essa la Corte territoriale ha non
irrazionalmente valutato come concreta dimostrazione del necessario recesso un
episodio che ha insindacabilmente ritenuto essere di certo avvenuto; 3) gli
episodi considerati dalla Corte palermitana come dimostrativi della
partecipazione al sodalizio criminoso sono stati accertati in base a valutazoni
e apprezzamenti di merito espressi con motivazioni non manifestamente
irrazionali e prive di fratture logiche o di omissioni determinanti; 4) avendo
ritenuto cessata nel 1980 la assunta partecipazione nel sodalizio criminoso,
correttamente il giudice di appello è pervenuto alla statuizione definitiva
senza considerare e valutare unitariamente il complesso degli episodi
articolatisi nel corso dell’intero periodo indicato nei capi d’imputazione; 5)
le statuizioni della Corte di Appello concernenti l’insussistenza di una delle
circostanze aggravanti contestate e la teorica concedibilità delle circostanze
attenuanti generiche non hanno formato oggetto di impugnazione specifica e,
quindi, sono passate in giudicato, precludendo qualsiasi ulteriore indagine
perché la cessazione della consumazione del reato nel 1980 ne ha determinato la
prescrizione. Inoltre essa ha ritenuto ulteriore fatto confermativo della
asserita dissociazione l’emanazione del D.L. 12 settembre 1989, n. 317, di cui
l’imputato è stato un fiero propugnatore; 6) al termine di questo articolato
"excursus", il Collegio ritiene di dover riprendere l’osservazione
iniziale: i giudici dei due gradi di merito sono pervenuti a soluzioni diverse;
non rientra tra i compiti della Corte di Cassazione, come già reiteratamente
precisato, operare una scelta tra le stesse perché tale valutazione richiede
l’espletamento di attività non consentite in sede di legittimità; in presenza
dell’intervenuta prescrizione, poi, questa Corte ha dovuto limitare le sue
valutazoni a verificare se le prove acquisite presentino una evidenza tale da
conclamare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine
all’insussistenza del fatto o all’estraneità allo stesso da parte dell’imputato;
7) ne deriva che, mancando tali estremi, i ricorsi vanno rigettati.
Al rigetto del ricorso
dell’imputato consegue per il medesimo l’onere delle spese ai sensi dell’art.
616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del
Procuratore Generale e dell’imputato e condanna quest’ultimo al pagamento delle
spese processuali.
Roma, 15 ottobre 2004.
Il Consigliere Estensore Il
Presidente.
Si da atto che la presente
motivazione è stata letta e approvata dal Collegio, ai sensi dell’art. 617
c.p.p., nelle camere di consiglio del 21 e 28 dicembre 2004.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 28
dicembre 2004