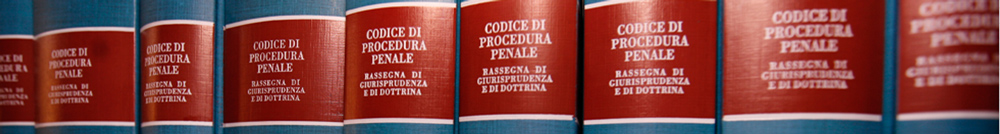Imprese ed Aziende
Il Presidente di Confindustria bacchetta la politica. Ecco il testo del discorso di Montezemolo. Roma, 26 Maggio 2005
Il Presidente di Confindustria bacchetta la
politica. Ecco il testo del discorso di Montezemolo
Confindustria – Assemblea 2005 Intervento del
Presidente Luca Cordero di Montezemolo
Roma, 26 Maggio 2005
Autorità, Colleghi, Signore e Signori,
in questo Auditorium, che rappresenta
uno dei simboli della creatività italiana, vedo tante persone determinanti per
i destini del nostro paese.
L’economia italiana attraversa la
stagione più difficile dal dopoguerra: non solo per la lunga catena di dati
negativi, ma soprattutto perché sembrano smarriti lo spirito e la tensione collettiva degli anni migliori e spesso perfino
le basi della convivenza civile.
Confindustria aveva invano lanciato l’allarme
diversi mesi fa. Ma molti hanno voluto negare
l’evidenza e oggi siamo in recessione.
Gli imprenditori vivono
un momento amaro, sono consapevoli del loro ruolo ma anche delle loro
responsabilità. Non intendono attardarsi in uno sterile lamento di fronte alle
difficoltà attuali e, come detto l’anno scorso, si sono veramente rimboccati le
maniche.
Ora è indispensabile che tutti
facciano altrettanto. Servono scelte urgenti, coraggiose, probabilmente
impopolari ma che sappiano fronteggiare l’emergenza
senza perdere di vista la costruzione del futuro. E di
questo parleremo più avanti.
Dobbiamo comunque
evitare che l’Italia resti schiacciata dal presente. I problemi di oggi vanno affrontati individuando gli obiettivi per il
domani.
Schiacciati dal presente, divisi sul
passato, rischiamo di prestare poca attenzione al nostro futuro. Serve uno
sforzo di visione. Serve una capacità di leggere i fenomeni per costruire il
domani. Serve una volontà di emergere dal quotidiano: non per sfuggirlo, ma per
poterlo affrontare meglio, con una mappa che indichi una strada.
Sta qui il senso di una politica
alta, che abbia un progetto per il domani e che sia
vicina ai veri problemi della gente.
Dove vogliamo che sia l’Italia tra dieci
anni? L’anno scorso dicemmo che era il momento di
restituire al Paese parte di quello che avevamo ricevuto. E
con il difficile lavoro di quest’anno abbiamo cercato
di farlo. Adesso ci chiediamo: cosa siamo noi disponibili a fare per il futuro
dell’Italia? Dove va il nostro paese? Quali sono i
suoi desideri? Quali i sogni dei nostri giovani? Quali le aspirazioni dei
lavoratori? Quali i progetti delle imprese?
Lontana è da noi l’idea che debba esserci qualcuno o un centro che programmi e diriga le
azioni dei singoli. Ma il nostro futuro è anche il
prodotto di ciò che la classe dirigente saprà far emergere oggi. E’ arrivata
l’ora delle grandi scelte.
Dobbiamo rimettere in funzione i
meccanismi di selezione, con due parole chiave: la trasparenza e soprattutto la
meritocrazia.
La meritocrazia è un valore di cui
abbiamo estremamente bisogno, nelle imprese come nella
società, nei servizi come nella pubblica amministrazione, nella scuola come
nelle università. Ed è bene che questo valore sia
trasmesso ai più giovani.
Questo non significa danneggiare i
più deboli, che vanno tutelati, ma creare le condizioni per fare avanzare i
migliori affinché siano protagonisti negli scenari del futuro.
Ma chi elabora questi scenari? Chi si impegna politicamente a far convergere verso di essi le
forze del Paese? Chi si confronta con quanti, in tutto il mondo, stanno
ponendosi gli stessi problemi?
Noi vogliamo essere costruttori del
futuro. Non ci rassegniamo a vivere il giorno per giorno.
Crediamo che l’Europa debba far parte di quelle istituzioni mondiali che stanno
operando per il domani. Un mondo senza la voce dell’Europa sarebbe più povero di idee e di cultura.
In questo mondo anche l’Italia deve
avere un ruolo importante. Non vogliamo chiuderci per sopravvivere in
dimensioni provinciali, ai margini della storia.
Quale sarà, nei prossimi dieci anni,
la struttura economica del mondo e quale la posizione dell’Europa e
dell’Italia? Il futuro è aperto, ma certe tendenze si
leggono già oggi.
Il baricentro economico mondiale si
sta spostando. Alla metà di questo secolo, Russia, India, Cina e Brasile saranno la più imponente forza economica mondiale.
Produrranno una ricchezza pari a quella attuale dei
sei paesi più sviluppati. Nel 2050 solo Giappone e Stati Uniti resteranno tra i
primi sei paesi al mondo nella classifica stilata in base al prodotto nazionale
lordo. Regno Unito, Germania, Francia e Italia si collocheranno tra il settimo
e il decimo posto.
Ai nostri livelli di produttività
basterebbero 500 milioni di cinesi per generare l’intero PIL mondiale di oggi. Si dimentica però che con la dimensione attuale del
PIL metà della popolazione del pianeta vive con meno di 2 dollari al giorno.
C’è uno spazio enorme di bisogni da
coprire e la sfida è dimostrare concretamente che lo sviluppo può andare di
pari passo, nell’economia globale, con la giustizia e
la dignità umana.
C’è posto per tutti sul pianeta. Il
problema, allora, è quello di gestire la transizione. È un processo che va
governato e per questo servono istituzioni sopranazionali forti e capaci.
E serve un’Europa vera, che funzioni,
perché solo l’Europa avrà, in questo mondo futuro, una dimensione che potrà
competere con gli altri giganti economici.
Per questo è importante interrogarci
su come sarà l’Europa tra dieci anni. Io non sono pessimista. Non vedo un
declino inesorabile del Vecchio Continente. Lo temo, solo se prevarranno le
logiche nazionalistiche e di conservazione. Lo escludo, se sapremo mantenere
alti gli obiettivi e forte la volontà di farcela.
L’Europa non sarà né una nazione
centralizzata, né uno Stato Federale nel senso classico del termine. Sarà una
nuova entità sopranazionale, la cui costruzione richiederà tempo, ma il cui
risultato sarà copiato dal resto del mondo. Tutti sappiamo
che in un mondo globale lo spazio per le singole nazioni si restringe.
Dobbiamo andare avanti. La strada è
tracciata: 25 nazioni, con lingue, culture, abitudini, religioni differenti si
stanno mettendo insieme e sostituiscono le leggi agli eserciti per risolvere le
loro questioni.
Noi stiamo realizzando un sogno,
un’utopia: la costruzione di una nuova istituzione politica fondata non
sull’unità di eguali, ma sul rispetto della diversità
delle genti e della loro autonomia. Non dobbiamo fare
l’errore di credere che l’Europa sia materia vecchia e scontata.
I giovani che sembrano
disinteressarsi dell’Europa sono molto più europei di quanto possa
sembrare. Per loro l’Europa c’è già: nella loro vita quotidiana, nei loro affetti, nelle loro ambizioni di studio e di lavoro,
nelle loro mete di vacanza, nella loro cultura e nei momenti di svago.
Ma sulla costruzione di questa Europa vedo in giro troppi scettici. Troppi governi
preoccupati più di farsi rieleggere a casa propria che
di costruire una nuova casa per il futuro. Troppi politici avvezzi a scaricare
sull’Europa responsabilità nazionali. Non è il Patto di Stabilità la causa
della stagnazione economica.
Noi sappiamo che non è la spesa
pubblica a far crescere l’economia, così come sappiamo che non può essere lo
Stato il motore dello sviluppo. Gli stessi Stati Uniti sono cresciuti
molto di più negli anni Novanta, quando avevano un bilancio pubblico in
avanzo, piuttosto che in questi anni in cui hanno generato squilibri di finanza
pubblica che peseranno negativamente sulle economie di tutto il mondo. E in Europa i paesi che crescono di più sono quelli che
hanno le finanze pubbliche in ordine.
Se continuiamo a dire
che è l’Europa la causa dei nostri mali, distruggiamo l’Europa e aggraviamo i
nostri mali. L’Italia, per crescere, ha bisogno dell’Europa. E
deve crederci.
Il bilancio europeo è misero rispetto a quelli nazionali. Va aumentato e mirato
verso il futuro. L’Italia deve battersi per accrescere il bilancio europeo e
affinché le risorse siano destinate all’innovazione, alla ricerca, ai grandi
progetti infrastrutturali: ossia le cose che
renderanno competitiva l’Europa dei prossimi dieci anni, non quelle che
difendono gli interessi e gli assetti del passato.
L’agenda di Lisbona non deve rimanere
né uno slogan né una chimera.
Con queste nuove risorse noi dobbiamo
costruire il bilancio 2007-2013, che è già in discussione in Europa. E’ una
partita delicata: se il bilancio europeo rimarrà nelle dimensioni attuali o,
peggio, se verrà compresso, le forze della
conservazione prevarranno. A nostro danno.
Il nostro paese è da anni un
contribuente netto del bilancio comunitario. Possiamo a buon diritto affermare
che la destinazione e la ripartizione di questi fondi rappresentano anche
elementi di chiarissimo interesse nazionale.
Le iniziative dell’Unione in tema di
competitività e la conferma della politica di coesione economica e sociale sono fondamentali per l’Italia e il Mezzogiorno. Richiedono
un rafforzamento delle risorse del bilancio comunitario e un loro intelligente
orientamento.
E’ questo un terreno dove il governo,
ma non solo, deve dare una prova concreta di influenza
sulle decisioni europee.
In ogni caso, l’Italia deve contare
di più in Europa: e anche questa è una responsabilità soprattutto nostra. Nei
posti che contano, gli italiani sono rari. E non si
tratta di fare ogni tanto la voce grossa per avere qualche posto in più. Si tratta
invece di valorizzare e investire, anche oggi, sui pochi rappresentanti che
abbiamo. Perché sentano di avere il supporto del loro
paese.
Va costruita una classe di funzionari
che sappiano stare indifferentemente in Italia e nel
mondo. Che siano autorevoli e portino la nostra
cultura negli organismi internazionali.
Fatta l’Europa, dobbiamo fare gli
europei.
Perché l’Europa cresca e produca ricchezza,
è necessario che il principio della libera concorrenza trovi piena attuazione.
La concorrenza non deve essere né un
mito né una religione. Ma il modo per dare a tutti maggiori
opportunità e per far emergere i migliori. Se
sapremo far emergere i migliori, allora saremo competitivi.
Dico questo anche adesso, in presenza di diffuse e comprensibili paure che derivano
dall’esplodere della concorrenza cinese nel mondo. Ma
la paura è sempre una cattiva consigliera. Invece
dobbiamo reagire. Siamo convinti che debbano essere messe in
pratica tutte le azioni necessarie in casi di crisi settoriale e a
fronte di concorrenza sleale.
L’Europa ha tutti gli strumenti: non
perda tempo e li usi rapidamente.
Il gioco della concorrenza è valido
solo se tutti rispettano le regole, che non devono imporre fardelli ai paesi
poveri, ma combattere le frodi, le falsificazioni, le illegalità e gli aiuti
pubblici: in una parola, la concorrenza sleale.
La libera concorrenza non è la
giungla, ma è un insieme di regole che vanno rispettate. Nel nostro paese,
grazie anche alla spinta dell’Europa e delle nostre
autorità competenti, la cultura della concorrenza è cresciuta. Occorre
insistere su questa strada.
Non dobbiamo, al contrario,
riscoprire vecchi dirigismi. Né riesumare enti pubblici pronti a intervenire su tutto né inventarne di nuovi.
Vedo con preoccupazione la
strisciante invadenza dello Stato nell’economia attraverso l’attivismo di nuovi
soggetti che richiamano alla mente la vecchia GEPI. Osservo con disagio le
resistenze degli enti locali che proteggono le loro aziende di
energia, acqua e gas e ostacolano i processi di liberalizzazione.
Concorrenza e mercato significano rispetto
delle regole e autorevolezza delle istituzioni. Una autorevolezza
che, purtroppo, ho visto ridursi in queste settimane.
Dopo le crisi finanziarie di alcune aziende italiane, nell’ormai lontano 2003, non
siamo ancora riusciti a varare una buona legislazione sul risparmio. E questo è
molto grave, ma anche significativo.
Poi si è scatenata una malintesa
battaglia per l’italianità delle banche, fatta di dichiarazioni intempestive da
parte di politici italiani e non solo italiani, in occasione delle offerte
pubbliche di acquisto su due banche nazionali.
Ne sono seguiti incontri più o meno riservati presso le autorità, manovre incrociate,
emersione di nuovi soggetti e di capitali misteriosi, rastrellamenti di azioni
sul mercato, scalate clandestine, sospetti e accuse di insider
trading, denunce di azioni di concerto, interventi della magistratura. Niente
di più lontano da produzione e lavoro.
Non è stato un bello spettacolo. Non
ci abbiamo guadagnato nulla. Spero
ancora che non abbiamo perso troppo, soprattutto per quanto riguarda la nostra
immagine sui mercati esteri. Le offerte pubbliche di acquisto
sono azioni trasparenti previste e regolate dalla legge. Chiunque vuole acquisire la proprietà ha il dovere di lanciare
un’OPA. E bene ha fatto la Consob a ribadire
questo principio con la sua decisione.
I fatti di queste settimane ci dicono che sono necessarie le regole e le autorità capaci di
farle rispettare. Con il rispetto delle regole cresce la cultura della
concorrenza. Con autorità professionali e indipendenti si garantisce la
correttezza del mercato.
Occorre far crescere la concorrenza
nel nostro paese. Sui mercati dei beni, dove già è forte da anni, ma dove è
necessario vegliare sulle pratiche distorsive. Sul
mercato dei servizi pubblici e in concessione, dove è più difficile, ma dove
occorre investire per avere minori prezzi e qualità del servizio elevata. Non
possiamo pagare l’energia più che negli altri paesi europei.
L’Italia resta fra le realtà più
chiuse anche per le professioni: da noi generano costi elevati per i
consumatori e le imprese, altrove sono un fattore dinamico per l’economia.
La riforma delle professioni,
concepita per immettere un po’ di concorrenza in questo settore, è stata prima
snaturata al punto di introdurre nuove protezioni e poi accantonata. Tutto
resta come prima: e non è un bene, perché perdiamo competitività internazionale
anche in questo settore.
E si rafforza la convinzione che
l’Italia sia il regno delle corporazioni intoccabili. Soprattutto quando si
avvicinano le elezioni.
La concorrenza è un mezzo per
migliorare il Paese, attraverso un processo meritocratico che deve cominciare
dalla scuola e dall’università.
Abbiamo bisogno di un sistema
scolastico – per il quale, va detto, si sta finalmente lavorando – che recuperi
rapidamente i ritardi accumulati nei confronti di altri
paesi dell’OCSE. E sia capace di accrescere efficacemente il nostro patrimonio di istruzione e intelligenze. Questo sistema deve valutare e
premiare gli studenti e i professori più validi.
Un paese dove l’istruzione e la preparazione siano più diffuse e continue lungo l’arco della
vita professionale, e dove la selezione dei migliori sia una regola sin dalla
scuola, è un paese che non teme la concorrenza. Anzi, che fa della concorrenza
la via per migliorare continuamente.
Vale nella scuola quello che deve valere nelle nostre imprese. Anche i nostri centri di eccellenza universitaria devono fare un grande sforzo
verso l’internazionalizzazione. Un sistema che sa promuovere e selezionare non
lascia indietro nessuno, perché crea gli spazi dove tutti possono trovare la
loro collocazione.
Queste riforme devono vedere
l’impegno congiunto di tutti i soggetti vitali del Paese. E
di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, a cominciare dalle regioni.
Il progetto deve essere fortemente integrato da ammortizzatori sociali moderni:
un sistema di indennità di disoccupazione combinato a
processi di formazione che devono accompagnare i lavoratori lungo tutto l’arco
della vita professionale.
Sarà la concorrenza a ridisegnare la
struttura produttiva del nostro paese e a creare nuove opportunità di lavoro e di impresa.
Non possiamo decidere a tavolino
quali settori e quali prodotti domineranno il mercato tra dieci anni. Ma sappiamo che, se l’Italia sarà più istruita e più
preparata, se avrà investito in centri di ricerca e avviato progetti per
migliorare il nostro territorio e la vita di tutti i giorni, allora sarà anche
presente nei nuovi settori.
L’Italia che verrà sarà popolata da
un numero di immigrati superiore all’attuale, perché i
maggiori arrivi si sommeranno al calo demografico della nostra popolazione.
Abbiamo bisogno di integrare queste
popolazioni e non possiamo aspettare che i nuovi problemi sorgano per
affrontarli. Sarebbe troppo tardi. La seconda generazione di immigrati
porrà problemi diversi e forse maggiori della prima, perché costituita da
persone nate sul nostro territorio, che vorranno giustamente avere tutti i
diritti e che non si accontenteranno solo dei posti di lavoro rifiutati dagli
italiani.
L’integrazione di domani si prepara
oggi, sapendo che il percorso dell’immigrazione finisce con i diritti di
cittadinanza e va considerato come un’opportunità.
Dobbiamo aumentare la nostra capacità
di adattamento al futuro. E noi sappiamo già da ora quale è il settore che più deve adattarsi. È quello dei
servizi.
I servizi sono i due terzi del PIL.
Rappresentano oggi un costo per le altre imprese, mentre in realtà potrebbero
essere un traino. La concorrenza nei servizi è bassa in Italia e in Europa.
Aver fatto fallire la direttiva sulla liberalizzazione
dei servizi, evento passato quasi inosservato nel nostro paese, rappresenta
purtroppo un grave errore.
Parliamo di mercato interno europeo
come se fosse già compiuto e non ci rendiamo conto che abbiamo liberalizzato
solo il commercio dei beni, che rappresenta meno di un terzo del PIL.
Non ci sarà un vero mercato interno
senza la liberalizzazione dei servizi. E senza questo mercato sarà difficile crescere.
Gli Stati Uniti crescono più
dell’Europa perché cresce la loro domanda interna. E questo perché i servizi sono liberi. I servizi hanno un
forte contenuto di manodopera locale e un elevato consumo di beni industriali
moderni. Basti pensare alla sanità, che consuma prodotti ad alta tecnologia. Ma lo stesso vale per il turismo, lo spettacolo, i
trasporti, l’educazione.
Il consumatore moderno compra beni
industriali attraverso l’uso dei servizi. Se i servizi non sono liberalizzati,
non cresce la domanda dei consumatori, non cresce la domanda di beni
industriali, non crescono la ricerca e l’innovazione che sono
implicite nei servizi moderni, organizzati ormai come vere imprese di
natura industriale.
La visione del futuro del nostro
paese deve comprendere una cura del territorio che è un’importante risorsa ma
anche una grande opportunità imprenditoriale.
Modernizzare le nostre città,
ricostruire le nostre periferie, valorizzare il nostro patrimonio artistico,
dotarsi di una rete di comunicazioni e di trasporti adeguati alla domanda di
mobilità, gestire con un minimo di efficienza la
raccolta e la distribuzione dell’acqua: sono tutti obiettivi che possono far
crescere nuovi imprenditori, nuove aziende, nuove professionalità e nuovi
servizi.
La domanda di moderne infrastrutture
è oggi ineludibile. Basta guardare all’esperienza della Spagna che ha saputo
utilizzare al meglio i fondi europei, facendo delle infrastrutture un motore
dello sviluppo. Ne dovrà derivare un potenziamento dell’offerta di logistica, necessaria
per un Paese che resta manifatturiero ma che non potrà avere sul
territorio tutte le fasi delle produzioni.
Il traffico di merci Europa-Asia via Suez ha già
superato quello Europa-USA. In quanto terminale
naturale di questi flussi l’Italia, e in particolare il Sud, può assicurarsi
valore aggiunto logistico e attività di perfezionamento delle merci.
Ma l’offerta di logistica implica anche
investimenti nell’intermodalità, a cominciare dai porti. E
poi innovazione organizzativa e tecnologica affinché si trasformi da onere per
le imprese in valore aggiunto per tutti. Ciò sarà molto importante per
l’impatto sui costi di trasporto, oggi troppo alti, e per il turismo.
Lo dico forte: serve un grande progetto per il turismo, per farlo uscire dalla crisi
in cui si dibatte e per farne un vero protagonista dello sviluppo nei prossimi
anni, un protagonista a dimensione industriale.
Natura, stile di vita e opere d’arte
non bastano più. Senza promozione coordinata e centralizzata del "marchio
Italia", senza prezzi concorrenziali e qualità del servizio, senza
imprenditorialità siamo destinati a perdere altre
posizioni.
Non è solo il recente sorpasso della Cina che ci preoccupa, ma il fatto che dal 2000
perdiamo turisti mentre aumentano negli altri paesi europei. E
questo nella più totale e generale disattenzione.
Il turismo è una delle più grandi
sfide che abbiamo davanti. Non è l’unica. Ma tutte le
occasioni si coglieranno meglio con un sistema finanziario adeguato.
Le banche italiane hanno fatto grandi
passi sulla strada della modernizzazione. Nessuno di noi dimentica da dove sono partite, solo pochi anni fa.
Ma il processo di crescita attraverso fusioni e
concentrazioni si è fermato. La via della crescita non è mai finita per nessuna impresa, a maggior ragione per le banche, che
debbono riprendere quel processo che si è interrotto.
Le banche sono imprese per le
imprese. E noi vogliamo banche italiane più grandi e
più forti, proprio come vogliamo industrie più grandi e più forti. Non c’è
differenza. Ma anche nel mondo del credito la
concorrenza deve diventare protagonista.
Il nostro mercato finanziario si sta
aprendo alla concorrenza estera. Questo è un bene. Auspichiamo che avvenga lo
stesso negli altri paesi e che le nostre banche siano protagoniste in Europa e
nel mondo.
E’ opportuno che accanto a banche
italiane controllate da banche estere, ci siano banche
italiane più grandi che controllino banche straniere. Solo la presenza delle
une e delle altre aiuterà la competizione in Italia e
potrà accompagnare al meglio le nostre imprese impegnate sui mercati mondiali. E in ogni caso, quando si tratta di banche europee sarebbe
meglio non considerarle straniere.
Come per gli istituti di credito,
anche per le imprese il controllo deve coincidere con la responsabilità di
farle crescere.
Può accadere che la salvaguardia delle nostre imprese passi per la diminuzione
del peso della partecipazione familiare al capitale dell’azienda. Non sempre,
naturalmente, ma può accadere.
E quando la crescita è necessaria per
il futuro dell’impresa io dico che dobbiamo sempre
scegliere la strada dello sviluppo, anche se questo vuol dire non essere più
soli alla guida dell’azienda.
Non si tratta di rinunciare a nulla
di ciò che l’imprenditore ha creato o ha contribuito a far crescere. Ma di
chiarire i ruoli reciproci, di regolare i rapporti tra controllo e gestione, di
mettere a punto moderni sistemi di governance.
Oggi può accadere di dover fare
scelte di questo tipo per essere competitivi sul mercato globale
e garantire così la continuità e il futuro di quel grande patrimonio che sono
le nostre aziende familiari.
L’Italia sarà sempre il paese delle
piccole imprese, ma le piccole imprese dovranno essere
più grandi e organizzate di quelle del passato. Questo non può essere un processo
lasciato solo all’iniziativa generosa dei singoli.
Alle piccole imprese dico: Confindustria è al vostro fianco nell’impegnativo cammino
della crescita e dell’internazionalizzazione, su cui quest’anno abbiamo insieme lavorato molto.
Nel corso degli anni abbiamo perduto
più di un grande gruppo multinazionale. Non sarà
facile inventarne di nuovi. Dobbiamo spingere quelli che abbiamo a fare da
traino alle piccole e medie imprese nel grande mercato
dell’economia globale.
E puntiamo moltissimo su imprese multinazionali
di medie dimensioni che hanno successo e stanno
ulteriormente crescendo perché molto focalizzate e specializzate.
Vedo qui oggi molti protagonisti di
questa realtà. Mi auguro di cuore di vederne sempre di
più.
Occorrono una volta
per tutte strumenti fiscali e finanziari mirati a far crescere le
dimensioni delle nostre imprese, favorendo fusioni e concentrazioni perché
siano più competitive.
Crescere è la nostra missione. Questo
deve essere anche l’obiettivo del Paese. A questo fine devono, anche, essere
ridisegnati il fisco italiano e la macchina amministrativa.
Il fisco non è solo pesante, ma è
anche mal distribuito. Premia più le importazioni che il lavoro nazionale.
Premia, soprattutto, più la rendita che la produzione. E’ questo che si vuole?
Mi rendo conto che sono temi delicati
e non penso che possano essere risolti con un colpo di bacchetta. Ma credo sia
necessario affrontarli e fare di essi un tema della
nostra politica industriale. Nel mondo si sta spostando il carico fiscale dall’imposizione
diretta a quella indiretta. Così facendo, si sgrava il
lavoro nazionale e si riequilibra il peso del prelievo nei confronti di paesi
concorrenti, ove i carichi fiscali e contributivi sono decisamente
più leggeri.
Noi che abbiamo un elevato peso
fiscale e un carico contributivo sul lavoro nazionale che non ha eguali in
Europa, dovremmo seriamente pensare a questa soluzione.
Si deve ridurre il cuneo fiscale e
spostare parte del carico dal costo del lavoro nazionale alle imposte
indirette, che pesano in eguale maniera sulla produzione interna e su quella importata.
Questa operazione può prendere il via
sin da ora. E’ ormai chiaro a tutti che va abolita
l’IRAP che grava solo sul lavoro italiano e sul capitale investito nel nostro
territorio. Non solo perché ce lo chiede l’Europa.
I dati dimostrano, senza possibilità
di smentita, che la crisi pesa sui settori più esposti alla concorrenza
internazionale, sull’industria e sul lavoro dipendente. Su quei comparti, cioè, che non possono sfuggire con meccanismi
protezionistici o di evasione ed elusione all’urto
della concorrenza e della globalizzazione. Comparti
che stanno affrontando una trasformazione senza precedenti del modello di
specializzazione produttiva per adeguarlo al nuovo contesto
dei mercati.
Togliere l’IRAP sul lavoro è urgente
per far recuperare competitività.
E’ essenziale che l’intervento sulla componente costo del lavoro avvenga in maniera diretta e
proporzionale, senza elementi discriminanti per le imprese industriali e la
loro dimensione. Non ripetiamo errori del passato!
Questa operazione va fatta senza
pregiudicare i conti dello Stato. Non sta a noi indicare dove tagliare la spesa
pubblica per trovare le risorse necessarie alla competitività. Ma certo sappiamo che lo spazio esiste.
Non vogliamo pagare con più deficit
quella tassa che comunque deve essere rimossa.
Il nostro paese ha tanto capitale
disponibile e troppe aziende sottocapitalizzate.
Stiamo diventando il paese della rendita. In Italia il rapporto tra patrimonio
(immobiliare e finanziario) e PIL è pari a otto volte!
Il maggior rapporto tra i paesi industriali. La Francia
sta dietro di noi e così gli USA. In questa situazione, il valore annuale della
rendita si avvicina paurosamente a quello del reddito da lavoro.
Vuol dire
che stiamo usando male le nostre risorse. Ma
soprattutto mi preoccupa l’insegnamento che da questa cultura della rendita
viene ai nostri giovani.
Se le cose stanno davvero così, vale
ancora la pena di insistere sui testi ostici delle materie scientifiche? Vale
ancora la pena di investire il proprio presente e il proprio futuro nella
ricerca, nella sperimentazione, nella grande avventura
dell’intraprendere quando il trattamento fiscale e il carico contributivo
penalizzano la produzione di ricchezza?
Sono domande che aspettano risposte
concrete in tempi brevissimi, per non doverci poi lamentare delle occasioni
perdute. Non fateci perdere il gusto e la voglia di fare gli imprenditori!
Il Paese da tempo non cresce. Il
Paese arretra in modo preoccupante in una fase di slancio dell’economia e del
commercio mondiale. C’è sfiducia. C’è una sorta di rassegnazione e perfino noi
imprenditori sembriamo talvolta smarrire il nostro ottimismo.
Bisogna rivalutare la capacità di
produrre ricchezza e la componente rappresentata dal
lavoro. Ma la rivalutazione non può essere solo una
questione di contrattazione sindacale, come invece sta avvenendo.
Sia chiaro. Noi imprenditori siamo
consapevoli delle difficoltà di molti lavoratori, ma anche delle difficoltà
delle aziende.
Dobbiamo evitare di fare, noi e voi
sindacati dei lavoratori, la fine dei polli di Renzo, che si beccavano ferocemente mentre venivano portati al macello. Noi non
vogliamo andare al macello.
Dobbiamo contribuire assieme a fare
crescere la competitività delle nostre imprese e a posizionarle
su quei segmenti di mercato che consentano profitti e un’adeguata remunerazione
del lavoro. Altrimenti, i maggiori salari sarebbero solo l’anticipo di futuri
licenziamenti!
Scusate la brutalità delle
espressioni. Ma occorre parlare chiaro. Noi non ci
sottraiamo alle nostre responsabilità. Serve uno scatto condiviso e adeguato
alle difficoltà della situazione. Senza dimenticare che il fattore tempo è determinante.
Auspichiamo che il sindacato ritrovi
una linea unitaria e realistica in materia di relazioni industriali per evitare
che si interrompa il dialogo con Confindustria.
L’esperienza di questi mesi ci dice che per andare
avanti nel confronto c’è assoluto bisogno di più visione comune da parte delle
confederazioni sindacali.
Mentre noi lasciamo passare i mesi in
discussioni estenuanti e senza conclusioni, la situazione del nostro sistema
produttivo si deteriora. Anche perché nei paesi nostri concorrenti – e non
penso solo alla Germania – le aziende e i sindacati stanno
adottando terapie assai incisive.
Vorrei dire a tutti, anche agli amici
del sindacato, che nell’economia globale le politiche
del continuo rinvio non hanno senso.
E’ arrivato il momento di rifondare
le relazioni sindacali per sviluppare in maniera moderna il valore dell’impresa
e del lavoro. Serve un modello di rapporti adeguato ai tempi per dare
prospettive concrete al fatto che capitale e lavoro hanno oggi il grande
interesse coincidente di guardare avanti.
Noi di questo siamo stati sempre
convinti. E su questa convinzione abbiamo basato la
scelta del dialogo e del confronto. Devo però dire con rammarico che al di là delle buone intenzioni un anno è trascorso senza
risultati concreti.
Essere tornati a parlarci ha creato
un clima migliore che deve però servire a costruire un
modello di relazioni davvero collaborativo, nell’interesse di tutti. E certo
non vanno in questa direzione piattaforme rivendicative al di fuori di ogni compatibilità e che pretendono di stravolgere
unilateralmente le regole del gioco.
Noi imprenditori stiamo comunque lavorando intensamente, cercando di fare la nostra
parte. Malgrado tutti gli sforzi è risultato finora
impossibile qualsiasi accordo. Abbiamo perciò deciso di preparare un nostro
documento sui temi delle relazioni industriali che riteniamo importante e
innovativo e che presenteremo come base di discussione.
Chiediamo un confronto di merito e
spirito costruttivo. Perché la sfida è veramente
impegnativa e i tempi sono strettissimi.
Vorrei citare solo due dati impressionanti.
Negli ultimi cinque anni, dal 2000 al 2004, la produttività è
aumentata in Germania del 10%, in Francia del 12%, in Italia è diminuita
di quasi un punto e mezzo. Negli stessi anni, il costo del lavoro per unità di
prodotto in Francia e Germania è diminuito, in Italia è aumentato di oltre il
12%.
Così non si può continuare. Senza
scelte immediate e coraggiose il divario tende ad allargarsi. L’OCSE già
prevede per il 2005 un incremento del costo del lavoro del
3,9% in Italia contro l’1,3% in Francia e addirittura una riduzione in
Germania.
Inoltre il numero di
ore realmente lavorate in un anno è fra i più bassi in Europa dove, in
media, si lavora oltre 300 ore in meno in un anno rispetto agli Stati Uniti.
Questo vuol dire che ogni cinque anni gli Stati Uniti
lavorano un anno di più rispetto a noi!
Anche qui, insieme e senza
contrapposizioni, è chiaro che abbiamo molto da fare. Senza aumenti di
produttività non c’è maggior torta da dividere e riaffiora la pericolosa tesi
del salario come variabile indipendente. Questo – lo ripeto – non vuol dire
ignorare il disagio di molti lavoratori. Ma si deve
innovare e trovare strade compatibili.
Il cuneo fiscale e contributivo – cioè la differenza fra il costo per l’impresa e la
retribuzione netta – è in Italia fra i più alti del mondo. Con l’IRAP che grava
sul costo del lavoro, per ogni 100 euro di salario netto, il costo per una
nostra impresa è pari a 193. Più della Francia, molto
di più dei 159 della Spagna e dei 145 del Regno Unito.
Sia chiaro, gli
imprenditori non chiedono minori tasse per fare maggiori profitti, ma per essere più
competitivi, per investire di più anche in ricerca e sviluppo, per costruire il
lavoro e il successo di domani.
E chiedono meno fardelli sull’impresa
per non dover continuare a guidare una macchina con una mano sola, in
condizioni di inferiorità rispetto ai concorrenti.
Sulle imprese italiane pesano
vincoli, gravami e oneri impropri che non hanno eguali nel mondo industriale.
Cambiare tutto ciò è indispensabile
per far ripartire gli investimenti, in particolare in ricerca e innovazione. E
qui, accanto a un maggiore sforzo del pubblico, si
sente il bisogno di un più grande e reale impegno dei privati.
Un paese come il nostro con tasse
elevate e servizi pubblici di bassa qualità favorisce solo chi è al riparo
dalla concorrenza, trasferendo la ricchezza dai settori esposti alla
competizione a quelli protetti. Cresce la rendita o il profitto di chi vive
fuori del mercato, a spese dei cittadini che pagano tariffe
più elevate.
Questo è il circuito del declino. Un
declino che si avverte quando è troppo tardi, perché
nel frattempo – come sta accadendo da noi – i settori protetti continuano a
prosperare.
Noi non vogliamo cadere in questa
trappola. C’è declino solo se non ci sono mete e obiettivi. E
le imprese, ve lo assicuro, hanno ambizioni all’altezza dei compiti e non si
arrendono. Lo dimostrano le tante, meravigliose aziende di successo e di eccellenza di questi tempi.
Ma occorre che tutto il Paese abbia
ambizioni e ritrovi il gusto della sfida. Alziamo lo sguardo verso il futuro. Dove vogliamo essere tra dieci anni?
Dobbiamo riunire il Paese in un
grande spirito di ricostruzione. Non perché ci sia stata una guerra con le sue
distruzioni ma per i guasti causati nel tempo da troppe omissioni.
Dobbiamo ritrovare quell’impegno e quella capacità di fare squadra che ci
hanno consentito di essere oggi tra le nazioni più
ricche e più libere del mondo. E i traguardi raggiunti
non sono mai assicurati per sempre.
In questo disegno possono giocare un
ruolo centrale le imprese e le associazioni che le rappresentano.
Con molte di loro, nell’ultimo anno,
è iniziato un tragitto comune che vuole evidenziare il molto che ci unisce
rispetto al poco che ci divide, puntando in futuro a mettere ancora più insieme
le energie di ciascuno. Sappiamo che i problemi delle imprese sono sempre più
gli stessi, a prescindere dalle dimensioni e dal settore.
Un buon lavoro comune è stato fatto,
anche con i sindacati, sul Mezzogiorno che è ancora molto indietro e risente
dell’apertura mondiale che lo spinge sempre più ai margini dello sviluppo. Per Confindustria il tema del Sud rimane più che mai centrale.
Lo deve essere per tutti, maggioranza e opposizione.
Possiamo fare molto, avviando le
infrastrutture che mancano e investendo nella qualità delle amministrazioni. Puntando, anche per attrarre investimenti, sulla fiscalità di
vantaggio e su strumenti automatici, senza intermediazione politica o amministrativa.
Potenziando un turismo integrato con la cultura, l’industria,
le comunicazioni, le università. Facendo crescere le
imprese meridionali e operando per una loro integrazione con il resto del
paese.
Ma abbiamo anche una frontiera che è
più trasversale e non coincide con quella del Mezzogiorno. È la frontiera che
separa ciò che è lecito da ciò che è criminale. Non possiamo avere alcuna
tolleranza. Non dobbiamo scendere a patti. Ipotesi di amnistie
sono nocive, come l’esperienza anche recente ha mostrato.
Un impegno sempre maggiore nella
lotta alla criminalità e alla corruzione diventa ogni giorno più necessario.
Sappiamo che possiamo contare su forze dell’ordine all’altezza dei compiti. A
loro, così come ai corpi militari, dobbiamo esprimere gratitudine per l’impegno
a tutela della sicurezza in Italia e per le importanti missioni di pace
all’estero.
Da Confindustria
viene un appello forte a intensificare con tutti gli
strumenti la lotta all’evasione fiscale e al sommerso. Non è solo una doverosa
battaglia di civiltà, ma lo strumento per una società più giusta e un’economia
più competitiva.
Le tasse si pagano, come fanno le
imprese, e si devono far pagare. E’ un principio fuori
discussione, ma anche la strada fondamentale per ridurre la pressione fiscale e
quindi il costo del lavoro.
In Italia il tasso regolare di occupazione è il più basso d’Europa. Un numero troppo
esiguo di persone contribuisce alla produzione di vera ricchezza. Nello stesso
tempo abbiamo una dimensione abnorme dell’economia sommersa, soprattutto nel
Mezzogiorno, che alcune stime collocano intorno al 25% del prodotto interno
lordo.
Si tratta di un fenomeno gravissimo,
di una vera emergenza nazionale, nei cui confronti non è più tollerabile alcuna indulgenza. Si tratta di concorrenza sleale, basata
su abusi ed elusioni di legge, che rischia di penalizzare
le imprese sane e corrette che giocano secondo le regole. Si tratta di una
colossale quota di ricchezza sottratta al fisco e alla collettività.
Parliamo di quattro milioni di
persone che operano al di fuori delle regole e che
vanno riconsegnati all’economia trasparente e legale, anche attraverso forme di
flessibilità regolata come quelle previste dalla riforma del mercato del
lavoro. Ne risulterebbe un mercato del lavoro più equo
e coeso e si aprirebbero spazi importanti per abbassare aliquote contributive e
fiscali oggi non più sostenibili.
Occorre ritrovare il senso dello
Stato e delle istituzioni.
Confindustria crede fermamente nel ruolo delle
istituzioni e sa che senza istituzioni credibili e
professionalmente organizzate non è possibile avere un vero libero mercato e un
paese civile.
Le nostre istituzioni sono rette da
una Costituzione che conserva intatto il suo valore. Può richiedere
adeguamenti, ma rappresenta la carta delle regole fondamentali nelle quali
tutti gli italiani devono riconoscersi.
Per questo ho visto con rammarico che
nella passata legislatura sia stata forzata la mano e si sia varata una riforma
approvata solo dalla maggioranza dell’epoca. Per questo vedo con preoccupazione
la nuova spaccatura che rischiamo oggi per un’ulteriore e ancor più profonda
modifica della Carta costituzionale.
In democrazia ogni cittadino deve
sentirsi tutelato, sia che vinca la sua parte sia che
vincano altri. Questa è la condizione fondamentale per avere una reale
possibilità di alternanza alla guida del Paese. E la
tutela del cittadino è affidata alla Costituzione: se essa varia al variare di ogni maggioranza, si perde questa sicurezza.
Possiamo e dobbiamo delegificare, perché tanti atti della nostra vita non necessitano dell’invasione della legge. Nessuno oggi è in
grado di sapere quante sono le leggi vigenti in Italia. Un dato è certo.
Abbiamo un numero di norme clamorosamente superiore agli altri paesi europei.
Vedo con preoccupazione governi ed
enti locali vantarsi di aver varato tante leggi: quasi che il fare leggi significhi automaticamente amministrare bene un paese!
Una volta per tutte, si deve semplificare
l’amministrazione pubblica. E’ un problema strutturale che, da troppi anni,
condiziona massicciamente la competitività del nostro paese.
Dobbiamo evitare che un malinteso
concetto di spoil system nelle amministrazioni
pubbliche generi dirigenti legati più ai politici che li hanno nominati che al
servizio dei cittadini che di fatto li remunerano.
Dobbiamo mettere con convinzione meritocrazia e produttività al centro delle
carriere del servizio pubblico.
Basta con contratti i cui rinnovi costano sacrifici alle finanze pubbliche senza
migliorare i servizi resi.
Occorre anche superare la logica del
distruggere prima tutto quello che ha fatto il Governo precedente e poi avviare
il proprio programma. I tempi della politica e quelli dell’economia corrono
rapidamente. Se si perde tempo a distruggere, non ci
sarà poi il tempo per costruire.
Basta con riforme
tese solo a cambiare il nome del Ministro che le propone. Basta con le scuse sulle eredità
lasciate dalle amministrazioni precedenti. E questo
vale per ieri, oggi e domani.
Ci vuole una sana amministrazione che
costruisca su quello che esiste e che dia il senso
della stabilità e della continuità. Anche così si
legittima un sistema bipolare. E bisogna superare
questa mania di spezzettare il Paese e di creare nuove e pesanti
amministrazioni con la pretesa di avvicinarsi al cittadino.
Delegificare e semplificare non significa creare
altre amministrazioni. Al contrario: dovrebbe significare abolirne alcune. E invece vediamo crescere il numero delle province. Vediamo
sopravvivere comuni di dimensioni ridicole.
Si pone in modo urgente il problema
della governance istituzionale. A
partire dalla chiarezza del rapporto tra amministrazioni centrali ed
enti locali. Regioni, province e comuni hanno ampliato la sfera delle competenze ma non hanno interpretato finora in maniera
significativa un principio di sussidiarietà
verticale, né si è consolidata la modalità di raccordo con il centro e le sue
attribuzioni.
Confindustria è contraria alle confusioni, alle
sovrapposizioni e alla moltiplicazione dei costi, delle procedure e dei
dipendenti.
Soprattutto in momenti difficili come
questi, le imprese si sentono parte integrante di questo paese: sono cittadine
dell’Italia, nel senso che contribuiscono alla sua crescita economica e civile.
Non voglio qui rivendicarne meriti e
risultati, che sono evidenti a tutti. Voglio invece sottolineare
la nostra volontà di partecipare, attivamente e senza invasioni di campo, alla
costruzione di un progetto Paese, oggi più che mai necessario. E’ un ruolo che
ci siamo conquistati nel tempo.
L’Italia ha sempre avuto nella
capacità di stare sui mercati esteri il suo punto di forza. E
anche qui le cose non vanno bene. Negli ultimi dieci anni la quota di mercato a
prezzi costanti delle esportazioni italiane su quelle mondiali si è ridotta di
un punto (dal 4,8 al 3,8%), mentre Francia e Germania hanno rispettivamente
mantenuto e aumentato il loro peso, pur avendo l’euro come noi.
E come sappiamo, altrettanto
preoccupante è la capacità sempre minore di attrarre investimenti stranieri in
Italia. Un problema che chiama in causa fattori strutturali diversi, tutti
riconducibili all’efficienza e alla competitività del nostro sistema paese:
dalle infrastrutture al costo del lavoro, dai tempi della giustizia civile al
carico fiscale, normativo e burocratico che non ha eguali nel mondo
occidentale.
L’Italia è negli ultimi anni stabilmente
dietro non solo a Francia, Germania e Gran Bretagna, ma anche alla Spagna come
paese destinatario di investimenti diretti esteri.
Le imprese italiane vogliono
rispondere alle sfide internazionali con la loro capacità di innovazione.
La ricerca e l’innovazione sono la molla del progresso. Sono anche grande
fonte di rischio. Lo sappiamo bene noi imprenditori, quando ci
imbarchiamo in progetti nuovi e quando tentiamo strade che altri non
hanno ancora percorso. Ma la capacità di rischiare è
l’elemento che caratterizza il vero imprenditore.
Se non c’è rischio non c’è neppure innovazione. Per contenere il rischio le aziende
possono utilizzare istituzioni finanziarie che sappiano
valutare e condividere i nuovi progetti: i fondi di private equity,
il venture capital, la Borsa.
Da noi questi strumenti sono ancora
troppo deboli anche perché il sistema fiscale non li favorisce. In ogni caso,
da soli non possono bastare.
Abbiamo in Italia un tasso
tecnologico troppo basso. Abbiamo bisogno di aumentare il contenuto tecnologico
e di innovazione dei nostri prodotti così da essere
meno esposti all’imitazione, alla contraffazione, alla pura competizione sui
prezzi.
E’ un compito nel quale le nostre
piccole e medie imprese non possono essere lasciate sole. Per questo si deve incentivare la cooperazione tra università, impresa e
strutture pubbliche in modo da realizzare veri e propri parchi tecnologici di
ricerca industriale. Parlo di realtà che possono costituire l’autentico
strumento di innovazione e di evoluzione del sistema
industriale.
E’ bene su questo dire le cose come
stanno. L’industria è la colonna portante della nostra economia, ma da troppo
tempo è stata trascurata, quasi dimenticata, se non addirittura contrastata. E oggi se ne pagano le conseguenze.
Dobbiamo fermare questa deriva vicina
al masochismo. Mettiamo l’industria al centro per dare slancio a un "nuovo manifatturiero" più globale, più
specializzato, più tecnologico.
Importante è anche una buona legge
fallimentare che circoscriva le responsabilità
dell’imprenditore che è fallito, magari perché cercava di innovare. Se il rischio è la base dell’innovazione, il fallimento non
doloso non può essere una condanna a vita.
L’Italia non ha oggi una buona legge
sul fallimento: la delega approvata nelle scorse settimane dal Parlamento può
essere un’occasione importante. Non deve andare sprecata.
Signore e Signori,
non è più tempo di rinvii. L’
"emergenza economia" impone di agire. I dati congiunturali sono da tempo negativi e l’OCSE parla di Italia in recessione.
Centri di analisi nazionali, istituzioni
internazionali e stampa mondiale fanno ogni giorno a gara a descrivere le
nostre difficoltà.
Forse ce lo
siamo in gran parte meritato. Ma intanto la retorica
del declino avanza.
I dati purtroppo sono
veri e ogni giorno peggiorano. Non sono né di destra né di sinistra. Ma anche il tempo dell’analisi si è esaurito. Colpe
esistono, tuttavia adesso è importante reagire perché nessun male oscuro
condanna l’Italia.
Già altre volte ci siamo
trovati in condizioni molto difficili e siamo sempre riusciti a invertire la
rotta. La chiave della nostra salvezza non è il fatidico stellone. E’ il senso
di responsabilità degli italiani, è la forza di reazione del nostro
straordinario patrimonio di imprese, è la capacità di
guida della politica che a volte riemerge.
Mai come oggi abbiamo bisogno di una
politica alta, che assuma responsabilità, prenda decisioni e non si smarrisca
in defatiganti dispute sul perimetro degli schieramenti, sia nel centrodestra che nel centrosinistra.
E’ proprio nei momenti difficili che
si genera la capacità politica di fare scelte coraggiose. In questi casi il
consenso segue e non precede le azioni. Non si possono accontentare tutti: lo
diciamo al governo e alla maggioranza di fronte alle scelte di queste ore in
materia economica e fiscale.
A maggioranza e opposizione dico: togliete la testa dalle urne elettorali. Fate scelte
di rigore orientate allo sviluppo e alla competitività
internazionale che sono le chiavi del nostro futuro.
Come cittadini
prima, e come imprenditori poi, giudicheremo le scelte di chi si è
assunto l’onere e l’onore di governare, ma anche il senso di responsabilità
dell’opposizione di fronte alla gravità e all’urgenza dei problemi.
Dobbiamo agire in fretta senza
l’ansia di vedere subito i risultati, operando per il bene del Paese. Dobbiamo
avere il futuro come scenario per le nostre ambizioni e il presente per
scegliere strumenti e azioni.
Dobbiamo scommettere molto di più sui
giovani, nella società come nelle aziende.
Il corpo sociale del paese è sano. La
coscienza civica degli italiani è solida, ma a volte stenta a manifestarsi,
frustrata com’è dai troppi comportamenti furbeschi che i
media ci riportano ogni giorno come vincenti. Abbiamo bisogno che esploda una coscienza civica diffusa.
Abbiamo un patrimonio di imprese che desta ancora invidia nel mondo. Siamo, tra i
paesi industriali, quello dove il manifatturiero conta di più rispetto agli
altri settori. In tutti i continenti veleggiano le nostre caravelle: medie imprese
globali che operano su segmenti di mercato di alta
gamma e specializzazione. I nomi italiani sono presenti in tutti gli angoli del
pianeta e testimoniano del nostro saper fare.
Certo, le nostre
imprese globali
sono ancora troppo poche. Manchiamo di grandi gruppi. Abbiamo un settore dei
servizi in gran parte asfittico e ancora troppo protetto. Abbiamo un contesto esterno alle imprese inefficiente. Abbiamo una
pericolosa predisposizione alla burocrazia. Insomma, abbiamo un sacco di cose
da fare. E’ arrivato il momento di farle.
Sta qui il senso della ricostruzione.
Tocca alle forze migliori e più responsabili, tocca alla maggioranza e
all’opposizione impegnarsi su cinque grandi fronti che richiedono interventi
strutturali su cui ci giochiamo le nostre prospettive: scuola e sistema
educativo, ricerca e innovazione, infrastrutture, concorrenza, semplificazione
burocratica.
Io sogno un paese con più
innovazione, più concorrenza, più solidarietà.
Un paese con una
forte etica del mercato e un’altrettanto forte etica del profitto.
Per ricostruire l’Italia ci vuole una
guida politica e istituzionale, una classe politica con ambizioni di futuro e
competenze elevate, con grande senso dello Stato. Per
classe politica non intendo solo i partiti, ma anche le istituzioni, i corpi
sociali, il mondo delle associazioni, le imprese e tutti coloro
che non limitano il proprio agire al mero conseguimento di una pur legittima
soddisfazione personale.
Questa è la classe dirigente di cui
abbiamo bisogno. Una classe dirigente che temo, oggi, non si renda
conto della drammatica situazione non solo dei conti pubblici ma, purtroppo,
soprattutto dell’economia reale. E che invece deve avere chiara questa
consapevolezza per compiere insieme le scelte nell’interesse dell’Italia di oggi e di domani.
Una classe
dirigente che oggi ha di fronte una sfida ardua ma esaltante e che attorno a
questa sfida sappia riscrivere un autentico patto fra i cittadini. Il patto fra tutti coloro che hanno a cuore il futuro del Paese.
L’Italia merita un futuro di qualità,
orientato alla crescita e allo sviluppo. E’ il futuro dei nostri figli e delle nostre imprese. Ma è soprattutto il
futuro del nostro paese, della nostra patria.
Riprendiamo slancio e coraggio.
Sappiamo cosa dobbiamo fare. La
rivincita dell’Italia è possibile.