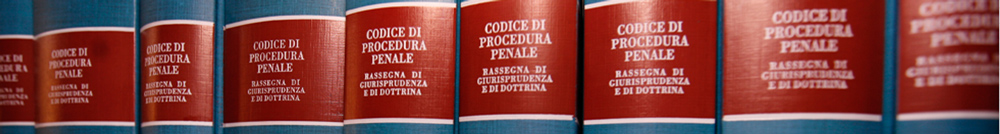Banca Dati
Dimissioni. La minaccia di far valere un diritto invalida le dimissioni solo se determina un vantaggio ingiusto a danno del lavoratore.
La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato, soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall’oggetto di quest’ultimo. Consegue che le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di far valere un diritto sono annullabili per violenza morale solo qualora venga accertata, con onere probatorio a carico del lavoratore che deduce l’invalidità dell’atto di dimissioni , l’inesistenza dell’invocato diritto del datore di lavoro.
Così stabilito dalla Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 4006, pubblicata il 15 febbraio 2017.
La vicenda: domanda di lavoratore diretta ad ottenere l’annullamento delle dimissioni rassegnate e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro.
Un lavoratore bancario agiva in giudizio al fine di far dichiarare l’annullamento delle dimissioni rassegnate sotto coercizione morale, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento danni. Il Tribunale adito rigettava la domanda. Proposto appello da parte del lavoratore, la Corte di merito lo rigettava, confermando la decisione di primo grado. Ricorreva allora in Cassazione il lavoratore.
Il carattere della minaccia di far valere un diritto
Il ricorrente si duole che la corte territoriale non abbia nel complesso ritenuto sussistere il carattere della violenza morale, per essere state le dimissioni estorte con minaccia di far valere un proprio diritto. Afferma infatti il lavoratore che la banca lo avrebbe minacciato di agire in via esecutiva nei confronti della figlia, al fine di recuperare l’esposizione debitoria di quest’ultima verso l’istituto di credito. Ottenendo in tale modo il duplice vantaggio di recuperare il credito, compensandolo con le retribuzioni dovute per la cessazione del rapporto di lavoro e contestualmente ottenendo il vantaggio di liberarsi di un lavoratore ormai scomodo.
Il Supremo Collegio ribadisce prima di tutto il principio di diritto sulla questione invocata dal ricorrente, secondo cui la minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, cioè quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall’oggetto di quest’ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall’ordinamento.
Onere della prova a carico del lavoratore
Così inquadrato il principio di diritto, va affermato che affinchè le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di far valere un diritto possano annullarsi per violenza morale, occorre che venga accertata, con onere probatorio a carico del lavoratore che deduce l’invalidità dell’atto di dimissioni , l’inesistenza dell’invocato diritto del datore di lavoro. Nel caso specifico il collegio di merito non ha ritenuto raggiunta tale prova gravante sul lavoratore ricorrente. E d’altro canto, l’azione prospettata dalla banca era la legittima azione esecutiva da promuoversi nei confronti della figlia del dipendente, volta ad ottenere il recupero coattivo dei crediti vantati nei confronti di quest’ultima.
Nuova causa petendi inammissibile in appello
Peraltro le allegazioni e le argomentazioni portate dal lavoratore, circa l’asserita coercizione della volontà di rassegnare le dimissioni vennero introdotte soltanto in sede di gravame. Costituendo tali difese vere e proprie domande nuove, comportanti la modificazione della causa petendi originariamente introdotta, deriva l’inammissibilità delle nuove domande. Inammissibilità correttamente affermata dalla corte d’appello nella sentenza impugnata. Le ulteriori argomentazioni tempestivamente proposte in primo grado sono rimaste sfornite di adeguato supporto probatorio.
In conclusione, il ricorso proposto è stato ritenuto infondato nel suo intero complesso e conseguentemente rigettato.
(Avv. Roberto Dulio, pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)